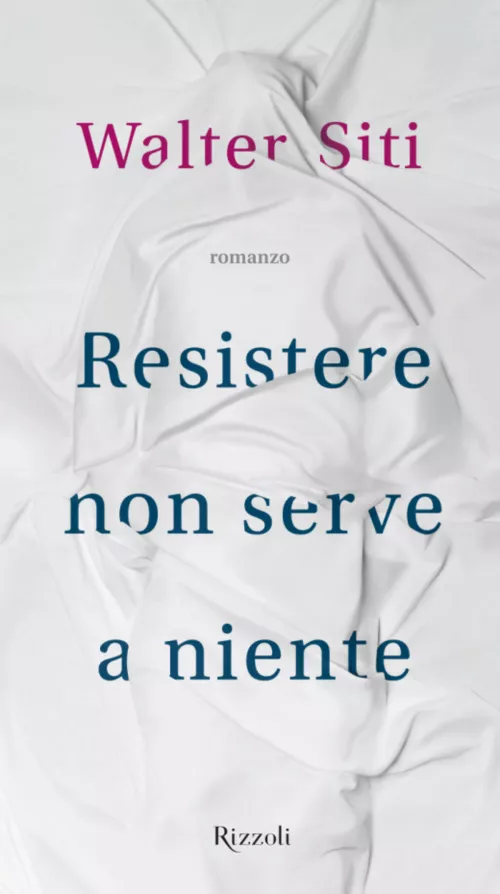Futile
Please allow me to introduce myself
I’m a man of wealth and taste
…
Pleased to meet you
Hope you guessed my name,
But what’s puzzling you
Is the nature of my game
…
Rolling Stones, Sympathy for the Devil
Certo non inventava niente Walter Siti nel teorizzare, e ampiamente praticare, un “io sperimentale” quale narratore, punto di vista focalizzante e protagonista indiscusso dei suoi primi romanzi. Si ricorderà come già Italo Svevo, a proposito del suo Zeno, scrivesse a un ammirato Montale: “pensi ch’è un’autobiografia e non la mia”. Ma, se si avvicina al vero quanto sostiene (esagerando) il Daniele Giglioli di Senza trauma (Quodlibet 2011) – che proprio quella che è invalso definire autofiction, insieme al noir “politico”, sia il genere egemone della narrativa italiana degli ultimi anni – ciò si deve principalmente a lui. All’esemplarità cioè che – presso i narratori più giovani, unico termometro fededegno d’autorevolezza quando i media guardano solo alle classifiche di vendita – s’è conquistato Siti, non tanto con l’esordiale e straripante Scuola di nudo (Einaudi 1994), quanto con la serie in apparenza compatta costituita da Troppi paradisi (ivi 2005), Il contagio (Mondadori 2008) e Autopsia dell’ossessione (ivi 2010; opere, in realtà, fra loro assai diverse e per certi versi l’una in polemica con l’altra; è vero infatti quanto gli viene rimproverato – che Siti scrive tanto, forse troppo – ma altrettanto vero è che gli addendi di questa serie tutt’altro che seriali risultano a una lettura ravvicinata).
Che rispetto a questo ciclo (o pseudo-ciclo) Resistere non serve a niente segni una decisa soluzione di continuità lo dice lo stesso Siti. Persino con brutalità. Nella prima pagina della narrazione (dopo due cornici iniziali): “La condanna di Antonio Franchini (l’editor della Mondadori) a proposito del mio ultimo” – Autopsia dell’ossessione appunto, pubblicato dalla SIS in stagione punitiva e col minimo sindacale di tiratura – “era stata esplicita, lapidaria nella sua rozzezza: “sei tornato a scrivere un libro per froci”. Così m’ero proposto di non deludere più nessuno, avrei espulso l’erotismo omosessuale dal mio orizzonte letterario”. Naturalmente l’affermazione appena citata – lo ha scritto Marco Belpoliti su L’Espresso – ha il valore di una negazione, in senso freudiano; ma è invece genuina quale presa di distanze dalla propria tradizione. Cioè appunto dall’interrogazione dell’io sperimentale quale fine (e insieme mezzo) dell’opera. Se è frocio, in termini non denotativi ma metaletterari, un libro il cui unico personaggio che conti si riveli quello con le fattezze del proprio autore (un testo omodiegetico, cioè, per dirla col gergo narratologico; e, aggiungo, omofocalizzato), viceversa sarà eterosessuale (cioè eterofocalizzato) un testo in cui il personaggio che conta è un altro. Cioè un personaggio “vero”, tridimensionale – round, “tondo”, come lo definiva l’Edward M. Forster di Aspetti del romanzo (in contrapposizione a quelli flat, “piatti”, stereotipicamente bidimensionali). E sarà, si può aggiungere, un vero romanzo quello che ruota attorno al centro di gravitazione d’un simile personaggio. Mentre altra cosa – seppur splendida – erano da considerarsi i testi precedenti.
Ed è allora davvero Resistere non serve a niente il primo, “vero” romanzo di Siti. Tale mi era potuto apparire, per la verità, già il precedente Autopsia dell’ossessione (rinvio a quanto scritto sul “Caffè illustrato”, 57, novembre-dicembre 2010): nel quale uno dei passi saggistici metanarrativi che vi intercorrevano diceva che “Il grande nemico dell’ossessione è mettersi nei panni dell’ossessionante; per questo l’ossessione, pur essendo una storia, è il contrario del romanzo” (p. 209). Materia prima di Autopsia dell’ossessione era appunto, almeno in apparenza, il mettersi nei panni dell’ossessionante rivale (nella passione per il culturista marchettaro Angelo): la bravura di Siti consisteva in quel caso nel condurre l’intero testo da quel punto di vista senza però poter evitare, né voler dissimulare, il rispecchiamento dei rivali l’uno negli occhi dell’altro. Danilo Pulvirenti, l’antiquario fanatico protagonista di Autopsia dell’ossessione, si rivelava così un vero e proprio doppelgänger del “professore bavoso” (p. 203) che l’aveva fatta da protagonista nei libri precedenti (non senza tornare tale, a tradimento, nell’ambiguo lieto fine appiccicato a forza allo scenario fosco e delirante che lo aveva preceduto). Allo stesso modo, della “pseudotrilogia” dell’io sperimentale, Autopsia si rivela specchio rovesciato; un’abiura che dissimula una variazione sul tema. Un gioco di prestigio, insomma.
Resistere non serve a niente fa un passo ulteriore. Il protagonista indiscusso, il “feroce bankster” (come si autopresenta a p. 26) Tommaso Aricò – proveniente da un ambiente degradato che pare uscito dagli scenari del Contagio, e oltretutto omonimo del protagonista di Una vita violenta di Pasolini – che giovanissimo accumula una fortuna smisurata grazie ai micidiali hedge funds e ad altri non meno mortiferi paraphernalia finanziari, non è semplicemente un doppio, una maschera, una proiezione dell’autore. Non mancano neppure qui, si capisce, giochi di specchi fra lui e chi dice “io” (e che alla fine, 316, viene chiamato “Walter Siti”): le psicologie dei due, nello studiarsi con attenzione, tendono sempre più a commisurarsi l’una all’altra (“Eccoci ancora di fronte, sempre più simili l’uno all’altro ma diversi da come eravamo partiti”, 311). Ma ciò non toglie che Tommaso resti, dall’inizio alla fine, un “vero” personaggio. Non è solo perché ha conosciuto la “prigione mobile” (103) dell’obesità, insomma, che è un personaggio “tondo” secondo la dicotomia di Forster. Il quale ne indicava un esempio nella Becky Sharp della Fiera delle vanità di William Thackeray: arrampicatrice sociale che sempre resta, anche all’apice del successo, dolorosamente consapevole del fango da cui proviene (“l’unica cosa che gli importa”, si dice di Tommaso, “è mettere più cielo possibile tra il sole del futuro e le proprie radici avvelenate, analfabete”: 90). Glielo dice in faccia, l’autore al personaggio: “M’ero programmato un Thackeray e mi ritrovo tra le mani un Philip Roth, se va bene…” (168). Mentre, infatti, Thackeray entra direttamente nella testa di Becky, come l’ottocentesco narratore onnisciente che è (differente però la strategia dello stesso autore in Barry Lyndon, in cui è il protagonista a narrare la propria parabola), il narratore del 2012 in un simile ruolo si trova comprensibilmente a malpartito (“onnisciente sarebbe solo Dio, se esistesse”, commenta a p. 50), e sebbene annunci il proprio “ritiro” dalla scena della narrazione non se ne allontanerà mai del tutto: tornando a farvi capolino in più d’un’occasione e in effetti continuando a svolgervi, dall’inizio alla fine, quanto meno il ruolo di “microfono” del Marlowe di Conrad (o dello Zuckerman di Roth, appunto).
Ciò non toglie che Tommaso riesca, proprio come quelli di Thackeray, un personaggio irresistibile. Non serve a niente resistere, infatti, ai “ganci” per l’immedesimazione, agli ami per il lettore che Siti a profusione dissemina nel costruirlo: la furia di riscatto (dalla catastrofe sociale di partenza – il padre è un killer della mafia carcerato da una vita – ma anche dall’handicap corporeo dell’obesità), il talento inspiegabile e appunto irresistibile (è un personaggio che conta anche perché dispone di un genio illimitato nella matematica), il cinismo strafottente (e dunque simpaticissimo), la neppure troppo segreta vena nichilistica (“il progetto che affascinava Tommaso era quello di distruggere il mondo”, 228, e si pensa proprio alla conclusione della Coscienza di Zeno quando, a p. 234, si parla di “un libro-ordigno”) dipingono una figura, oltre che memorabile, appunto straordinariamente coinvolgente. Il miracolo di Siti – luciferino miracolo – consiste però nel farci appassionare così tanto a un personaggio che nel corso della narrazione si rivela – assai più del Pulvirenti di Autopsia dell’ossessione – un vero demone. Una figura del Male, cioè.
Un personaggio “tondo”, dice Forster, si riconosce perché “cresce e cala e ha sfaccettature come gli esseri umani” (1927, trad. it. Garzanti 1991, p. 78). Si modifica, cioè, davanti ai nostri occhi mentre leggiamo: mentre la sua vita ficta si snoda nella narrazione. Ed è esattamente quanto succede a Tommaso in Resistere non serve a niente. Il romanzo prevede, infatti, non uno ma due snodi (o, avrebbe detto Henry James, due giri di vite) che, del personaggio in questione, mutano profondamente la natura. Nel capitolo programmaticamente intitolato “Il patto cambia”, si viene infatti a sapere che Tommaso, nel mondo astratto e immateriale della mega-finanza sul quale surfa in modo impareggiabile, non è solo il più spregiudicato fra coloro che si muovono nella zona grigia tra legalità e illegalità; ben al di là di questo ci sono i capitali mafiosi che in realtà – veniamo a sapere – usano questo suo talento come proprio strumento. Al narratore confessa infatti (225): “se arrivo prima su certe informazioni non è perché sono così bravo… sono anche bravo, ma ho sempre potuto contare su un aiutino. […] Da parte di gente che le cose le può anche modificare… sanno quello che succederà perché lo fanno succedere loro…”. Zuckerman-Siti gli chiede allora: “Stai dicendomi che sei sostenuto, o addirittura fai parte di una associazione criminale?”. E Tommaso gli risponde divertito: “Questo ti farebbe orrore?”. La domanda è ovviamente retorica; se Tommaso attrae il narratore è proprio perché si muove in quella zona grigia. Ed era difficile non nutrire anche prima il sospetto che la linea d’ombra del crimine, Tommaso, l’avesse da tempo attraversata (i due all’inizio, nello stringere il loro patto irridendo compiaciuti i moralismi e le ipocrisie dei “fighetti di sinistra”, si complimentano a vicenda: “‘È intelligente’: lo pensiamo l’uno dell’altro ed è l’alibi di entrambi”, 46): “Se tu non mi avessi già giudicato” – e dunque implicitamente assolto, osserva Tommaso – “non ti saresti spinto così avanti” (225). Infatti il capitolo seguente, il cui titolo parafrasa il passo evangelico posto da Leopardi in esergo alla Ginestra (“Gli uomini preferiscono le tenebre”), porta Zuckerman-Siti a diretto contatto con un capomafia, Morgan Lucchese, che di Tommaso è più o meno coetaneo e strutturalmente è in sostanza un suo doppio, solo più esplicito e privo di sfumature: il che consente all’autore di esplorare nei dettagli anche tecnici il bicefalo sistema finanziario-criminale che fa da sfondo al romanzo (con tanto di doppio grafico, alle pp. 274-5, dell’architettura dei clan di Cosa Nostra a specchio di quella delle “banche depositarie” più o meno off shore – citate sono anche Barclays, Morgan Stanley, Unicredit…).
È questo il tratto “savianesco” del libro (il nome di Roberto Saviano, sul quale in passato Siti ha scritto pagine di grande intelligenza, figura tra i ringraziamenti): il corpo contenutistico che furbescamente gli ha conquistato una sorprendente visibilità mediatica (con tanto di comparsata televisiva da Fabio Fazio). Ma la sua reale sostanza è ben altra. E infatti pressoché opposta funzione a quella che ha in Gomorra, a ben vedere, ha in Resistere non serve a niente la stessa presenza “viva” e non stereotipata della criminalità. Se qualche lettore intelligente (e non troppo benevolo) di Saviano ha potuto osservare che la plasticità e la vividezza della sua rappresentazione di quel mondo si deve anche alla sua omogeneità antropologica con esso, e all’ambigua attrazione di cui si venano la sua esecrazione e la sua denuncia (attrazione con ogni probabilità contraccambiata da chi per ritorsione lo ha condannato a morte), non si può immaginare antropologia più distante di questa, invece, dall’esperienza di un Siti cresciuto – come insegna Scuola di nudo – entro la serra protetta e soffocante della Scuola Normale di Pisa. È proprio questa distanza ad attrarlo: e a fargli desiderare così tanto, come già nei confronti del mondo borgataro dei libri precedenti, di esporsi al suo contagio. Solo che, a fronte del capitale simbolico (e non solo) mobilitato dall’universo orrendo di Morgan Lucchese, il piccolo spaccio del quartierino e la marchetteria borgatara del libro che al Contagio s’intitola sono spiccioli d’abiezione, argent de poche dello scandalo.
Ma soprattutto, come si diceva, la prospettiva di Siti è simmetricamente inversa a quella di Saviano: ammesso che in questi vi sia, un’attrazione segreta per l’oggetto della propria esecrazione, quella di Gomorra è per l’appunto un’esecrazione. Che infatti si struttura (non solo retoricamente, come dimostrano le successive conseguenze) come una denuncia. Simmetricamente inverso, Resistere non serve a niente sotto l’apparenza di una denuncia (come è stata presa dalla ricezione mediatica di cui sopra, in qualche modo incoraggiata da ipocrite dichiarazioni pubbliche dell’autore) ha invece proprio l’attrazione, quale sua reale molla conoscitiva.
Un’attrazione, del resto, tutt’altro che segreta. Dal momento che sin dall’inizio il rapporto fra chi scrive e chi viene scritto si presenta come scambio di favori: Tommaso risolve il cruccio abitativo dello scrittore sfrattato (acquistando l’immobile in cui risiede), “e io in cambio scriverò un libro sulla sua vita (‘devi dirmelo tu chi sono’)” (49) non esente da un certo ammiccamento da spin doctor (“pensa piuttosto a combinare qualcosa di glamour che renda giustizia alla nostra categoria”, incita Tommaso il suo beneficiato cliens, “…sono stufo di quelle robe americane che ci fanno sembrare tutti degli isterici”, 50). Ma nel momento in cui “il patto cambia” si fa evidente che una tale “complicità può non essere simbolica” (si dice “Walter” a p. 215). Se fino a quel momento la complicità del narratore-portavoce era infatti coi provocatori disvalori di un simpatico avventuriero, un immoralista in sedicesimo del quale ritrarre, a contorni neppure troppo acidi, l’irresistibile ascesa come un Hogarth del ventunesimo secolo, ora i giochi cominciano a farsi seri. Quel che più interessa, dal punto di vista strutturale, è che se il personaggio di Tommaso, come detto, si modifica – avvitandosi verso il peggio – non si modifica, di contro, l’atteggiamento del narratore nei suoi confronti. La presenza scenica di “Walter”, anzi, da questo momento in avanti si intensifica. E non certo per contrastare le idee e i comportamenti di Tommaso. È questa la sua vera complicità. La simpatia e l’immedesimazione che eravamo pronti a concedere al Barry Lyndon della finanziarizzazione, in una sorta di scivolamento progressivo e costante, siamo ora indotti a provarla anche per il quaquaraquà di Cosa nostra, il consigliori dei corleonesi, l’Harry Potter delle cosche. E poi, ancora oltre.
Difatti ho parlato di un secondo giro di vite. Che ci porta in un territorio estraneo alla cronaca finanziaria nonché alla cronaca nera; ma più in generale estraneo ai ritmi, ai linguaggi, alle temperature della cronaca tout court. Un territorio di pertinenza della letteratura, invece: forse ancor più che della filosofia che, pure, tanto lo ha indagato. È nel territorio del Diavolo che entriamo, nella dimensione del Male (nella “Nota al testo” conclusiva, Siti ammette ma non spiega: “La mia fascinazione per il male è oscura anche a me stesso”, si limita a osservare a p. 319). Sempre nel capitolo-chiave, “Il patto cambia”, “Walter” si trova nella necessità di far visita al luogo-simbolo d’aggregazione di coloro che oggi si oppongono allo stato di cose esistente: il Teatro Valle occupato, a Roma. Senza neppure uno dei commenti che ci attenderemmo, il suo occhio percorre “gli eterni look da okkupazione”, descrive gli striscioni e gli slogan, annovera le presenze inevitabili del “vecchio Bifo”, della Guzzanti, di Monicelli (in effigie), di Concita De Gregorio Lidia Ravera Teledurruti gli attori politicizzati e insomma tutto il radicalscicchismo in precedenza acutamente irriso e moralmente disintegrato. Poi però, al momento di uscire, si imbatte “in una specie di clown, non capisco se maschio o femmina”, il quale “alza le dita a V, le guance e le sopracciglia impiastricciate di glitter” e gli dice “hasta la victoria siempre”. Al che il narratore commenta, a sintesi di quanto pensa di quel luogo e di ciò che rappresenta: “Come no? E la bellezza salverà il mondo” (224). La frase, si sa, è quella attribuita al Principe Myškin nell’Idiota, e nella cultura postmoderna – al netto dell’ambiguità di Dostoevskij, com’è ovvio, qui invece ripresa e accentuata sino allo scherno dall’esibita carnevalizzazione – rimbalzata ossessivamente, nei contesti più diversi (sino a figurare tatuata sul braccio del tennista serbo Janko Tipsarević, per ciò stesso appellato “filosofo” dai colleghi dell’ATP), come slogan consolatorio, generico e, dunque, semanticamente vuoto.
Il sarcasmo sferzante col quale viene ripetuta dal narratore è la sintesi, in epitome, dell’atteggiamento anti-virtuistico e immoralistico di Siti, dei suoi intenti da “demoralizzatore totale” (come una volta si definì James G. Ballard). Quella che si condensa con aforisma memorabile nel titolo Resistere non serve a niente, insomma, non è l’ideologia solo di Tommaso, o di Morgan. “Il lato oscuro della globalizzazione” (216) – quello in cui, con un altro dei micidiali aforismi che scandiscono il testo, “le vittime sono invidiose dei carnefici”, 282 – viene presentato come qualcosa cui non ha senso opporre resistenza, appunto, perché iscritto nella natura delle cose. E infatti nei discorsi diretti dei personaggi viene illustrato con metafore prese dalle scienze naturali (“la finanza mondiale è irresistibile come la marea e noi dobbiamo essere la Luna”, dice Morgan a p. 240; Tommaso parla di “calamità naturali, terremoti e tsunami”, 219). Le stesse usate però dalle parole del narratore, che per lunghi tratti del resto parafrasa senza virgolette quelle dei personaggi. Per esempio a p. 217: “la pretesa di mettere sotto controllo la speculazione babelica e apolide è come voler mettere sotto controllo la rotazione terrestre”. Un sottile quanto insidioso scivolamento mimetico fa sì, dunque, che la medesima metaforologia “naturale” si ritrovi anche nelle parole direttamente pronunciate dal narratore (il quale per esempio definisce la situazione finanziaria una “slavina generalizzata” a p. 153), laddove non si trova a parafrasare alcunché.
S’è detto che il narratore si fa strumento di Tommaso (al modo in cui Tommaso, come s’è visto, si rivela strumento di Cosa nostra) “ai limiti del favoreggiamento e oltre”. Tanto è vero che, proprio qui, egli si autodefinisce “un utensile dismesso” (243). Ma il modo in cui si fa strada nel testo l’ideologia dell’autore, per gradi e insensibilmente, suggerisce come a essere vero sia – piuttosto – il contrario. È l’oltranza provocatoria degli atteggiamenti e degli statements di Tommaso a consentire a Siti di prendere posizioni, ed esprimere giudizi, in modi sconosciuti ai suoi libri precedenti (che se “scandalizzavano” era proprio per la compiaciuta epochè praticata dall’autore sulla materia trattata: “Il mio destino è osservare la vita”, diceva Troppi paradisi a p. 57, “non sono fatto per intervenire o per schierami. Dimenticare, glissare, saltare”). Verso la fine, invece, il narratore di Resistere non serve a niente si rivolge al personaggio in questi termini: “forse sei il mio stunt-man, quello che esegue per me le scene pericolose… un prototipo della mutazione… o forse, più in profondità, sei il mio vendicatore” (a p. 314).
Più d’una volta (per esempio a p. 42, a p. 49, a p. 167) Tommaso viene paragonato a un alieno, un extraterrestre. E, in effetti, il titolo del romanzo di Siti ricorda irresistibilmente, è il caso di dire, la frase-slogan dei Borg, gli arci-nemici appunto alieni dell’equipaggio dell’Enterprise nella seconda serie di Star Trek (1987-94; la prima serie si trova citata, en passant, in Troppi paradisi a p. 9): Resistance is futile (slogan che scopro essersi poi ampiamente diffuso nella cultura pop contemporanea). È almeno in apparenza su un supporto differente dall’io sperimentale d’antan, insomma, che Siti ha voluto sperimentare un innesto di quelli acrobatici, davvero transgenici: quello di un’ideologia aliena, in quanto tale disumana, su una psicologia umana, troppo umana (e infatti irresistibilmente coinvolgente). Del resto il narratore lo confessa, rivolgendosi sempre a Tommaso: “sento fraterno chi si mette fuori dall’umano, come se fuori dall’umano ci fosse qualcosa… può darsi che tu abbia scelto l’evangelista sbagliato” (170). Che Siti abbia sempre avuto nostalgia di una dimensione extra-umana della quale sognarsi partecipi (o dalla quale sospettare di provenire) lo dice la quantità di riferimenti alla mitologia gnostica cosparsi nei suoi libri precedenti; ma qui, blasfemo, aggiunge la dimensione cristologica (meta-umana, appunto). Seppure in modo deforme e imperfetto, e in forma di parziale preterizione, egli si presenta qui, infatti, niente meno che come l’evangelista di Tommaso (suo il nome, fra l’altro, dell’autore del più conosciuto dei vangeli gnostici): proprio al modo in cui, con ambiguità tormentosa, Dostoevskij si presentava quale evangelista del nuovo Cristo – Myškin, appunto.
Ma come quello a Saviano (si parva licet) anche il riferimento a Dostoevskij di Siti è perverso, infido, profondamente traditore. Perché mentre l’invenzione di Myškin rappresentava una provocazione in quanto Dostoevskij aveva preteso di farne l’“uomo assolutamente buono” (come scrisse alla nipote Sonija Ivanova), l’adesione di Siti ai valori di Tommaso è provocatoria in quanto egli incarna, al contrario, l’assolutamente cattivo. Non certo in quanto speculatore finanziario, e neppure perché complice della mafia. Parlavo prima, infatti, di un secondo giro di vite narrativo, che sposta ulteriormente in avanti (se così si può dire) l’asse morale di Resistere non serve a niente. Un giro di vite che si colloca nelle ultime trenta pagine del testo e che si consuma, dunque, davvero a tradimento: quando il lettore s’è cioè abituato a concedere a Tommaso, se non l’adesione incondizionata della prima parte, almeno l’ambigua attrazione della seconda.
I suoi lettori sanno come il più lacerante emblema del Male sia rappresentato, per Dostoevskij, dalla sofferenza dei bambini (c’è anche, sul tema, una ricca monografia italiana recente: Angeli sigillati di Antonina Nocera, Franco Angeli 2010). Dal primo romanzo, Povera gente, sino alla disputa fra Ivan e Aleša Karamazov nell’opera ultima, è questo enigma a sostanziare la sua implacabile interrogazione metafisica. E non è un caso che tanto spesso ricorrano, nei suoi intrecci, le violenze inflitte all’infanzia incolpevole – soprattutto nella forma più spregevole, quella dell’insidia sessuale. Come ha fatto notare il giovane George Steiner nel suo mirabile Tolstoj o Dostoevskij (1959, trad. it. Garzanti 1995, pp. 197-8), il Diario di uno scrittore registra con insistenza morbosa i casi di violenza contro i bambini, e anche alle radici di Delitto e castigo – documentate dagli abbozzi – figura la passione sadica per i “bambini violati” di Svidrigajlov, questa specie di doppio iperbolico (e destinato alla catastrofe) di Raskol’nikov. Sicché si può dire che fermenti sempre questo medesimo plesso lancinante, alle radici del tema dell’atto gratuito che da quest’opera di Dostoevskij, come si sa passando per Gide, s’è imposto alla coscienza moderna. In ogni caso, sintetizza Steiner (op. cit., p. 199), “Dostoevskij considera la sofferenza dei bambini, e soprattutto la loro degradazione sessuale, come il simbolo del male concentrato in un’unica azione irreparabile. […] Torturare o violentare un bambino equivale a profanare nell’uomo l’immagine di Dio proprio dove essa è più luminosa. Ma, ancor più spaventosamente, è mettere in dubbio la possibilità di Dio, o, con una formulazione più rigorosa, la possibilità che Dio abbia una qualche affinità con la sua creazione” (è appunto questo il rovello di Ivan Karamazov).
Nell’ultimo capitolo di Resistere non serve a niente, intitolato “Che cos’è una magnolia?”, torna il tema faustiano (“siamo davvero i nuovi alchimisti, i soli che si orientano nel pianeta in bollitura”, 107) del “patto”. All’inizio s’era saldato in questa chiave il rapporto fra Tommaso e il suo “evangelista” narratore; ma ora la sua natura demoniaca – proprio come, in precedenza, la “complicità” fra i due – non può più considerarsi con tanta facilità “simbolica”. Quello che stringono Tommaso e un industrialotto alla canna del gas viene definito, infatti, “un patto che non è di questa terra” (298). L’industrialotto riesce ad avere Tommaso a cena, e gli piacerebbe cavarsela come in qualche commediaccia all’italiana: offrendogli – in cambio del finanziamento in grado di evitargli la revolverata alla tempia – i favori di una moglie più che consenziente. Ma Tommaso, che di “super-merce” (204) muliebre ne consuma già sino alla noia, decide di rilanciare (“I peccati banali non mi interessano”, 296): quella che chiede all’industrialotto – che a tale richiesta quasi non fa una piega, badando soprattutto ad assicurarsi che il corrispettivo bonifico venga versato in anticipo – è la figlia dodicenne. Quando si produce l’incontro con Isabella, Tommaso scruta nei dettagli, con disgusto sottile che tuttavia non lo fa perdere d’animo (proprio come accadeva all’Humbert Humbert di Nabokov), il suo “corpo non specializzato”, grassottello e sudaticcio. È chiaro che non prova alcuna attrazione per lei. Tommaso non è un pedofilo. Il suo, infatti, è in realtà un “patto” con se stesso: un perfetto atto gratuito dostoevskiano. “Sotto la maglietta non porta reggiseno perché il seno è solo abbozzato, sembrano le mammelle di un maschietto obeso; com’ero io, pensa Tommaso, e il cazzo gli dà segni di vita” (299). Così può succedere quello che deve succedere. Al che il narratore, in clausola, fa due distinti (e direi opposti) commenti: “la dignità umana è una bufala” (che è quanto viene da pensare, dopo, a Tommaso) e “Lo schifo può essere una soluzione” (nel senso – abbastanza ipocrita – che “se i desideri che conducono al peccato cominciano a ripugnarti, forse qualcosa di nuovo può cominciare”: 302).
In modo come s’è visto perfettamente dostoevskiano, in realtà, l’episodio serve al personaggio di Siti quale eclatante argomento di anti-teodicea, sull’assenza o indifferenza di Dio cioè (già il tema-guida di Troppi paradisi, si ricorderà, era orientato nella medesima direzione: “il consumismo è una protesta per l’inesistenza di Dio”, p. 133). Le spie in tal senso, in Resistere non serve a niente, sono numerose. Al padre di Isabella che tenta di giustificarsi per la goffa e pecoreccia profferta di sua moglie, a sorpresa Tommaso risponde: “Che credo in Dio, lo sai?” (296). Ma, quando poi lui gli fa la sua controfferta, l’unico barlume di resistenza che riesca a opporgli l’industrialotto suona: “Chi te l’ha ordinato? Dio, non credo…”. Al che Tommaso risponde, coerente con tutto ciò che ha detto e fatto sino a quel momento: “La responsabilità è tutta mia, non c’è nessun altro di mezzo” (297). E infatti tutto il suo comportamento, nella narrazione, è ordinato alla smentita e alla cancellazione del disegno divino: il suo gioco superiore – che in pochi istanti, con un click di mouse, mette a repentaglio i destini di interi paesi e popolazioni – lo definisce “un gigantesco risiko, uno sberleffo cosmico” (251). Mentre un giorno il suo doppio Morgan, a Cipro, ascoltando ubriaco Amy Winehouse, alza gli occhi al cielo e, nello “spazio vuoto tra una palma scarmigliata e l’altra, quel che crede di leggere non è un miracolo né tanto meno un perdono ma piuttosto un permesso, una tabula rasa” (264). È appunto la tabula rasa nichilista – la febbre di Kirillov nei Demoni – che a questi personaggi permette, e anzi in qualche modo impone, di tuffarsi nell’estasi del Male.
Ma se di fronte a loro l’atteggiamento del narratore “Walter”, come abbiamo visto, è di sostanziale e incrollabile complicità, non riesco a non interrogarmi – giunto a questo punto – su quale sia, invece, l’atteggiamento dell’autore Siti. So bene di commettere in tal modo la più clamorosa delle ingenuità, di infrangere la prima norma che governa ogni narrazione “inattendibile” quali sono sempre e in particolar modo, a dispetto delle apparenze, quelle di Siti. Ma a questa tentazione, stavolta, non ho modo di resistere. La cosa che mi ha davvero infastidito nell’atto appena descritto di Tommaso (e lo ha fatto molto), è un suo aspetto in apparenza marginale. S’è detto che il suo gesto non ha moventi passionali, sessuali. Non ha cioè alcuna parte, in esso, il Desiderio – primo motore immobile, invece, di tutti i libri precedenti di Siti. Quello di Tommaso nei confronti di Isabella è uno stupro tutto intellettuale, e anzi come s’è visto addirittura (a)teologico. Forse rappresenta un’altra ingenuità chiedersi il perché di qualcosa che per definizione un perché non ce l’ha, come appunto un atto gratuito; eppure avere a che fare con un romanzo – un’architettura di parole, calibrata come sempre quelle di Siti, con echi e raccourcis mai casuali – mi spinge irresistibilmente a farlo.
E dunque. Appena prima che Tommaso vada dal padre a fargli la proposta che sappiamo, in seguito a una baruffa coi fratelli Isabella s’è chiusa in camera. E “andando in bagno Tommaso ha notato un cartello sulla sua porta, tenerissimo di privacy infantile: ‘Vietato l’ingresso – Pericolo di morte’ e sotto un teschio con le ossa incrociate” (296). Appena una decina di pagine prima, all’inizio del capitolo, vediamo lo stesso Tommaso pasteggiare in un ristorante di estremo lusso, nel centro di Roma percorso dalle “proteste dei giovani” (286; siamo al Pantheon, il Teatro Valle è lì a pochi metri). Gli capita un piccolo incidente: è alla cassa per pagare quando vede che di fronte alla vetrina del ristorante si danno di gomito “due ragazze molto giovani, quasi due adolescenti”. Il loro aspetto e il loro abbigliamento gli fanno escludere che siano due possibili clienti. A un certo punto infatti le due ragazzine si accovacciano davanti alla soglia del locale, si abbassano jeans e mutandine (l’occhio del narratore indugia, au ralenti, su questo istante:“il doppio diaframma dei vetri ne rifrange la bizzarra postura e i lampi di acrilico multicolore – poi due mezzelune rosa di efebica nudità”): le due piccole rivoluzionarie si mettono “a pisciare per spregio davanti a quel tempio borghese del lusso (così probabilmente presentano l’azione a se stesse)” (286). Tommaso non pensa nulla e nulla – per una volta – gli fa dire il narratore. Sente solo un’inspiegabile attrazione nei loro confronti: “già mulina nel cervello varie ipotesi di approccio – una consolazione, un blando rimprovero paterno, un ‘avete ragione’ a mezza bocca”, tutte ipotesi per lui perfettamente equivalenti come si vede; allorché una delle due, con perfetta scelta di tempo, proietta nella sua direzione uno sputo. Col quale non centra il suo viso come avrebbe voluto, ma gli sfiora solo il mento, atterrando su una spalla della sua giacca. È un’epifania: “più delle auto in fiamme e dei cartelli stradali usati come arieti, quell’umidore carnale è il marchio a fuoco della giovinezza finita e di una progressiva, inquietante, perdita di lucidità” (287).
Se fossimo in uno dei libri precedenti di Siti non ci stupiremmo a scorgere, in una scena del genere, la genesi del desiderio. È sotto la lente del desiderio, appunto, che negli altri libri venivano regolarmente tradotte le emergenze storiche e politiche (rinvio a quanto scritto in Il romanzo della politica La politica nel romanzo. Almanacco Guanda, a cura di Ranieri Polese, Guanda 2008). Ma quello che nasce, stavolta, non è un desiderio. Bensì una volontà di vendetta: che per proprio oggetto sceglie chi detiene quanto colui che la esercita sente di aver perduto – la giovinezza finita. Lo stupro di Isabella comincia qui, insomma; e a dimostrarlo è un dettaglio rivelatore. Sotto i giubbotti colorati delle ragazze del ristorante, infatti, Tommaso fa in tempo a scorgere che indossano “magliette coi teschi” (286). Esattamente il dettaglio tenerissimo che, di lì a poco, definitivamente lo attrarrà nell’abiezione.
Questo cortocircuito, seppur spostato verso la fine, è il vero centro del romanzo di Siti. Quello che lo spinge a mettere in scena, per il suo personaggio, un atto decisivo che è estraneo al proprio immaginario sessuale, il suo personale desiderio (che infatti viene dichiarato estinto all’inizio del romanzo – il quale del resto segue l’altro, che dell’ossessione annunciava l’autopsia). Ma dal punto di vista di un’ipotetica verosimiglianza non è così congruo che domini i pensieri di un men che quarantenne, qual è Tommaso, il senso della giovinezza finita. Il quale riguarda invece, molto evidentemente e appunto molto dichiaratamente, il narratore. Nonché, al di là di esso, l’autore che porta il suo stesso nome. Era stato infatti proprio il narratore, e non Tommaso, a visitare il Teatro Valle e a pronunciare, con parole dostoevskiane, il più sprezzante dei giudizi nei confronti della passione di futuro dei giovani compagni delle due ragazze colle magliette coi teschi. E quando, alla fine del libro, viene pronunciato l’aforisma che lo intitola, è “Walter” a farlo – con aggiunta eloquente: “Resistere non serve a niente… il sangue dei vecchi non lo vuole nessuno” (313). S’è visto poi come sia stato direttamente l’autore a comminare, alle ossessioni valoriali di Dostoevskij, il più sulfureo dei contrappassi. Per dirla con l’ennesimo aforisma: “L’eternità non è più di moda” (49).
È stato sempre Steiner a indicare come in Dostoevskij “i delitti contro i bambini sono l’altra faccia, reale e simbolica, del parricidio”, cioè dell’altro grande tema ossessivo della sua opera (op. cit., p. 200). Un tema che com’è noto Freud – nel saggio più acuto fra quelli da lui dedicati alla letteratura, quello sull’autore del “romanzo più grandioso che mai sia stato scritto” ossia I fratelli Karamazov (Dostoevskij e il parricidio, 1927) – ha ricollegato al complesso di Edipo. Ma è in uno scritto assai meno noto, Un’esperienza religiosa, scritto più o meno insieme a quello su Dostoevskij, che Freud applica esplicitamente il meccanismo edipico alla tematica religiosa in precedenza affrontata in Totem e tabù e nell’Avvenire di un’illusione: la lotta contro Dio (Freud parla anzi, propriamente, di “resistenza contro Dio”), che si spinge nell’ateo sino al deicidio, altro non è che “una riproduzione della situazione edipica”: cioè ovviamente della lotta contro il Padre (trad. it. di Renata Colorni in Opere, X, Boringhieri 1978, p. 516).
Nei libri di Siti – che seguono, seppur con lievi e significative sfasature, lo snodarsi del vissuto “empirico” dell’autore, per dirla sempre col lessico narratologico – l’emersione dell’Edipo procede di pari passo con l’invecchiamento dei suoi genitori reali (nonché ovviamente col proprio). Ma è anche simmetrica al precisarsi e approfondirsi della dimensione politica, di quest’opera. Se in questo senso un punto di svolta non si può non indicare in Troppi paradisi, vi si dovranno rileggere quelle che sono in assoluto, con ogni probabilità, le pagine più belle mai scritte da Siti: il capitolo iniziale intitolato “La miseria dei miei” e dedicato, appunto, alla catastrofe dell’invecchiamento. L’invecchiamento dei genitori ottantenni, l’invecchiamento proprio, l’invecchiamento della realtà tutta (e persino dell’irrealtà, una volta ben funzionale a sostituirla). “La mia coazione al semi-lusso”, confessa “Walter Siti”, “è anche una reazione alla miseria dei miei” (p. 18): cioè alla loro parsimonia antica e out-of-date, figlia dei valori di un tempo esautorato e obsoleto. Passando per la formazione di compromesso di Autopsia dell’ossessione, alla fine del quale la madre veniva uccisa dal doppelgänger Pulvirenti (che forse, alla maniera di Gonzalo Pirobutirro nella Cognizione del dolore gaddiana, dopo tanto averlo desiderato, in effetti solo fantastica di averla fatta fuori), è in Resistere non serve a niente – dove la sua coazione incontra il lusso vero, sia pure per l’interposta persona di Tommaso – che il nodo di “Walter”, nonché quello di Siti, finalmente viene al pettine.
Il sangue dei vecchi non lo vuole nessuno. I vecchi genitori di “Walter” – memorabili co-protagonisti del primo capitolo di Troppi paradisi – in Resistere non serve a niente sono liquidati in poche battute. E “liquidati” non è una metafora. Di sua madre, a un certo punto, gli chiede Tommaso “Ma… è morta?” e lui risponde: “Peggio, non è più in grado di rispondere… l’unica cosa che manca a una morte dignitosa è una salma” (212). Mentre la pratica paterna, già archiviata da qualche tempo, così la commenta “Walter” rivolgendosi a Tommaso (e così giudicando il proprio operato): “se invece che un povero commesso viaggiatore mio padre fosse stato proprietario di un negozio, voi gli avreste rovinato la vita… in realtà sto sputando sulla sua tomba” (311-2).
Tommaso e il suo mondo valoriale hanno insomma consentito “per procura” (314; e cfr. Troppi paradisi, p. 57), a “Walter”, quanto vagheggiava almeno da Troppi paradisi (“Come si fa a uccidere una madre senza lasciare tracce?”, p. 305) – e cheil troppo isterico Pulvirenti di Autopsia dell’ossessione non era riuscito a fare “davvero” fino in fondo: simbolicamente uccidere i propri genitori.
L’ambivalenza torturante del proprio rapporto coi genitori “Walter” l’ha confessata una volta per tutte, del resto, già in Scuola di nudo (pp. 154-5), col tramite esemplare d’uno spettacolo televisivo: “In una gara di sci la tragedia della mia vita: desidero sempre che vincano quelli per cui non faccio il tifo. Tutto è cominciato col terrore insopportabile che mio padre perdesse, e quindi tenevo per qualcun altro: tifavo contro di lui per non affrontare la disperazione di vederlo sconfitto. Da quel momento la passione superficiale si è divisa dall’appartenenza profonda: quelli contro cui mi schiero sono, in verità, i miei. Non dunque l’atteggiamento nobile di chi sta con i perdenti, ma quello pazzoide di chi vuole che perdano coloro per cui sta”. Il disamore profondo che “Walter” nutre nei confronti dei suoi, insomma, è un costante scommettere al ribasso. E qual è infatti la specialità di Tommaso Aricò – il virtuosismo che gli permette una fulgida ascesa proprio negli anni della Grande Crisi, quando i suoi colleghi speculatori annaspano – se non appunto questa? Rispetto al compagno di scalata Folco, che “è più portato a comprare” e che ci lascerà infatti le penne, Tommaso è uno specialista del “vendere giocando al ribasso; prova un piacere che confina con la preghiera a verificare ogni volta che il crollo previsto è inevitabile” (121).
Con tutta evidenza, non si tratta solo di affari. Per lui questa speciale abilità ha qualcosa di più intimo, simbolico e quasi trascendente (mio l’ultimo corsivo): “in quei momenti si sente come un profeta vendicativo con la spada sguainata. A vendicare che cosa non saprebbe dirlo nemmeno lui” (121; e si rammenti la frase di “Walter”, su Tommaso proprio fantasmatico “vendicatore”, 314). Il fatto è che Tommaso e “Walter” professano e praticano, in campi diversi, la medesima “religione profonda”: “un rancore vecchio quanto me”, spiega il secondo in Troppi paradisi (p. 127), “mi spinge ad apprezzare tutto quello che distrugge la vita, o la sputtana, dimostrando che è identica ai suoi surrogati”. E distruggere la vita, per “Walter” che per scelta sessuale si preclude di produrne di ulteriore, non può che consistere nell’annichilire chi gliel’ha data.
Quanto più fa soffrire, nelle prime pagine di Troppi paradisi, è l’incapacità d’amare che si capovolge nel suo contrario. L’odio per i genitori, a più riprese scatenato in “Walter” dalla loro “miseria”, a questo si deve in realtà: “Lo so cosa vorrebbero da me, amore e non cibo – ma quello non posso darglielo da tanto tempo, ve l’ho detto che sono mediocre” (p. 16). In Resistere non serve a niente la stessa generosità – che allude alla medesima sfera trascendente – è preclusa invece a Tommaso, nei suoi rapporti con l’altro sesso: “la fede che sarebbe necessaria a un grande amore è condizione non più recuperabile” (144; e infatti poco prima, citando un innominato Céline, dell’amore si dice che “è l’infinito alla portata dei cani”: 143).
Ma a quali valori è impossibile restare fedeli? Per quale parte, che malgrado tutto si continua a sentire la propria, si fa un così nevrotico tifo contro? A quale DNA, nel tempo remoto ma nelle viscere così prossimo, ci si sente ancora legati? Quali legami si vorrebbe con tutte le proprie forze recidere – se necessario uccidendo chi storicamente, ma anzitutto visceralmente appunto, ne è portatore? A queste domande ha per tempo dato risposta la scena più memorabile di Troppi paradisi, il suo cuore di tenebra: “penso a mio padre, intimidito dall’enormità dei telegiornali; a mio padre che posa piano la forchetta quando parlano di corruzione, e mia madre antica staffetta partigiana di Montefiorino che inveisce “an n’am menga mazè abasta, quand a psìven”, non ne abbiamo ammazzati abbastanza, quando si poteva” (p. 48). È appunto la Resistenza – in tutti i sensi fisici e metafisici, storici e trascendenti (il “Principio Resistenza” di Zanzotto…) – quella che “Walter”, e insieme a lui Siti, suo metafisico complice, hanno deciso di uccidere dentro loro stessi. Eseguendo la sentenza, finalmente, in Resistere non serve a niente.
Non serve a niente resistere sino al provocatorio, protervo lieto fine appiccicato alle sue ultime pagine – riconsegnando a Tommaso la magnifica merce Gabry, il suo paradiso prêt-à-porter –, onde ricavare la morale di Resistere non serve a niente. Come la lettera rubata essa ci viene consegnata all’inizio, prima dell’inizio anzi. È tutta nel titolo, il primo e più comprensivo degli aforismi che lo punteggiano. Una morale politica. È un pensiero compiutamente e consapevolmente di destra, cioè, quello dall’inizio alla fine professato da Resistere non serve a niente. Quel pensiero che da sempre ha terrore del futuro e detesta chi si sforza di produrlo (“Sono l’Occidente perché detesto i bambini e il futuro non mi interessa”, memorabile sentenziava Troppi paradisi a p. 186). Quel pensiero che da sempre considera la storia un fenomeno naturale, al quale come tale – appunto – è inutile opporsi. Quel pensiero che da sempre, della natura umana, considera solo e ossessivamente il Male. Quel pensiero che da sempre osserva esclusivamente il pessimismo della ragione, irridendo e compiangendo quella volontà che altro potrebbe concepire.
Certo siamo in presenza di una destra moralmente, oltre che tecnologicamente, “all’altezza dei tempi” (315). Alla fine del capitolo “ideologico”, “Gli uomini preferiscono le tenebre”, al capomafia Morgan viene lasciata torrenzialmente, irresistibilmente la parola. Ed è lui che ci proietta “nel cuore del teorema” (281): “la democrazia è il dio morto della modernità che sopravvive come un idolo di cartapesta” (281), “la democrazia è contro natura” (innegabile la degnità di p. 279: e infatti la destra di ogni tempo è la legge di natura che venera), “le oligarchie implicite devono uscire allo scoperto” (280: se necessario redigendo “per procura” un manifesto in forma di romanzo) e finalmente regnare, come è loro diritto sempre di natura, sugli esseri umani ridotti a “organismi collettivi, colonie tipo i coralli o le spugne, compattati dalla scienza come nell’alto medioevo li compattava la religione” (281). Resistance is futile. Come no? E Resistere non serve a niente – purtroppo – è il libro più bello dell’anno.
Ancora più provocatorio era stato Tommaso. Che a un certo punto s’era trovato a pronunciare la frase-scandalo: “un’alternativa c’è ma si chiama rivoluzione” (166). Naturalmente la pronuncia – allo stesso identico modo in cui il narratore aveva detto che “la bellezza salverà il mondo” – solo per “risolvere un teorema per assurdo” (134): appunto il “teorema” che più avanti spetterà alla sua versione hard, Morgan, dispiegare per esteso. La morale di Siti è quella che in Troppi paradisi lo aveva fatto innamorare della televisione appunto perché in essa aveva scoperto “il luogo in cui si può raccontare solamente che non c’è speranza di cambiare il mondo” (p. 78). Ed è la stessa morale che ora lo spinge a inscenare, implacabile, un patto che non è di questa terra.
Ma ognuno riconosce i suoi, Walter. E tu lo sai bene che noi, invece, siamo della razza che rimane a terra.
Walter Siti, Resistere non serve a niente, Rizzoli, pp. 321, € 17