Un’intervista cinese / Carlo Ginzburg: scrivere di storia significa "Tartufi per tutti”
Microstoria
Lei ha scritto di essersi imbattuto nei documenti poi utilizzati nel libro Il formaggio e i vermi mentre stava lavorando a I benandanti, e di non aver pensato a quei documenti per alcuni anni prima di cominciare a scrivere il libro. Perché si è interessato alle vicende di un personaggio minore come quello?
All’inizio della ricerca che poi confluì nel libro I benandanti trovai un documento scritto da un inquisitore al principio del ‘700: un elenco “dei primi mille processi celebrati dall’Inquisizione in Friuli”, una regione situata al confine nord-orientale dell’Italia. Ogni processo menzionato nell’elenco era accompagnato da un riassunto di poche righe. Cominciai a ispezionare l’elenco, che comprendeva processi contro eretici, streghe e così via, cercando benandanti (i protagonisti di quello che sarebbe diventato il mio libro) – e tutt’a un tratto m’imbattei nel riassunto di due processi contro un contadino [si chiamava Domenico Scandella] che sosteneva che il mondo era nato dalla materia putrefatta. In altre parole, mi trovai di fronte a un riassunto di poche righe, non alla documentazione che analizzai successivamente: un particolare minimo, che però getta qualche luce sulla traiettoria di ricerca che mi portò a scrivere Il formaggio e i vermi. A questo punto sorge inevitabilmente una domanda: perché, tra mille riassunti di processi, la mia attenzione venne attratta proprio da quelle poche righe, che trascrissi immediatamente su un foglietto di carta?
Retrospettivamente, penso che fui colpito da tre elementi: a) la tesi anomala formulata dal contadino; b) il possible nesso tra quella tesi e uno strato sconosciuto di materialismo contadino; c) un’associazione fulminea (e gratuita) che mi attraversò la mente, tra la tesi di quel contadino sull’origine del mondo e un pannello del famoso polittico (oggi a Colmar) eseguito all’inizio del ‘500 da Matthias Grünewald. Il pannello, che raffigura l’incontro di due eremiti in un paesaggio, era stato descritto dallo storico dell’arte Kenneth Clark in questi termini:
“La bizzarra idea del limo primigenio sembra avere fortemente ispirato Grünewald. Siamo sorpresi di non vedere un dinosauro accanto ai due santi eremiti”.
Senza dubbio, questo passo del libro di Clark Il paesaggio nell’arte, che avevo letto poco prima, aveva lasciato una traccia indelebile nella mia memoria, creando un ponte tra un’immagine (il dipinto di Grünewald) e un testo (il brevissimo riassunto del processo inquisitoriale contro Menocchio). Incidentalmente, ho scoperto poco fa, consultando una copia della versione inglese del libro di Clark oggi alla Biblioteca dell’Archiginnasio, che il suo primo proprietario, lo storico dell’arte Francesco Arcangeli, aveva sottolineato in margine lo stesso passo: N(ota) B(ene).
Dunque, la scintilla che accese, vari anni dopo, il mio progetto di ricerca, scaturiva da un miscuglio eterogeneo. Credo che succeda spesso – anche se in molti casi la scintilla si spegne subito.
L’appunto che trascrissi nel 1962 rimase sepolto tra le mie carte per otto anni, anche se di tanto in tanto mi tornava in mente. Poi, nel 1970, decisi di andare a Udine per consultare i processi contro quel contadino: e quando cominciai a leggere quei documenti ne fui subito afferrato. Penso che molti storici avrebbero menzionato il caso in una nota a piè di pagina; perché decisi di dedicargli un libro? Forse una risposta emergerà dalle mie risposte alle domande che seguiranno.
Sua madre scriveva romanzi, suo padre era un filologo, uno storico e un critico letterario, tra i suoi amici c’erano persone come Italo Calvino. Sarebbe difficile associarla a quella che Gramsci definì “cultura delle classi subalterne”, non è vero?
Le scelte che hanno modellato gli inizi della mia traiettoria di studioso avevano radici diverse, culturali e personali, consapevoli e inconsce. Poco prima dei vent’anni lessi Cristo si è fermato a Eboli (1945): un libro basato sul periodo passato nel 1935-’36 dal suo autore, Carlo Levi, in un piccolo villaggio dell’Italia meridionale, dove era stato confinato dal regime fascista. Carlo Levi e mio padre, Leone Ginzburg, erano amici; due intellettuali ebrei, membri dello stesso gruppo antifascista clandestino, Giustizia e Libertà. Mio padre, che aveva passato due anni in carcere per la sua attività antifascista, visse negli anni 1940-’43 a Pizzoli, un paese degli Abruzzi, dove fu raggiunto da mia madre e dai loro due bambini (io ero il maggiore); lì nacque mia sorella. In quel paese ho passato i primi anni dell’infanzia. Dopo la morte di mio padre e la fine della guerra, mia madre scrisse un saggio commovente su quel periodo della sua vita, descrivendo l’ambiente contadino in cui avevamo vissuto. Una ragazza che si prendeva cura di me e dei miei fratelli ci raccontava, nel suo dialetto, storie di magia e di fantasmi. Questa immersione parziale nella cultura contadina riemerse quando lessi i Quaderni del carcere di Antonio Gramsci e Cristo si è fermato a Eboli Carlo Levi. Entrambi, in maniera diversa, agirono su di me come dei filtri, attraverso i quali ho rivisitato degli anni che avevo passato da bambino in quel villaggio.
Sono ben consapevole delle implicazioni politiche della mia esperienza privata. Gli elementi culturali di cui sto parlando fanno parte di un’eredità trasmessa alla mia generazione (o almeno a una sua parte) dalla generazione precedente. Dalla fine della seconda guerra mondiale la scoperta della ricchezza della cultura contadina dell’Italia del sud ha avuto una parte importante nella strategia politica del partito comunista italiano. Successivamente le riflessioni di Antonio Gramsci sulle classi subalterne hanno avuto echi in tutto il mondo. Carlo Levi, il cui libro ebbe subito un successo internazionale, era vicino ai comunisti, anche se non divenne mai membro del partito. Fui profondamente colpito dal suo tentativo di analizzare la cultura contadina che aveva incontrato al confino. In Cristo si è fermato a Eboli coesistevano una simpatia profonda e una netta distanza intellettuale. Ho avuto la fortuna di conoscere Carlo Levi e di diventare amico di Giovanni Levi, uno dei suoi nipoti, con cui molti anni dopo ho collaborato alla costruzione della microstoria.
Ma le scelte che orientarono la prima fase della mia traiettoria di ricerca avevano anche una dimensione di cui per molti anni non mi resi conto. “Non c’è da stupirsi che un ebreo come te si occupi di eretici e di streghe” mi disse una volta lo storico dell’arte Paolo Fossati (Il formaggio e i vermi era stato appena pubblicato). Rimasi sbalordito: il nesso era ovvio – come avevo potuto rimuoverlo? Retrospettivamente, attribuii quella rimozione a una strategia dell’inconscio, volta a rendere quel nesso più efficace. Nel saggio “I benandanti, cinquant’anni dopo”, che se non erro è stato incluso nella ristampa dell’edizione cinese di quel libro, ho detto qualcosa sui ricordi, legati al periodo della guerra, che avevano fatto di me un bambino ebreo.
Quando lavoravate, lei e i suoi amici legati a Quaderni storici, all’elaborazione della microstoria, vi rendevate conto di partecipare a un progetto che avrebbe cambiato la storiografia? Che cosa vi spingeva allora?
Le nostre discussioni erano assolutamente libere, immuni da condizionamenti accademici o politici. Eravamo tutti orientati a sinistra, anche se nessuno di noi era iscritto a un partito. Ci rendevamo conto che ci inoltravamo in un terreno inesplorato – anche se ognuno di noi seguiva una traiettoria di ricerca diversa. Penso che allora (ossia alla fine degli anni ’70) nessuno di noi poteva immaginare le ripercussioni di ciò che stavamo facendo. Più tardi, siamo stati colti di sorpresa (io lo sono ancora) dalla ricezione internazionale della microstoria.
Nella prefazione a Il formaggio e i vermi lei ha menzionato Foucault. In che senso l’opera di Foucault l’ha influenzata in quel periodo? Soprattutto perché ha fatto qualcosa di simile nel suo “Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello…”?
Non sono mai stato influenzato da Foucault; ho criticato esplicitamente i suoi scritti, e in particolare il libro che lei ha citato.
In Cina, Il formaggio e i vermi è considerato da molti come uno dei “tre classici della microstoria”; gli altri due sono Il ritorno di Martin Guerre di Natalie Zemon Davis e Montaillou di Emmanuel Le Roy Ladurie. Qualcuno respinge questo tipo di graduatoria, ritenendola incompatibile con i libri di storia. Non solo: anche l’etichetta di “microstoria” nasconde differenze di prospettiva. Che cosa pensa di questa graduatoria?
Parto dalla domanda che si lega al problema generale da lei sollevato: è possibile stabilire una graduatoria tra opere scientifiche o artistiche? A un livello altissimo – per esempio: chi è superiore come pittore, Leonardo o Raffaello? la domanda appare assurda. Ma respingere l’idea di una graduatoria significherebbe respingere l’idea di qualità – il che sarebbe altrettanto assurdo. Ora, il termine “qualità” potrebbe sollecitare una reazione semplice, del tipo “sì o no”; ma un’argomentazione particolareggiata sarebbe più utile. Nella postfazione alla traduzione italiana del Ritorno di Martin Guerre di Natalie Zemon Davis (1984) cercai di precisare le mie reazioni a un libro così brillante e così provocatorio, che apparve in traduzione italiana in una serie denominata “microstorie”, diretta da Giovanni Levi e da me. (Sull’opportunità di includere quel libro nella nostra collana non avemmo alcun dubbio). Incidentalmente, nel Formaggio e i vermi il termine “microstoria” non compare mai: dopo tutto, quella nozione emerse anche dalle discussioni attorno al mio libro.
Quando si parla di microstoria ci possono essere degli equivoci: qualcuno può identificarla con la biografia di un personaggio minore, oppure con le minuzie della vita quotidiana. Leggendo i suoi scritti si ha l’impressione che microstoria e macrostoria non siano veramente distinte. In un’intervista con la “Shanghai Book Review” lei ha detto che ci sono molti libri che si autodefiniscono “microstorie” ma che non sono veramente tali. Che cosa è la vera microstoria?
Com’è stato detto molte volte (ma forse mai abbastanza) il prefisso “micro”, nella parola “microstoria”, si riferisce alla prospettiva analitica: non alle dimensioni, reali o simboliche, dell’oggetto dell’analisi. “Micro” allude al microscopio: sotto la lente di un microscopio possiamo mettere il frammento di un insetto o il frammento della pelle di un elefante. Il primo titolo della serie “microstorie” fu un libro scritto da me su Piero della Francesca – un gigante della storia dell’arte. Ci sono molte versioni della microstoria – comprese alcune in cui la dimensione analitica, che era al centro del nostro progetto originario, è del tutto assente. Ma un’ortodossia microstorica non esiste.
Il formaggio e i vermi è stato un grande successo: ha rivoluzionato la storiografia alla fine degli ’70 e al principio degli anni ’80. Com’è cambiata la posizione della microstoria in rapporto alla storiografia in generale, dopo la pubblicazione del Formaggio e i vermi? Come vede gli sviluppi della microstoria dopo di lei?
Non ho potuto seguire gli sviluppi della microstoria. Qualcuno ha considerato l’emergere della storia globale, che ha certamente cambiato il paesaggio storiografico, come una sfida alla microstoria. Ho sostenuto il contrario in un saggio (“Microstoria e storia del mondo”) tradotto in molte lingue, tra cui il cinese.
I microstorici più recenti sono più interessati all’antropologia che alla psicologia freudiana. Ha dei commenti da fare su questo fenomeno?
Senza dubbio le mode intellettuali esistono. Non sono né un antropologo né uno psicoanalista, ma mi interessano le discipline alle quali fanno riferimento, e la loro interazione. Per esempio, mi riprometto di esaminare da vicino il contributo di Georges Devereux all’etno-psicoanalisi.
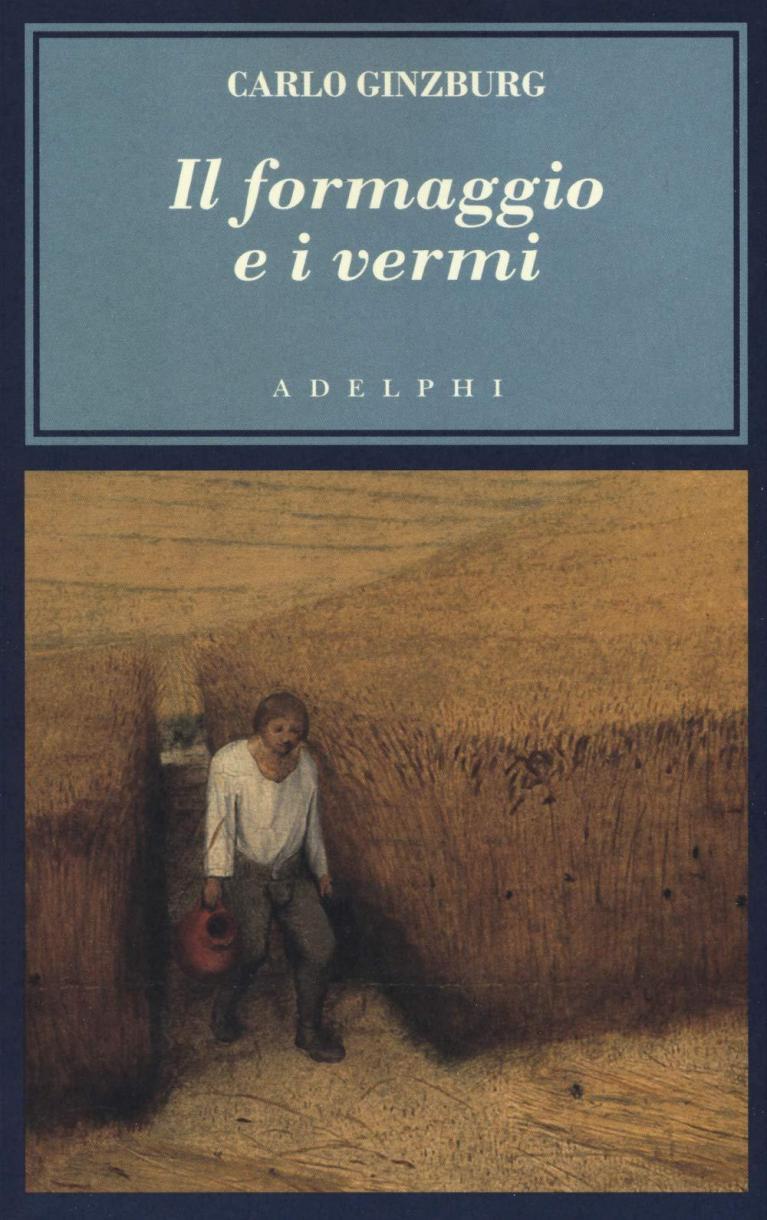
In quanto lettrice cinese, le chiedo: ha osservazioni o commenti sugli sviluppi della microstoria in Cina?
Mi dispiace: devo confessare la mia ignoranza. Non sono in grado di rispondere alla sua domanda.
Politica
Lei ha affermato che la sua ricerca è legata al "populismo che è una parte importante della mia formazione", e che esistono molti legami tra il populismo e le sue scelte come storico. Da qui sarebbero derivati, da parte sua, qualche errore e qualche eccesso interpretativo. Sono affermazioni che mi lasciano perplessa, dato che oggi, quando parliamo di populisti, pensiamo subito a Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti, e ai suoi seguaci. Può spiegare che cos’è il “populismo” che è stato parte della sua formazione?
Capisco perfettamente la sua perplessità. Il populismo di cui ho parlato, in quanto elemento della mia formazione, era il populismo russo: il movimento politico e culturale che nell’800 cercò di stabilire un rapporto stretto tra le élites intellettuali e i contadini. Franco Venturi, nella prima edizione (1952) del suo libro fondamentale sui populisti russi, menzionò mio padre (entrambi facevano parte del gruppo antifascista Giustizia e Libertà) definendolo “un’incarnazione nuova e originale dello spirito dei populisti”. Ho reinterpretato i miei ricordi infantili, legati al luogo dove mio padre era stato confinato, attraverso la frase di Franco Venturi. Come vede, il populismo di Trump è un fenomeno completamente diverso, anche se la denominazione è la stessa.
Lei è uno storico di sinistra, ma i suoi lavori sono in un certo senso distanti dalla politica, cosa rara tra gli storici della sua generazione. Perché? Qual è secondo lei la giusta distanza tra storia e politica? Lei è d’accordo con l’affermazione di Benedetto Croce secondo cui “tutta la storia è storia contemporanea”?
Ho formulato una critica particolareggiata dell’argomentazione di Benedetto Croce secondo cui “tutta la storia è storia contemporanea” in un saggio (“Le nostre parole, e le loro”) che è stato tradotto anche in cinese. Partendo dalla distinzione proposta da Kenneth Pike, antropologo e linguista, tra categorie etic e categorie emic, riferite, rispettivamente, alla lingua dell’osservatore e alla lingua degli attori, ho sostenuto che gli storici formulano domande etic, plasmate dalla storia contemporanea, per ottenere, attraverso un’analisi della documentazione, risposte emic legate alle categorie degli attori. Ecco perché, nel saggio “Microstoria e storia del mondo”, che ho già ricordato, ho scritto che “ogni vera storia è storia comparata”, poiché implica necessariamente una comparazione (e un dialogo) tra le due prospettive, quella dell’osservatore e quella degli attori.
Esiste un elemento ricorrente nelle sue ricerche? Si direbbe che il tema della mobilità intellettuale che era al centro del Formaggio e i vermi sia diventato via via più marginale nelle sue ricerche successive. Lei ha detto in alcune interviste che questo è un sintomo minimo di un grande problema, ossia la sconfitta della sinistra in Italia. Può dire qualcosa su questo punto?
La sconfitta della sinistra che si è verificata negli ultimi decenni non è un fenomeno esclusivamente italiano. Senza dubbio, la circolarità tra cultura popolare e cultura delle élites (la “mobilità intellettuale” è un’altra cosa) analizzata in Il formaggio e i vermi rifletteva il clima politico italiano degli anni ’60 e dei primi anni ’70, e l’importanza assunta dalla sinistra in quel periodo. Ma quella circolarità è un’ipotesi che continua ad affascinarmi. Recentemente, nella prefazione alla traduzione russa, di prossima pubblicazione, di Giotto and the Orators di Michael Baxandall, ho esplorato il rapporto tra la lingua delle botteghe e la lingua con cui gli umanisti parlavano della pittura.
In The Uses and Abuses of History, Margaret MacMillan sostiene che gli storici non devono dedicarsi soltanto alla storia culturale e sociale abbandonando lo studio della storia politica. Che ci piaccia o no, la politica influisce profondamente sulla società e sulle vite di ciascuno di noi. Che cosa pensa di quest’affermazione?
Uno dei miei libri, Il giudice e lo storico (1991, tradotto in varie lingue; la traduzione russa è stata pubblicata pochi mesi fa) analizza un evento politico contemporaneo: il processo contro Adriano Sofri, leader del gruppo di estrema sinistra Lotta continua. Nel 1991 Sofri fu accusato di aver ispirato l’uccisione di un commissario di polizia, avvenuta nel 1972. Decisi di scrivere quel libro perché Adriano Sofri è uno dei miei amici più cari, ed ero certo della sua innocenza. Con quel libro, basato su un esame particolareggiato della documentazione processuale, cercai di convincere la giuria del processo d’appello che l’accusa contro Adriano Sofri era assolutamente infondata – ma inutilmente. Adriano Sofri fu condannato a 22 anni di carcere. Dopo 9 anni fu colpito da un grave malore che lo ridusse quasi in fin di vita. Fu mandato agli arresti domiciliari; ora è libero.
Il mio rapporto con la politica è certamente indiretto, ma forse Il giudice e lo storico non costituisce un’eccezione. Mi pare che i miei interventi contro lo scetticismo postmoderno abbiano ben precise implicazioni politiche. Citerò un solo esempio: il saggio “Unus testis”, che è stato tradotto in molto lingue, compreso il cinese. Recentemente ho scritto vari saggi sulle fake news, e sul modo di demistificarle: un tema che ha implicazioni politiche evidenti.
Scrivere di storia
Lei ha lavorato su temi molto diversi, come mi resi conto ascoltando nel 2019 la sua conferenza su Machiavelli e Michelangelo all’università di Pechino. Secondo lei, c’è una contraddizione tra gli studiosi che si divertono a scorrazzare in varie direzioni e quelli che preferiscono specializzarsi in un ambito ben preciso? Qual è secondo lei la differenza, nel campo della ricerca, tra le “volpi” e gli “istrici”, per citare Isaiah Berlin?
Per i veri specialisti provo ammirazione; certo, io non lo sono affatto. Mi piace affrontare nuovi temi partendo da zero. In questi casi, come mi è capitato di dire, provo “l’euforia dell’ignoranza”: non so niente, ma imparo qualcosa. Mi piace saltare da un tema all’altro, ignorando i confini tra le discipline. Dunque, secondo la dicotomia proposta da Isaiah Berlin [che la riprendeva da Archiloco] sarei una volpe? Non credo. Quando, molti anni fa, Maria Lúcia Pallares-Burke me lo chiese, risposi (mi scuso per la lunghezza della citazione): “Penso di stare diventando sempre più simile a una volpe, anche se in ultima analisi mi considero un istrice. Nonostante la varietà dei temi di cui mi occupo, sto ancora cercando di fare i conti con le implicazioni dei miei primi lavori sulla stregoneria, basati sui processi inquisitoriali. Per me è stata un’esperienza paragonabile al lavoro sul campo per un antropologo. Anche il mio pervicace interesse per le questioni di metodo ha le sue radici in quella esperienza: il tentativo di leggere tra le righe, di leggere quelle testimonianze processuali contropelo, contro gli scopi per cui erano state costruite dagli inquisitori”. Quando la traduzione spagnola del mio dialogo con Maria Lúcia Pallares-Burke venne pubblicata nella rivista messicana Contrahistorias, il mio amico Carlos Aguirre Rojas scelse questo titolo: “El erizo encubierto”, “L’istrice nascosto”. In questa definizione mi riconosco.
Il suo metodo di ricerca consiste nello scegliere documenti a caso dall’Archivio di Stato di Venezia – la "roulette Veneziana", secondo la sua definizione – oppure di pescare titoli scelti a caso nei cataloghi online. Perché procede in questo modo? Le principali fonti d’ispirazione del suo lavoro vengono da qui?
Anch’io, come tutti, uso Internet per cercare risposte a ogni sorta di domande. Ma qualche volta uso Internet (oppure i cataloghi delle biblioteche) per imbattermi in domande inaspettate, che generano altre domande, e così via. Lo scopo di questa strategia di ricerca apparentemente contorta è di trovare qualcosa d’inatteso. Ne ho parlato in un breve saggio intitolato “Conversazioni con Orion” (Orion era il nome del software in base al quale, molti anni fa, era stato costruito il catalogo della UCLA Research Library). Certo, non posso dire che la maggior parte delle mie ricerche si basano su questa strategia: ma il caso ne è un elemento importante. In italiano la parola “caso” ha due significati: “chance” e “case”. Su questa omonimia continuo a riflettere. Una prospettiva imperniata sullo studio di casi, aperta al caso: descrivere la mia traiettoria di ricerca sarebbe insufficiente, ma non errato.
I suoi lavori sono molto leggibili e molto diversi dalla storiografia accademica. Nella Cina antica tra letteratura, storia e filosofia non c’era alcuna distinzione. Per esempio, Ssu-ma Chien, lo storico più importante della Cina antica, è molto leggibile. Ma molti pensano che oggi questo sia difficile, perché gli studiosi obbediscono alle norme accademiche dominanti. Che cosa pensa di tutto questo? Secondo lei le ricerche storiche dovrebbero essere molto leggibili?
Fin dall’inizio della mia attività di ricerca non mi sono curato delle norme accademiche dominanti. Questo era certamente frutto di un privilegio – l’ambiente intellettuale in cui sono nato. Non solo: la mia attrazione per la dimensione narrativa della storia era senza dubbio influenzata dall’esempio di mia madre che era, come lei saprà, una scrittrice molto nota. Riflettendo su questo ho cercato di definire il mio atteggiamento verso chi mi legge con un motto: “Tartufi per tutti”. I tartufi sono buoni, sono rari, sono cari: dunque, “tartufi per tutti”. Come vede, è l’opposto dell’atteggiamento paternalista verso chi legge – un atteggiamento che detesto.
Con l’ascesa del postmodernismo la storia è diventata irregolare e frammentaria. Si direbbe che tra letteratura e storia non esista un confine preciso, che la letteratura sia storia e la storia sia letteratura. Che cosa pensa di tutto questo? Qual è il confine tra letteratura e storia?
Contro quest’idea postmoderna ho combattuto per decenni. Più volte (per esempio nel saggio “Unus testis” citato prima) ho sostenuto che si tratta di un’idea inaccettabile, per motivi che sono al tempo stesso morali, politici e cognitivi. Come ho sottolineato nel mio libro History, Rhetoric, and Proof [in italiano, Rapporti di forza. Storia retorica prova] il confine tra storia e letteratura è legato alle prove. Ma sia la letteratura sia la storia si propongono di rappresentare la realtà, in modi diversi. Ho analizzato ripetutamente alcuni scambi tra letteratura e storia, dall’antichità in poi. Si tratta, com’è ovvio, di una prospettiva completamente diversa da quella postmodernista che era di moda tempo fa (oggi, spero, un po’ meno).
Questa intervista è uscita il 9 settembre 2021 su “Jiemian global”, che ringraziamo. Un grazie anche a Carlo Ginzburg. L’originale cinese si può trovare qui.









