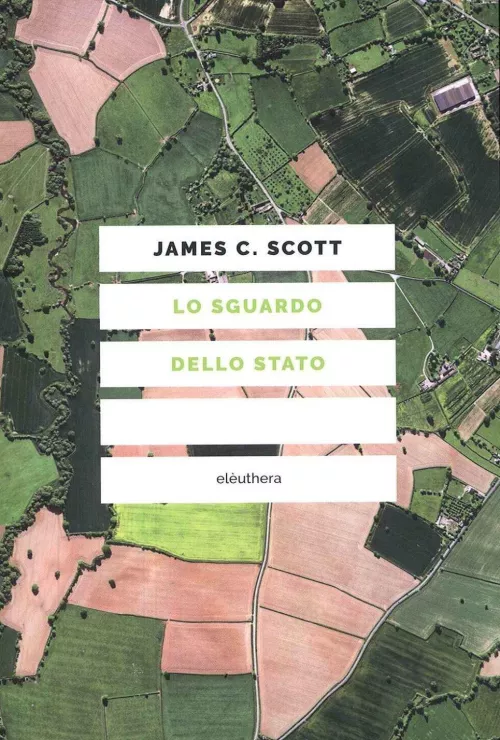Libertà e appartenenza / James Scott, Lo sguardo dello stato
Malesia, fine degli anni ’70 del secolo scorso. Nel cortile di un compound di un piccolo villaggio di campagna, attorno a un grande albero di mango rinomato in tutto il circondario per la qualità dei suoi frutti, c’è una certa animazione. Da un po’ di tempo l’albero è aggredito da orde di grosse formiche rosse che distruggono gran parte dei frutti prima che questi giungano a maturazione. A più riprese, Mat Isa, il vecchio capo famiglia, sistema ai piedi della pianta delle fronde secche di palma nipah (Nypa fruticans), e ne controlla lo stato. Interrogato, spiega sorpreso che una volta concluso il loro ciclo vitale le sottili e lanceolate foglie di quella palma si arricciano in lunghi tubi stretti. La gente del posto le usa come cartine da sigarette. Le regine delle formiche nere, invece, le usano per deporci le uova. E le formiche nere sono acerrime nemiche delle formiche rosse. Oltre il muro del compound se ne trovano numerose colonie. Le fronde secche che il vecchio capo appoggia metodicamente alla base dell’albero vengono da lì, e contengono quantità di uova pronte a schiudersi e ad attaccare quelle rosse. Mat Isa lo sa. È da settimane che, sotto gli occhi scettici dei vicini, prepara il terreno in modo che la guerra delle formiche possa scatenarsi. Una volta schiuse, e seppur più piccole di quelle rosse, le formiche nere riescono grazie al loro numero, dopo una settimana di alterne vicende, a prevalere su quelle rosse, e a salvare il raccolto dell’albero di mango.
Questo episodio, per quanto minimo, riassume bene uno dei temi principali trattati da James C. Scott in Lo sguardo dello stato, tradotto da Eleuthera, a cura di Stefano Boni, a vent’anni di distanza dalla sua pubblicazione. Il complesso insieme di conoscenze – ecologiche, botaniche, entomologiche, etc. – messe in campo dal vecchio capo per liberare il grande albero di mango dalle formiche rosse non corrisponde affatto a quelle che l’antropologo osserva negli esperti incaricati di addestrare i contadini della regione, che invece si occupano “solo di riso, fertilizzanti e prestiti”. Le conoscenze localmente radicate, vernacolari perché connesse a un saper fare quotidiano, come quelle di Mat Isa, vengono identificate da Scott con la mètis greca (sulla scia degli studi di Marcel Detienne e Jean-Pierre Vernant), in opposizione al sapere “più astratto e generalizzato”, e portatore di interessi specifici, tipico tanto delle burocrazie statali che delle grandi multinazionali (oggi, tra loro, sempre più osmotiche) e di cui individua una possibile metafora nella progressiva istituzione, a partire dalla seconda metà del diciottesimo secolo, delle scienze forestali.
La razionalità elaborata dallo Stato prussiano nella gestione del suo patrimonio forestale mira a rendere leggibile sinotticamente una realtà complessa e diversificata come quella della foresta primaria, facendola rientrare, meglio costringendola, dentro una griglia tecno-amministrativa elaborata sulla base di principi scientifici. Con un forte restringimento del campo visivo, da habitat complesso la foresta diventa risorsa, in cui ciò che conta, in base a un’appropriata disciplina tecnica e commerciale, codificabile e riproducibile, è la facilità della sua gestione. A patto di “intendere come costanti, qualsiasi variabile”, salvo quelle direttamente coinvolte nel suo sfruttamento. Nello sguardo dello Stato, la griglia è la foresta. E come accade per ogni riduzione cartografica, rappresenta solo ciò che interessa lo Stato. È nella messa in opera di questa leggibilità e semplificazione del reale, e nella limitazione via via più forte dell’autonomia di quanti la subiscono, che sta per Scott il “fulcro dell’arte di governo moderna”. Ed è in questo senso che lo schema che si esprime nella selvicoltura scientifica prussiana – leggibilità, controllo, pianificazione – diventa un analogo di quello messa in opera dallo stato moderno (nelle sue varianti autoritarie) nei grandi e fallimentari progetti di ingegneria sociale del XX secolo analizzati estesamente nel libro, si tratti della collettivizzazione forzata in Unione sovietica o della altrettanto forzata istituzione dei villaggi ujamaa (delle cooperative socialiste) in Tanzania, tra il 1973-76, dei progetti di riforma agraria di molti paesi del Terzo Mondo o, ancora, della fondazione di nuove città come nel caso di Brasilia e Chandigarh (anche se quest’ultima parte è stata omessa nella traduzione italiana).

Non si tratta per Scott di opporsi al sapere scientifico formalizzato, al contrario, ma di chiedersi invece che margini esistano ancora affinché conoscenze pratiche, contingenti e non epistemiche come quelle che hanno caratterizzato a lungo la storia e le vicende umane, possano emergere e/o essere preservate di fronte alla potenza semplificatrice nella leggibilità della società incarnata in quello che definisce “l’imperialismo dell’ordine sociale ultra-modernista”. Con questa espressione Scott esprime quell’amalgama composto “dalla gestione burocratica di natura e società, dalla fedeltà nel progresso e nelle sue possibilità di dominio sulla natura, dalla certezza di un futuro migliore che giustifica il sacrificio richiesto”, e la cui attuazione passa per un restringimento dell’attenzione verso un unico esito e un’unica soluzione (il There is no alternative della Thatcher, ripreso convintamente poi anche da Schröder) e la sua applicazione a tutti piani dell’esistenza umana. Perché l’ideologia ultra-modernista fa leva sulla logica d’emancipazione inscritta nell’idea di progresso, ed ha una spiccata tendenza “a svalutare o a blandire la politica”, le cui soluzioni e interessi “non possono che essere d’intralcio alle soluzioni sociali” che gli esperti hanno individuato grazie all’oggettività scientifica.
Tema quanto mai attuale, come si vede, anche se i dati su cui Scott elabora il suo discorso risalgono essenzialmente agli anni ’80. Bene fa quindi Stefano Boni nella sua postfazione a sottolineare come le dinamiche descritte da Scott siano in gran parte ancora riconoscibili, malgrado i cambiamenti intercorsi negli ultimi decenni, soprattutto per quel che riguarda il passaggio, fondamentale, “da informazioni statiche a dati perennemente aggiornati”. L’efficacia dello Stato, e ancor più delle grandi multinazionali, nel rendere leggibili, e in tempo reale, i suoi governati, e utenti, è sotto gli occhi di tutti, generalizzando a ogni ambito della vita la corrispondenza sempre più stretta tra corpo e codice (impronte, iride, genoma...), tra corpo e luogo (gps, social network, visa, imposizione fiscale...). Ma, sottolinea ancora lo stesso Boni, “i dati che permettono l’identificazione e il tracciamento sono ormai in buona parte offerti volontariamente” da noi stessi, in una versione attualizzata della servitù volontaria di La Boétie. Dal punto di vista antropologico il paradosso non è affatto secondario e ci si potrebbe chiedere quando e fino a che punto l’autorità centralizzata dello Stato influenza realmente la vita della gente? Perché nella lettura orientata di Scott, l’essere contro lo stato emerge talvolta come una posizione più stabile di quello che si può osservare, anche all’interno delle nostre società occidentali. Perché, e lui lo sa benissimo, la vita si esprime sempre in forme e modi ben più complessi degli aut aut con cui spesso la descriviamo. E come lui stesso riconosce, se il vecchio Mat Isa avesse avuto a disposizione un “insetticida letale ed economico”, l’avrebbe sicuramente usato.
Il punto è che Scott è perfettamente consapevole del ruolo e della forza assunta dal capitalismo globale e di come, in tale contesto, lo Stato possa paradossalmente agire in alcuni casi “da difensore delle differenze e delle varietà locali”. Il suo atto d’accusa è rivolto in particolare contro “un certo tipo di Stato”, nel tentativo di limitarne e contrastarne lo sguardo assoggettante, come ha ripetuto nel più recente Elogio dell’anarchismo. Posizione che almeno sotto certi aspetti possiamo avvicinare a quella di un’anticonformista come Jane Jacobs, citata a più riprese (in particolare nell’edizione originale) per la sua impietosa critica dell’urbanismo ultra-modernista, il cui errore principale era l’avere una concezione prettamente visuale, più che funzionale, dell’ordine (vale per le città, vale per le foreste). Nella New York degli anni ’50 e ’60, la Jacobs fu la protagonista di epici e vittoriosi scontri con Robert Moses, a lungo deus ex machina non eletto della metropoli e incarnazione perfetta della logica pianificatrice novecentesca discussa da Scott.
Eppure, in piena coerenza con le posizioni di una vita – difesa dell’informalità, della creatività del quotidiano, dell’autonomia dall’autorità centrale, etc. – la Jacobs non ci ha lasciato soltanto il suo famoso Vita e morte delle grandi città americane, ma anche, meno conosciuto, un argomentato plaidoyer scritto nel 1980 in favore dell’indipendenza del Quebec (The Question of Separatisme: Quebec and the Struggle for Soveregnity). Al netto degli isterismi progressisti, l’attualità della questione è ancora in questa tensione irrisolta tra libertà e appartenenza. Con tutti i paradossi del caso. Riconoscerli, anche grazie a libri come quello di Scott, e prenderli sul serio dovrebbe essere con sempre più urgenza condizione necessaria, pur se non sufficiente, per qualsiasi riformulazione democratica dell’ordine politico. Ossia delle condizioni e delle possibilità affinché “una particolare forma di vita sociale” possa essere ancora “plasmata dai valori e dall’esperienza di coloro che la compongono.” Qui, come altrove.