Dioniso, estasi e terrore
Chi è Dioniso? È il dio dell'estasi e del terrore; il dio della selvaggia frenesia e della più dolce liberazione; il dio folle che trascina gli umani nella sua follia.
È il dio misterioso e contraddittorio che rivela, fin dalla nascita, la sua fondamentale duplicità. Infatti è figlio di Zeus, il dio più grande, la forma delle forme del divino e di Semele, una semplice mortale tebana. Lei, la donna mortale, fu letteralmente folgorata dalla soverchiante presenza del dio, padre della creatura che portava in grembo. Per non perderlo Zeus si cucì in una coscia il feto e poi lo diede alla luce. Dioniso è quindi il nato due volte, e nato da donna e da uomo, oltre che, come detto, da mortale e immortale.
La sua pianta sacra, si sa, è la vite, ebbra di luce, figlia del caldo, che produce il vino, il nettare di fuoco che incendia corpo e anima. Ma anche l'edera è nondimeno sacra a Dioniso, con la sua natura fredda e i suoi inutili germogli d'ombra, che rinviano alla notte e alla morte. Le due forme vegetali stanno quindi in un eloquente rapporto di contrapposizione reciproca.
A sua volta il vino, che rappresenta proverbialmente l'essenza del dio, è anch'esso tremendamente ambiguo: capace di dare libertà, liberazione dal dolore (e “Liberatore” è uno degli epiteti più ricorrenti del dio), di dare conforto e beatitudine, pure, al contempo, è responsabile dell'ottenebramento più totale, come nel caso del centauro Eurizione, il cui senno sopraffatto dall'alcolica bevanda lo portò a compiere misfatti tali che lo consegnarono intero alla rovina.

Però quello che più sconvolge, in Dioniso, è la sua condizione di “deus patiens”. Egli è una divinità sofferente, caso unico tra gli Olimpici. Il dio subisce egli stesso gli atti terribili che compie. Se chi osa resistergli, come Penteo, viene letteralmente dilaniato dalle Menadi, sue fedeli seguaci (e il suo corteggio è sempre femminile), anche Dioniso medesimo, nella sua veste di Zagreo, patisce lo stesso affronto: il Grande Cacciatore viene cacciato e lo smembratore viene a sua volta smembrato (nella fattispecie dai Titani).
È per questo suo destino di patimento che è stato a lungo considerato come un antesignano di Cristo.
Il dio che afferra è afferrato. Analogo rovesciamento si verifica per le donne invasate che lo seguono abitualmente: la loro dolce maternità universale, che può riversarsi anche su creature animali, cerbiatti, e anche lupi e leoni, si muta repentinamente in furia selvaggia. Quelle stesse innocenti creature, prima allattate premurosamente vengono poi fatte a pezzi e divorate crude. Il sangue gronda dalle bocche delle Menadi furiose.
Da dove viene Dioniso? C'è chi dice che venga dall'Asia. Dalla Frigia, dalla Licia. Oppure dalla Tracia. Secondo altri è un dio autoctono. Per altri ancora la sua patria d'origine fu Creta. I mitografi, notoriamente, si contraddicono.
Ma che importa il luogo? Egli è ontologicamente “il dio che viene”. Anzi che sopravviene. La sua presenza è improvvisa. In qualunque momento e da qualunque luogo egli provenga, che arrivi dal mare su una nave prodigiosa o emerga dalle profondità, o che, neonato, apra all'improvviso gli occhi, il suo impeto si riversa sulle donne che lo hanno atteso e fa sì che rovescino il capo all'indietro, scuotano le chiome e diventino folli, proprio come lui, il dio della follia.
Il suo avvento, notturno o diurno, all'alba o al crepuscolo, è comunque tale che il suo fragore si converte fatalmente in silenzio. Un rumorosissimo silenzio, un silenzio eloquentemente chiassoso.
Anche la sposa di Dioniso, Arianna, conosce l'alternanza tra massima gioia e dolore straziante. Solo quando credeva di vivere nell'abbandono estremo, sull'isola di Nasso, lasciata da Teseo, e tutto pareva perduto, solo allora il dio sopravveniente, Dioniso con il suo corteggio giubilante, le si manifesta in tutto il suo fulgore e la ridesta alla beatitudine fra le sue braccia divine.
Questa sua duplicità di fondo si rispecchia nel simbolo che gli è peculiare, quello della maschera: egli è se stesso ed è un altro, presente e assente. Solo lui, tra le figure divine del vaso François, volge direttamente a chi guarda il suo volto spaventoso dai grandi occhi. Ma è solo la sua maschera, che nasconde e rivela. Noi moderni, che non vediamo nella maschera altro scopo che quello di essere portata, non riusciamo a capire. Ci siamo allontanati troppo dalle origini. Dall'originario carattere selvaggio dell'essere. Vediamo o crediamo di vedere, in Dioniso, un dio della vegetazione. Non ci accorgiamo nemmeno dell'assurdità di questo travisamento, dato che, nel culto dionisiaco, ci sono solo celebrazioni di “risvegli” e mai di “addormentamenti” della natura. Abbiamo confuso le manifestazioni della sua epifania con vicende di spostamenti e trasmigrazioni. Abbiamo dimenticato che, Dioniso, come tutti gli altri dei non è che “una forma originaria dell'essere”, in cui si manifesta “la libertà del mondo primigenio”, con il suo fondo inestricabile di oscurità e chiarezza, di contraddizione costitutiva, vitalmente costitutiva.
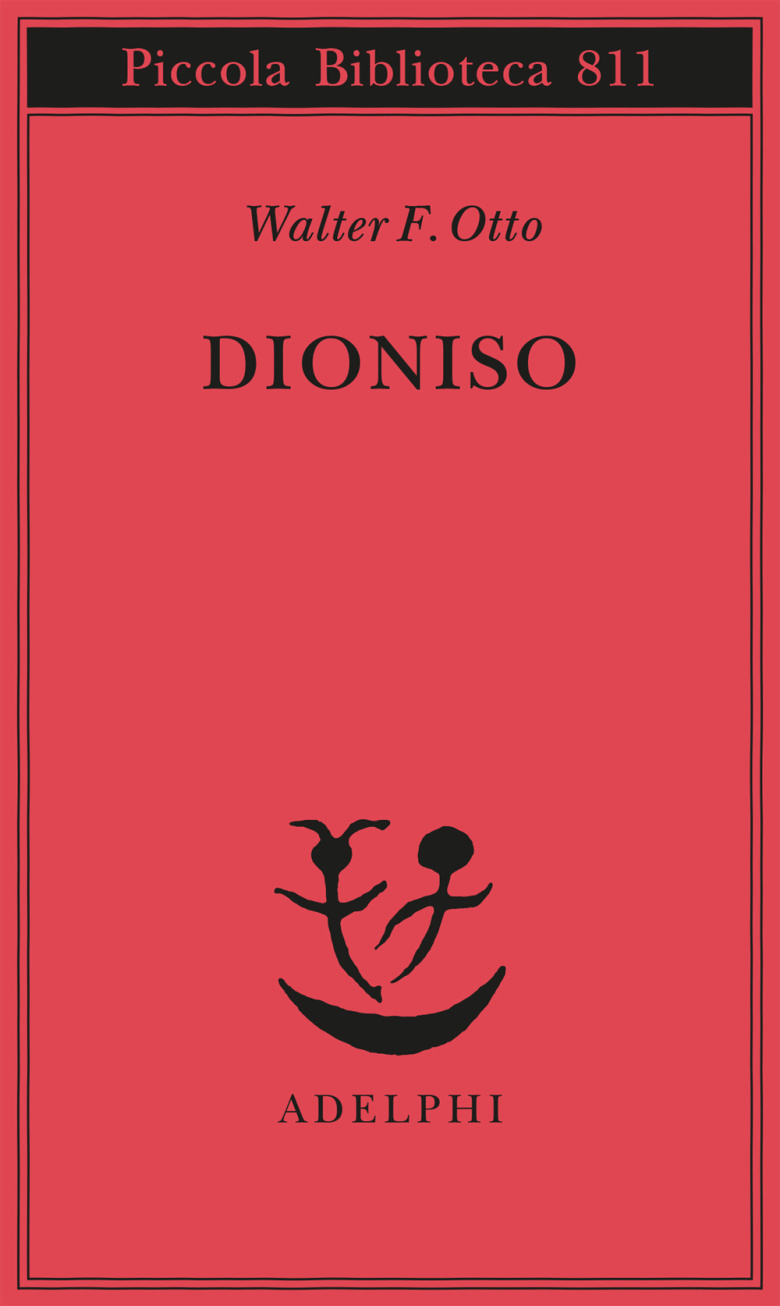
Tutto questo è una pallida eco delle pagine bellissime che, nel 1933, Walter Friedrich Otto consacrò a Dioniso e che adesso Adelphi pubblica a cura di Giampiero Moretti. Walter Friedrich Otto (da non confondere con Rudolf Otto, l'autore del celebre Das Heilige, Il sacro, con cui anzi qui polemizza, p.46 e ss.) era propriamente un latinista, addottoratosi nel 1898 con una tesi sui Nomina propria latina oriunda a participiis perfectis e che solo relativamente tardi, in età matura, si dedicò a ricerche sulla religione greca. La sua opera più famosa è quella che pubblicò nel 1929, a cinquantacinque anni, sugli Dèi della Grecia. (Tradotta nel 2004 da Adelphi, dalla cui postfazione, a cura di Giampiero Moretti e Alessandro Stavru, deduco le informazioni di cui sopra, e altre che utilizzerò in seguito).
L'interesse di Otto per questi temi non è di natura esclusivamente filologico-testuale, né, tanto meno, etnologica. Anzi, da quest'ultima tendenza, su cui all'epoca gravava ancora una pesante ipoteca positivistica, egli prende le distanze.
A Walter Friedrich Otto la religione greca preme per il suo valore filosofico-concettuale, ed anche esistenziale. Gli dèi antichi ci parlano. Parlano di noi. La nostra esperienza vitale ne è intimamente coinvolta. La loro è una presenza da cui siamo afferrati. Da Leo Frobenius, il grande africanista suo collega all'università di Francoforte, Otto toglie a prestito il concetto per l'appunto dell’Ergriffenheit, alla lettera: l'esser presi, l'esser afferrati. (Qui, a p. 56, il verbo “afferrare” ricorre per ben tre volte in una sola pagina). Noi siamo emozionati, colpiti, sconvolti anche, dalla presenza degli dei, che è immanente e non trascendente. Ciò che ci colpisce è la loro forma (Gestalt). L'uomo greco, caso unico nella storia, ha scelto di riconoscere e adorare il divino non nell'assolutezza della sua potenza, o saggezza o volontà, bensì nelle forme originarie della realtà. Il Greco celebra, nelle figure degli dei, la sacralità dell'ente in quanto ente. La forma umana assunta dal divino greco non è, come a torto si è creduto, una antropomorfizzazione del sovrannaturale, quanto una divinizzazione del naturale, e anche dell'umano.

Certo, dietro a Otto, stanno non solo Frobenius e Nietzsche (qui però contraddetto, p.265 e ss. dato che Apollo e Dioniso non sono visti tanto come polarmente disposti, quanto come complementari, dato che nel santuario di Delfi si venerava anche la tomba di Dioniso) ma anche Bachofen, Klages oltre che, fra gli altri, pensatori romantici come Schelling.
L'approccio di Otto venne naturalmente massacrato all'epoca della prima pubblicazione dei suoi testi, da studiosi come Nilsson, Pfister, Van der Leeuw e altri. Del resto, anche Nietzsche, si sa, quando pubblicò La nascita della tragedia venne massacrato dalla filologia ufficiale nell’autorevolissima persona di Ulrich Von Wilamowitz-Moellendorf.
Però il testo di Otto incontrò il gusto di Heidegger e, soprattutto, di molti giovani studenti che cercavano nel mondo greco non un vano pascolo di sterile erudizione ma un nutrimento vitale per la loro esistenza, perché, come scrive Salustio, il principale collaboratore di Giuliano Imperatore, nel capitolo quarto di Sugli dèi e il mondo (qui ricordato a p.101): “queste cose non avvennero mai, ma sono sempre”.









