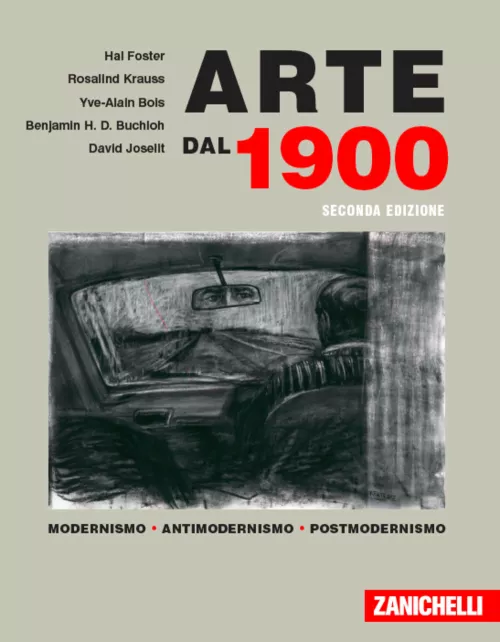La difficile situazione dell'arte contemporanea
Lo so, non toccherebbe a me scrivere di questo libro, essendone il curatore, non si tratta però di una recensione ma solo di informazioni che spero utili. Ricordo velocemente che il volume in questione, Arte dal 1900, uscì in prima edizione nel 2004, in traduzione italiana nel 2006. Scritto da quattro degli storici dell’arte contemporanea più accreditati e combattivi della scena internazionale, benché o proprio perché fortemente assestati su posizioni audaci, da allora non ha fatto che influenzare in un modo o nell’altro, per adesione o per reazione, comunque per vastità e varietà di temi, oltre che per la loro trattazione approfondita e stimolante, gli studi di settore di tutto il mondo, Italia compresa. Impostato per anni, invece che per movimenti artistici o decenni come è maggiormente d’uso nei manuali, ha anche reinventato questa formula accattivante e insieme significativa, benché scombini un poco le abitudini didattiche a cui siamo abituati.
È uscita da qualche mese la seconda edizione che qui vogliamo presentare, perché non è né una semplice ristampa né un aggiornamento da poco. Ai quattro autori – Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H. Buchloh e Hal Foster – se n’è infatti aggiunto un quinto, David Joselit, che l’ha arricchito di un apporto originale. In oltre 150 nuove pagine, l’arrivo di Joselit ha segnato l’entrata di nuovi temi attualissimi oggi, dalla multimedialità all’interattività, dal virtuale all’avatar. L’interessante è che a partire da questi temi di attualità gli autori hanno ricostruito la loro storia anche all’indietro, arricchendo il percorso storico di nuove voci, che riguardano dunque pupazzi-marionette-manichini, alter-ego e identità inventate da un lato, prime versioni dell’avatar elettronico, e interazione e multimedialità a confronto con l’evoluzione della pittura e della scultura – di cui molti si saranno chiesti alla lettura della prima edizione che cosa ne fosse nella considerazione e nella teoria di questi autori. Un ulteriore filone che viene rafforzato è il rapporto tra arte e mercificazione, sviluppo allora del readymade e dell’introduzione dell’oggetto e della riflessione sul contesto, e infine, naturalmente, l’attenzione per i nuovi protagonisti extra-occidentali della situazione artistica odierna, cinesi in primis, di cui vengono ricostruiti prodromi, e altri.
A noi non solo non è parso poco, ma è parso ragione ottima per segnalare agli attenti lettori e agli studiosi che di un vero aggiornamento si tratta qui e che la nuova edizione non va liquidata come pretestuosa operazione editoriale.
A titolo di sintesi di argomenti e tesi, abbiamo pensato ti proporre ai lettori di doppiozero la nuova versione del dibattito finale tra gli autori del volume, che restituisce bene “dal vivo” gli argomenti, il modo e il tono che caratterizzano il loro lavoro e punto di vista. Si noterà, per chi conosce già la prima edizione, come Joselit si inserisce nel dibattito tra gli altri e come riprende e rilancia collegandosi perfettamente all’insieme, ma apportandovi anche una posizione che non è scontata per gli altri.
Elio Grazioli
Ringraziamo l'editore Zanichelli la concessione del testo qui di seguito riprodotto.
(La discussione della tavola rotonda è originariamente avvenuta nel dicembre 2003. I partecipanti erano Yve-Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, Hal Foster e Rosalind Krauss. David Joselit ha contribuito con i suoi interventi nel settembre 2010.)
Rosalind Krauss: Abbiamo strutturato i nostri capitoli sull’arte del XX secolo attraverso le prospettive analitiche che ognuno di noi tende a favorire: quella di Hal è psicanalitica, quella di Benjamin storico-sociale, quella di Yve-Alain formalista e strutturalista, la mia post-strutturalista. Un modo per guardare indietro allo sviluppo dell’arte nel dopoguerra è quello di considerare cosa è accaduto agli strumenti metodologici, se la loro rilevanza è cresciuta o diminuita.
Yve-Alain Bois: Nessuno di noi ha sposato un metodo in particolare.
Hal Foster: Giusto: il mio interesse per la psicanalisi non è così forte come dici; spesso l’arte mi ha portato metodologicamente del tutto altrove. Ma la tua domanda è in realtà sul destino di questi diversi metodi nell’arte e nella critica del dopoguerra. Su questo punto, per quanto riguarda la psicanalisi, l’interesse dei surrealisti per l’inconscio continua dopo la Seconda guerra mondiale, ma su un registro più privato che politico. Molti artisti dall’Espressionismo astratto a Cobra cercano di aprire questo inconscio privato a una dimensione più collettiva; c’è uno spostamento, per esempio, dalla focalizzazione freudiana sul desiderio a un interesse junghiano per gli archetipi. Questa svolta viene presto bloccata, almeno negli Stati Uniti, dall’affermarsi della psicologia dell’io, che fa sorgere un’altra reazione. Un’avversione all’io privato come fonte della creazione è palpabile da John Cage, Robert Rauschenberg e Jasper Johns ai minimalisti: a diversi gradi cercano tutti di depsicologizzare l’arte e, di fronte all’opera molto carica di pathos degli anni Cinquanta, si può capire perché.
L’unica ironia del Minimalismo è che, nonostante il suo fare arte più pubblica nel contenuto, più oggettiva nel contesto, rimette anche in gioco il soggetto in una forma fenomenologica, incluso nello spazio.
Quando poi postminimalisti come Eva Hesse complicano questo soggetto generale, evidenziando come è segnato in modi diversi da immaginario, desiderio e morte, la psicanalisi fa il suo ritorno. Questo diventa esplicito negli anni Settanta, quando le artiste e teoriche femministe si chiedono come il soggetto sia diviso dalla differenza sessuale e come essa incida sia sul fare arte che sul fruirla. La psicanalisi è molto efficace per molte femministe, anche se non mancano di criticare i suoi presupposti, e lo stesso vale per alcuni artisti e teorici omosessuali, così come per alcuni critici postcoloniali.
Su un livello più astratto la psicanalisi ha fornito intuizioni sulle forme artistiche che altri modelli non colgono altrettanto bene, per esempio l’evocazione costante dell’“oggetto parziale” da Duchamp, via Johns, Louise Bourgeois, Hesse e Yayoi Kusama, fino a molto artisti recenti. Comunque la psicanalisi non è molto importante nel dopoguerra: la sua presenza cresce o diminuisce secondo l’avanzare o recedere dell’interrogazione sulla soggettività e sulla sessualità.
YAB: Il destino degli strumenti metodologici del formalismo e dello strutturalismo nel dopoguerra è in parte discusso nella mia introduzione. Lì traccio la trasformazione di una concezione morfologica del formalismo (alla Roger Fry prima della guerra, ma rivista da Clement Greenberg nel dopoguerra) in una strutturalista, poi quella della posizione strutturalista in una “poststrutturalista”, che Rosalind a sua volta spiega nella sua introduzione. Lì discute come molti artisti a metà degli anni Settanta e all’inizio degli Ottanta abbiano trovato nel “Poststrutturalismo” un potente alleato teorico che li ha aiutati ad affrontare le questioni della loro opera. (Se metto tra virgolette “Poststrutturalismo”, come faccio con “postmodernismo”, è perché, per quanto ne so, il termine non è mai stato usato dagli autori indicati da questa etichetta.) Qui vorrei sottolineare che lo Strutturalismo ha lasciato un segno anche sulla produzione artistica degli anni Sessanta. Sappiamo che un certo numero di artisti a New York leggevano Roland Barthes e Claude Lévi-Strauss (per esempio i loro libri c’erano nella biblioteca di Robert Smithson) e, cosa forse più importante, i romanzi del Nouveau roman francese (come quelli di Alain Robbe-Grillet), scritti in contesto strutturalista (Barthes era il più grande sostenitore dei primi romanzi di Robbe-Grillet). In molti modi l’antisoggettivismo, che è un elemento essenziale dello Strutturalismo, fu parallelo alla tendenza depsicologizzante, appena ricordata da Hal, di molti artisti in opposizione al pathos dell’Espressionismo astratto negli Stati Uniti e dell’Art informel in Europa. La tendenza anticompositiva che caratterizza tanta arte prodotta dalla metà degli anni Cinquanta fino al Minimalismo – atteggiamento seriale, interesse per i procedimenti indicali, monocromo, griglia, caso, ecc. – va mano nella mano con la ribellione dello Strutturalismo contro l’Esistenzialismo.
Questo mi porta all’altra metodologia nominata da Hal, che non appare nel nostro quartetto: la fenomenologia. È molto interessante che la Fenomenologia della percezione di Maurice Merleau-Ponty sia diventato il libro di riferimento per molti artisti americani (per esempio Robert Morris) e critici (per esempio Michael Fried) subito dopo la sua pubblicazione in inglese nel 1962. La formazione teorica di Merleau-Ponty era identica a quella di Sartre e del suo Esistenzialismo (il testo fondamentale per entrambi fu il lavoro teorico di Edmund Husserl), ma Sartre ebbe un fascino limitato sugli artisti (principalmente in Europa e per breve tempo). Forse perché – diversamente da Merleau-Ponty, che scrisse bene di Ferdinand de Saussure – rimase ostile alla posizione strutturalista (per non parlare della sua posizione imbarazzata riguardo alla psicanalisi). In altre parole, Sartre continuò a presupporre un “soggetto libero” e così rimase in parte prigioniero della filosofia classica della coscienza ereditata da Cartesio. Non era perciò in sintonia con ciò di cui si occupavano molti artisti dopo l’Espressionismo astratto (il suo sostenitore nel mondo dell’arte americano fu Harold Rosenberg, a sua volta indentificato con la versione “pathos” dell’estetica espressionista astratta). Per contrasto, Merleau-Ponty, anche se aveva poca conoscenza dell’avanguardia artistica del suo tempo (le sue pagine migliori sull’arte riguardano Cézanne), toccò dei punti che risuonarono con gli interessi degli artisti degli anni Sessanta.
RK: Hal, quando Yve-Alain ed io abbiamo curato la mostra L’informe: istruzioni per l’uso al Centre Pompidou di Parigi nel 1996, abbiamo messo in primo piano l’operazione dell’“informe” in un gran numero di produzioni artistiche da Duchamp a Mike Kelley; per comprendere questo informe, fu importante per noi ripensare i problemi della “desublimazione” e la psicanalisi era ancora fresca, ancora urgente, per quell’investigazione.
YAB: È questione degli usi diversi che si fanno dello stesso modello. Anche questo è qualcosa che abbiamo appreso da Georges Bataille, da cui abbiamo preso l’anticoncetto di informe. Bataille si è opposto al modo letterario in cui André Breton ha applicato la psicanalisi nel suo Surrealismo, riducendo il discorso dinamico di Freud a una raccolta di miti e simboli. Per Bataille i simboli e i miti andavano contestati; sono illusioni, sul versante dell’ideologia dominante della rappresentazione, e la psicanalisi è uno strumento per dissezionarli e dissiparli. Il suo lavoro ci ha forzato a ripensare quali aspetti della psicanalisi possono parlare alle pratiche artistiche che ci interessano, come può essere usata per configurare un diverso insieme di oggetti e concetti che non si trovano in altri tipi di interpretazioni – in parte perché non coinvolti in un’operazione di desublimazione. Forse è questo il progetto di ognuno di noi in questo libro: suggerire diversi tipi di riconfigurazione.
Per Bataille lo stesso modello poteva essere usato in modo conservatore o in modo rivoluzionario (suppongono che oggi non useremmo questo termine); è una costante in tutti i suoi testi riguardanti non solo la psicanalisi, ma anche il Marxismo, Nietzsche, de Sade e quasi tutti gli altri sistemi filosofici o modelli interpretativi che ha discusso. Penso che questo sia legato al nostro tipo di approccio qui. Per esempio, Hal ha scritto un saggio all’inizio degli anni Ottanta che sottolinea che ci sono due tipi di “postmodernismo” in arte, uno autoritario e uno progressista, e ha scritto anche in modo simile sulle diverse eredità del Costruttivismo russo e del Minimalismo. Questo va di pari passo con quello che ho detto a proposito dei due tipi di formalismo, uno morfologico e uno strutturale.
HF: Forse la “desublimazione” è un modo per sollevare la questione della storia sociale dell’arte nel dopoguerra. L’attacco alla Bataille alle forme reificate e ai significati codificati è una delle versioni del processo, ma c’è anche lo spettro della “desublimazione repressiva” nel senso marxista di Herbert Marcuse. Quali sono gli effetti sociali quando le forme artistiche e le istituzioni culturali sono desublimate: per esempio quando sono fatte esplodere dalle energie libidinali? Non è sempre un evento liberatorio: può anche aprire queste sfere a una ricanalizzazione spoliticizzata del desiderio da parte dell’“industria culturale”.
Benjamin H. D. Buchloh: Come ho sviluppato nella mia introduzione, la dialettica di sublimazione e desublimazione gioca un ruolo importantissimo nella storia dell’arte del dopoguerra. Forse è anche una delle dinamiche centrali del periodo, certamente più che nella storia delle avanguardie dell’anteguerra. È definita diversamente dai differenti teorici, sia come strategia avanguardista di sovversione sia come strategia dell’industria culturale per incorporare e sottomettere. Un asse su cui questa dialettica viene condotta nel dopoguerra in modo più programmatico che mai è il rapporto della neoavanguardia con l’apparato in espansione del dominio dell’industria culturale: come negli anni Cinquanta, nel contesto dell’Independent group in Gran Bretagna, per esempio, o nella prima Pop art negli Stati Uniti, quando l’appropriazione dell’immaginario e delle strutture della produzione industriale divenne uno dei metodi con cui gli artisti cercarono di riposizionarsi tra un fallito modello umanista di aspirazioni avanguardiste e un apparato emergente il cui potenziale totalitario poteva non essere del tutto visibile all’inizio. La desublimazione in Gran Bretagna servì come strategia radicale insieme per rendere popolare la pratica culturale e per analizzare le condizioni dell’esperienza collettiva della pervasiva cultura di massa. La desublimazione in Andy Warhol, per contrasto, operò più all’interno del progetto di un annichilimento finale di qualsiasi aspirazione politica e culturale che potessero ancora nutrire gli artisti dell’immediato dopoguerra.
Per quanto schematico possa apparire, il mio lavoro è situato metodologicamente tra due testi: uno del 1947, La dialettica dell’Illuminismo di Theodor Adorno e Max Horkeimer, in particolare il capitolo “L’industria culturale”, e l’altro del 1967, La società dello spettacolo di Guy Debord. Più penso a questi testi e più mi sembra che storicizzino gli ultimi cinquant’anni di produzione artistica, perché dimostrano come gli spazi autonomi della rappresentazione culturale – spazi di sovversione, resistenza, aspirazione utopica – sono gradualmente erosi, assimilati o semplicemente annientati. È quello che è accaduto nel dopoguerra con la trasformazione delle democrazie liberali negli Stati Uniti e in Europa: dal mio punto di vista si è amaramente realizzata non solo la prognosi di Adorno e Horkeimer del 1947, ma anche quella ancor più nichilista di Debord del 1967, perfino superata. La situazione del dopoguerra può essere descritta come una teleologia negativa: un continuo smantellamento di pratiche, spazi e sfere autonome della cultura e una perpetua intensificazione dell’assimilazione e omogeneizzazione, al punto che oggi assistiamo a quello che Debord ha chiamato lo “spettacolo integrato”. Dove vanno le pratiche artistiche oggi e come possiamo, in quanto storici e critici d’arte, indirizzarle? Esistono ancora spazi al di fuori dell’apparato omogeneizzante? O dobbiamo riconoscere che gli stessi artisti non si vogliono situare al di fuori?
HF: Siete d’accordo con il carattere definitivo di questa analisi?
YAB: È una diagnosi terribile (dopo tutto Debord si è suicidato), ma penso che tutti noi la condividiamo in qualche misura.
HF: Sì, ma se siete completamente d’accordo con Adorno e/o Debord, si può dire qualcosa di più.
BB: Prendo sul serio l’ultima affermazione che ho fatto: non concludo che tutti gli artisti oggi definiscono la propria opera come inestricabilmente integrata e affermativa. Può ancora esistere la capacità artistica non solo di riflettere sulla posizione che l’opera d’arte assume nel sistema più ampio di rappresentazioni infinitamente differenziate (moda, pubblicità, intrattenimento, ecc.), ma anche di riconoscere la sua suscettibilità di venire integrata in questi sottoinsiemi di controllo ideologico. Inoltre, se esistono pratiche artistiche che stanno ancora al di fuori del processo di omogeneizzazione, sono meno convinto che possano sopravvivere e che noi critici e storici possiamo sostenerle e supportarle in modo sostanziale ed efficace per prevenire la loro totale marginalizzazione.
David Joselit: Vi è un approccio metodologico che accetta la struttura dello spettacolo come nuovo contesto visivo in cui agire, dove le opere d’arte sono riconosciute come un tipo di immagine tra le altre, dal cinema e dalla televisione a Internet e ai cellulari. Influenzato da un lato da figure dei media studies come Lev Manovich e dall’altro dalla teoria dell’attore-rete di Bruno Latour, questo approccio è incentrato meno sulla critica in sé, che implica negazione, e più sulle nuove configurazioni di associazione produttive di nuove reti, o – per rimandare a Debord – di nuove situazioni. Latour usa una magnifica espressione che ricorda il museo: “riassemblare il sociale”. Con questa espressione insiste che non esiste nessuna stabile versione unificata del “sociale” che attende di essere scoperta e sovvertita, che non c’è nessuna comunità ready-made, ma soltanto configurazioni di associazione, di rapporti che possono essere assemblati o “collezionati”. Questa prospettiva è utile per individuare un’ampia gamma di tendenze e opere nell’arte contemporanea. Molti artisti lungo il XX secolo, ma soprattutto dagli anni Sessanta in poi, hanno cercato di forgiare comunità alternative attraverso l’arte.
Questo è chiaro all’inizio della storia della Video art, che non solo cercò alternative alla televisione commerciale e nuove esperienze fenomenologiche per lo spettatore, ma spesso riguardò anche disposizioni e strutture di lavoro, un tipo di organizzazione cellulare strutturalmente analoga alle reti mediali. Più recentemente molte pratiche artistiche collettive e sperimentali che sono talvolta messe sotto la categoria di “estetica relazionale” sono incentrate sull’associazione come atto estetico.
I cosiddetti nuovi media, e soprattutto la capacità di replicare e riformattare immagini digitali, offrono un’opportunità per ripensare le nostre concezioni del valore dell’arte in quanto derivante dalla sua rarità o scarsità. Come concorrenti nell’industria culturale, figure come Warhol – o Matthew Barney – hanno insegnato a diffondere immagini a una scala che si avvicina a quella della cultura popolare. Oggi, in condizioni in cui gli artisti devono costruire una sorta di “marchio” che sia riconoscibile in un mondo dell’arte globalizzato, la distribuzione e la “saturazione” dei mercati ritrovano un nuovo interesse.
HF: Guardiamo indietro al di là degli ultimi decenni agli esempi in cui le alternative critiche furono proposte. Indicando qualche “progetto incompleto”, possiamo aiutarci a guardare avanti.
BB: Sì: che posto ha la pratica della neoavanguardia nel presente, paragonato a quello che aveva nel 1968, per esempio? O anche negli anni Settanta, quando la relativa autonomia di tale pratica aveva un ruolo nella sfera pubblica borghese liberale come luogo di differenziazione dell’esperienza e della soggettività? Poi venne sostenuta, o almeno presa sul serio, dallo stato, dai musei e dalle università. Così negli anni Ottanta la produzione artistica fu integratanella pratica più generale dell’industria culturale, dove ora funziona come merce, investimento e intrattenimento. Da questo punto di vista vedi come Matthew Barney, ancor più che Jeff Koons, ha espresso – cioè sfruttato – queste tendenze. In questo senso per me è un artista protototalitario, un dilettantesco Richard Wagner americano che mitizza le catastrofiche condizioni di esistenza nel tardo capitalismo.
HF: Di nuovo, possiamo complicare ulteriormente la posizione adorniana secondo cui la sfera culturale totalitaria è semplicemente continuata nell’industria culturale americana e questa industria ha completamente integrato l’arte?
YAB: Esistevano espressioni forti di libertà artistica in seguito al 1968 – e anche prima...
BB: Certo, c’era un’importante cultura artistica negli Stati Uniti del dopoguerra, dall’Espressionismo astratto, attraverso la Pop art e il Minimalismo, fino almeno al Concettualismo. Va tenuto in conto. Perché fu possibile? Perché gli Stati Uniti erano una democrazia liberale al suo più alto livello di differenziazione. Ma non più.
HF: Altre possibilità si sono aperte in altre parti del globo, soprattutto in vari incontri tra diversi modernismi. Per esempio, Yve-Alain discute dell’elaborazione del Costruttivismo nel Neoconcretismo in Brasile, così come della performance dopo Pollock con il gruppo Gutai in Giappone. Già queste pratiche complicano la vecchia storia del puro spostamento dall’Europa al Nordamerica o, ancora più riduttivamente, da Parigi a New York. È un racconto alternativo della différance culturale, delle pratiche d’avanguardia in altri spazi-tempi.
YAB: All’inizio tuttavia il paradigma usuale non è cambiato molto: almeno per due decenni queste attività d’avanguardia in vari continenti si definiscono ancora in rapporto ai vecchi centri. Per esempio, i brasiliani guardano ancora a Parigi e Gutai a New York, soprattutto a Pollock, che leggono attraverso le fotografie di Hans Namuth. È solo più tardi, una volta che hanno avuto un po’ di storia nel loro modo di lavorare, che stabiliscono un rapporto competitivo con i vecchi centri. A questo livello il 1968 segna una data molto importante: c’è una straordinaria internazionalizzazione non solo della ribellione politica, ma anche dei suoi prodotti artistici, con fermento sociale in tutta Europa, Stati Uniti e ovunque (la Primavera di Praga e la sua ripercussione nell’Unione Sovietica; la convenzione democratica di Chicago seguita da violenti scontri, e così via), tutto nel contesto della Guerra del Vietnam. Fu un forte elemento politico unificatore per le menti progressiste nel mondo, non dimentichiamolo. Certi aspetti delle presenti e recenti situazioni politiche ricordano un po’ quel periodo, soprattutto il fatto che l’amministrazione Bush ha unificato molte parti del mondo contro l’imperialismo americano. Resta da vedere, naturalmente, se questo “internazionalismo negativo” avrà conseguenze dirette nella sfera culturale.
DJ: La cosiddetta globalizzazione del mondo dell’arte ha reso molto diversa la “direzionalità” dell’influenza nell’arte contemporanea. Da un lato, penso che si possa fare un esempio forte, quello cioè che esiste oggi uno stile internazionale, che potremmo chiamare “Concettualismo globale” dal titolo dell’importante mostra organizzata dal Queens Museum di New York nel 1999.
Dall’altro lato, si potrebbe essere cinici e sostenere che i materiali dell’Arte concettuale – testo, fotografia e video – viaggiano più agevolmente (e a costi più bassi) dei media tradizionali della pittura e della scultura, come naturalmente l’importante curatore e “impresario” dell’Arte concettuale Seth Siegelaub riconobbe già a suo tempo. Ma è altrettanto importante che questo “linguaggio” condiviso sia soffuso di inflessioni (o accenti) locali. Come sostengono James H. Gilmore e B. Joseph Pine nel loro libro Autenticità: quello che il consumatore vuole veramente, del 2007, l’implacabile standardizzazione che l’industria culturale impone genera anche una sorta di domanda compensatoria di “customizzazione”, di “autenticità”. Credo che questi effetti si siano visti nel mondo dell’arte contemporanea.
Per esempio come i grandi poteri “socialisti”, l’Urss e la Cina, hanno cominciato a entrare nei mercati globali capitalisti – la rinata Russia all’inizio degli anni Novanta e la Cina alla fine dei Novanta e inizio dei Duemila – e come vi fu un’enorme fascinazione per queste opere e un loro corrispondente boom di mercato. Da un lato potremmo condannarlo come un altro mero esempio in cui l’opera d’arte serve da avanguardia economica – creando nuovi mercati culturali per superpoteri economici emergenti – ma il fascino che queste opere (e quelle di molti altri paesi) ispirano in Occidente è anche una forma di curiosità in buona fede. Esse formano un’avanguardia di traduzione culturale che aiuta a introdurre sistemi non familiari di valori e significati attraverso la retorica familiare dell’Arte concettuale.
HF: Molto prima del 1968, il periodo prima della guerra vide la risurrezione internazionale di alcuni movimenti – come Dadaismo, Surrealismo e Costruttivismo – che fin dall’inizio furono internazionali nelle ambizioni. Anche il Bauhaus ha avuto diverse risurrezioni in diversi luoghi dopo la Seconda guerra mondiale. Questo è ulteriormente complicato da un movimento centrifugo rispetto a Parigi e New York. Cobra per esempio inizia un parziale spostamento da Parigi ad altre città europee; e più tardi, per fare un altro esempio, nasce l’Arte povera in Italia. Così vi è una rimappatura dell’Europa, una relativizzazione di Parigi come capitale d’arte, fragile ma significativa. Lo stesso vale anche per gli Stati Uniti, con una relativizzazione simile di New York, soprattutto da parte degli artisti della California, la performance beat e gli artisti dell’assemblage di San Francisco e Los Angeles, e anche la Pop art tarda e gli astrattisti californiani.
BB: Sì, ma allora, se torniamo al presente, cosa vediamo? Guarda Michael Asher, per molti versi la figura più radicale di quelle impegnate nella critica istituzionale dalla fine degli anni Sessanta in poi e a lungo attivo a Los Angeles: la sua opera è ora per lo più dimenticata; la stessa radicalità della sua contestazione sembra dimenticata. Chiaramente la complessità dell’opera di Asher sembra porre, ora più che mai, ostacoli insormontabili alla sua ricezione all’interno dei parametri attuali del mondo dell’arte. Così, come con la repressione sociale in generale, il modo di rispondere all’opera è semplicemente quello di sradicarla dalla memoria storica e isolare i suoi produttori come outsider. Daniel Buren, un altro artista radicale della critica istituzionale, è il suo pendant dal lato europeo, solo che Buren ora si è trasformato, di buon grado, in un affermativo artista di Stato per evitare il destino che ha segnato Asher.
HF: Ancora una volta, il vostro racconto può essere complicato ulteriormente? Non comporta una teleologia riduttiva e disfattista?