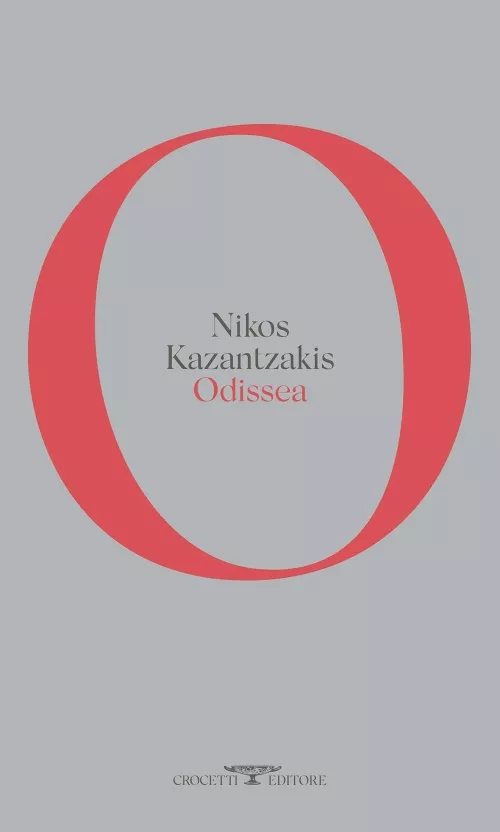La “santa infedeltà” dell’Ulisse / L'Odissea di Kazantzakis
Anche chi non ha mai visto per intero il film Zorba il greco (1964), diretto da Michael Cacoyannis e interpretato da Anthony Quinn, avrà in mente la famosa scena (più volte riproposta nei media) della danza sulla spiaggia, e soprattutto la colonna sonora di Mikis Theodorakis, che rese popolare in tutto il mondo la musica greca (impropriamente chiamata sirtaki). Non so quanti ricorderanno, invece, che il film è tratto dal romanzo omonimo del cretese Nikos Kazantzakis (1883–1957), pubblicato nel 1946 e tradotto in italiano nel 1955. (A un’altra opera dello stesso autore, L’ultima tentazione, si ispira il film di Martin Scorsese L’ultima tentazione di Cristo, del 1988).
La popolarità di Kazantzakis presso i lettori italiani, oltre che limitata, è comunque legata quasi esclusivamente alla sua produzione in prosa. Questo rende ancora più sorprendente – e ardita, e meritoria – la pubblicazione, nella bella traduzione italiana di Nicola Crocetti, del suo poema Odissea (uscito in Grecia nel 1938). L’iniziativa assume un rilievo ulteriore quando si pensa che l’opera, articolata in 24 canti, consta di ben 33.333 versi (decaeptasillabi, un metro del tutto inusuale nella prosodia neogreca) per un totale – nell’edizione italiana – di quasi ottocento pagine.
La narrazione di Kazantzakis riprende – come quella di Dante nel canto XXVI dell’Inferno che in parte (ma solo in parte, come vedremo) le fa da modello – dalla irrequietezza di Ulisse una volta tornato a Itaca. Nella sua terra, finalmente raggiunta e riconquistata, l’eroe non si sente appagato. Per sondarne le ragioni, e per dare un assaggio della poetica dell’autore cretese, è opportuno citare alcuni versi (951-962) del Canto XVI. È Ulisse a parlare:
La patria mi stava stretta, sentivo oltre le sue rive
altre patrie dagli occhi ridenti, altre anime carnose,
tristezze e gioie di ogni sorta, fratelli e sorelle,
che sedute sulle rive aspettavano il mio ritorno!
Che tu sia benedetta, vita, per non essere rimasta
fedele a un solo matrimonio, come una donnicciola;
è buono il pane del viaggio e l’esilio è miele,
per un istante eri felice, godevi ogni tuo amore,
ma presto soffocavi, e a ogni amante dicevi addio.
Anima, la tua patria è sempre stata il viaggio!
La virtù più fertile al mondo, la santa infedeltà,
segui fedele tra risa e pianti, e più in alto sali!
L’Ulisse di Kazantzakis, come si vede, si discosta non poco da quello dantesco. A spingere l’eroe del XXVI Canto dell’Inferno a riprendere il mare e a varcare i confini del mondo è “l’ardore/ ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto/ e delli vizi umani e del valore”; oltre che dalla sete di conoscenza (hybris ma anche virtù, in Dante), il personaggio di Kazantzakis è mosso da un irrefrenabile impulso a liberarsi di ciò che è consueto e convenzionale (“borghese”, verrebbe da dire), a trasgredire sistematicamente le prevedibili virtù di un figlio, di un padre, di uno sposo, di un amico. È un eroe amorale, se non antimorale, paradossalmente “fedele” alla “santa infedeltà”, che celebra nei versi citati come “la virtù più fertile al mondo”. Più che a Dante, il poeta cretese sembra rifarsi a Nietzsche, altro autore da lui amato e tradotto.
In effetti, il primo episodio del nuovo viaggio di Ulisse ha tutta l’aria di un exploit superomistico: l’eroe si reca a Sparta, dove ritrova il suo vecchio compagno di avventure Menelao, invecchiato e rammollito; la compassione per l’amico e il rispetto per l’ospite non lo frenano: senza farsi troppi scrupoli, seduce sua moglie Elena (Seduttore è uno dei molti nuovi epiteti che Kazantzakis inventa per il suo eroe), la rapisce (col consenso di lei) e la porta a Creta, seconda tappa del viaggio.
Nelle sue nuove avventure, Ulisse non è affiancato dalla generica e anonima “compagna/ picciola da la qual non fui diserto” di cui parla Dante; i membri del suo equipaggio hanno un nome, e sono lontanissimi dal cliché dell’eroe mitologico: Capitan Conchiglia è un anziano marinaio, Centauro un grassone di buon cuore; Bronzista è il maniscalco del palazzo di Itaca, Orfeo (a dispetto del nome) è un flautista un po’ matto; e così via. Nell’accostamento di personaggi umili e “comici” al sublime protagonista, Kazantzakis sembra rifarsi al Don Chisciotte di Cervantes (altro autore amato), che peraltro il suo Ulisse incontrerà nel corso del viaggio, sotto le spoglie di Capitan Uno.
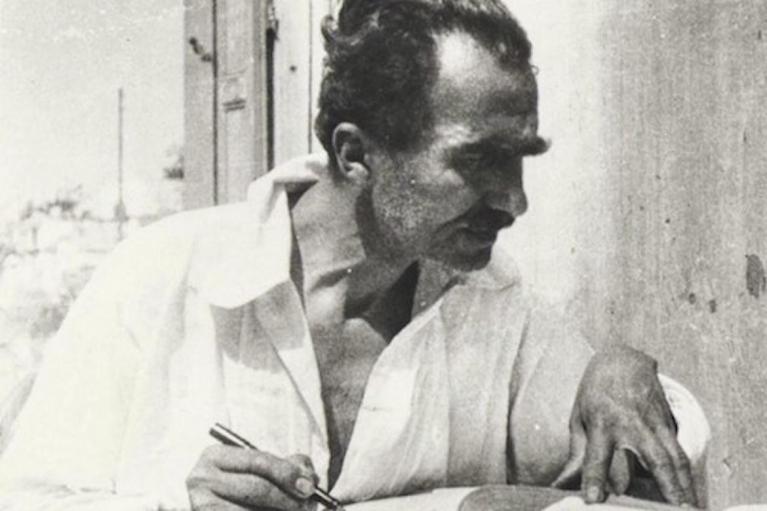
A Creta, Ulisse rovescia il regno già declinante di Idomeneo, anch’egli suo vecchio compagno nell’assedio di Troia. Cnosso viene data alle fiamme. L’eroe abbandona Elena, e la spinge a unirsi a un barbaro (un giardiniere biondo) dando alla luce Elleno, simbolo dell’innesto di due civiltà. Nemmeno a Creta, però, l’eroe di Kazantzakis trova pace. La terza tappa del suo viaggio è Eliopoli, in Egitto. Anche qui cerca di rovesciare un regno, quello del Faraone. Viene catturato, si libera con una delle sue astuzie, risale il corso del Nilo verso le sorgenti, fonda una nuova città, una città ideale ispiratagli da una mistica visione. Appena fondata, la città viene distrutta da un terremoto. Ulisse scaglia una tremenda invettiva contro Dio. Il viaggio prosegue attraverso l’Africa, in direzione Sud.
Durante il cammino incontra fra l’altro Capitan Uno (Don Chisciotte, come abbiamo già ricordato) e il Pescatore Gentile (Gesù Cristo). Come nel Canto XXVI della Commedia, il punto d’arrivo dell’estrema avventura di Ulisse è il Polo Sud, che egli raggiunge, ormai morente, a bordo di una barca-bara. L’unica sua compagnia è la Morte (che in un precedente episodio, nel Canto VI, addormentata tra le sue braccia, “ha avuto un incubo: la vita”). Ulisse, giunto alla fine, richiama attorno a sé tutti i personaggi della sua esistenza, poi con una grande risata muore, trasformandosi in pura fiamma, luce, spirito. Il poema si chiude – così come è iniziato – con un’invocazione al Sole.
Il personaggio di Ulisse, come sappiamo, è stato al centro di varie rivisitazioni, in particolare nel Novecento. La più famosa, quella di Joyce, esce nel 1922, tre anni prima che Kazantzakis metta mano alla sua Odissea. Tra i due “rifacimenti”, comunque, le distanze sono notevoli: mentre Joyce – come sappiamo – trasferisce le vicende dell’eroe nella contemporaneità, e le concentra in una sola città, in una sola giornata, abbassandole e in parte parodiandole, il poeta cretese concepisce il suo poema come una diretta continuazione ed espansione delle avventure di Ulisse, mantenendo e anzi potremmo dire intensificando il tono epico-sublime dell’originale.
Quando viene pubblicata, nel 1938, l’Odissea di Kazantzakis riceve una pessima accoglienza nell’ambiente letterario greco. Non è solo il titolo – che già di per sé suona arrogante e quasi blasfemo – a scandalizzare i critici: a sconcertarli e a irritarli è la mole abnorme dell’opera (5.527 versi più dei due poemi omerici messi insieme), l’uso di un metro inusuale (il decaeptasillabo, scelto per riecheggiare l’esametro omerico), l’introduzione di vocaboli stravaganti e “impuri” (molti lo accusano di scrivere “in cretese”, ma in verità l’autore li ha raccolti in tutta la Grecia) e l’adozione di una sintassi e di un’ortografia anomala (la riforma ortografica della lingua neogreca era di là da venire).
Kazantzakis, che Crocetti ha il merito di far conoscere ai lettori italiani con questa traduzione (e con altre precedenti), è una figura davvero impressionante, per qualità, varietà e mole di lavoro. Nato a Iraklio, nell’isola di Creta, nel 1883, figlio di un commerciante di prodotti agricoli rozzo e autoritario (“un mostro” lo definisce il figlio), fin da ragazzo mostra la sua forte inclinazione allo studio. Ad Atene frequenta la facoltà di giurisprudenza; dal 1907 al 1909 è a Parigi, dove studia filosofia, frequentando le lezioni di Bergson. Nel 1909 pubblica a Creta una dissertazione intitolata Friedrich Nietzsche e la filosofia del diritto. Il viaggio caratterizza tutta la sua vita (“Anima, la tua patria è sempre stata il viaggio!”): nel 1917 è in Svizzera, a Zurigo, poi a Vienna, a Berlino, in Italia; percorre tutta la Grecia, collezionando parole rare e desuete (che inserirà nel suo poema); nel 1925 (anno in cui inizia a scrivere l’Odissea) visita la neonata Unione Sovietica, dove tornerà a più riprese; come giornalista si reca in Palestina, in Spagna, in Egitto, in Inghilterra, e nei suoi ultimi anni, già gravemente malato, in Giappone e in Cina. Nel frattempo – ma dove lo trova, il tempo? – traduce tra gli altri Bergson, Nietzsche, William James, Darwin, Maeterlinck, Platone, Goethe, Shakespeare, i nuovi poeti spagnoli, oltre ai poemi omerici e alla Commedia di Dante.
Il suo percorso culturale è tanto fervido quanto eclettico: a elementi di forte spiritualità (cristiana, e non solo) vi si mescola l’attrazione per il socialismo (la figura di Lenin, in particolare) e per il pensiero di Nietzsche. Particolarmente significativa è la sua opera filosofica intitolata Ascetica. I salvatori di Dio (1927), dove – come riassume in una lettera alla moglie del 1923 – si pensa a un Dio che “non è onnipotente, così che noi possiamo stare a braccia conserte aspettando la sua vittoria certa. La sua salvezza dipende da noi, e soltanto se lui si salva ci salveremo anche noi”.
La traduzione del poema-fiume di Kazantzakis ha richiesto sette anni di lavoro a Nicola Crocetti. Nato a Patrasso nel 1940 da madre greca e padre italiano, milanese di adozione, Crocetti è, oltre che traduttore (è lui ad averci fatto conoscere le opere dei massimi poeti greci contemporanei), uno dei più importanti editori italiani di poesia. In un’intervista rilasciata a “La Lettura” (15 novembre 2020) parla delle difficoltà – e delle soddisfazioni – di questa impresa immane. Uno dei tanti problemi è quello posto dalle stravaganze lessicali di Kazantzakis, dai vocaboli rari e desueti tratti da tutti i dialetti greci, dall’introduzione di nuovi composti come gli aggettivi mygdalogelàstra (“che ride come un mandorlo”) o krysolampadòkormi (“dal corpo snello e d’oro”). Per la sua traduzione, come dichiara, ha fatto riferimento a quella inglese (1958) realizzata da Kimon Friar in collaborazione con l’autore. Per ovvie ragioni di spazio, il volume non riporta il testo originale a fronte; ma a differenza che in molti testi poetici tradotti da lingue straniere, qui il lettore non avverte gli inciampi e le forzature del “traduttese”, non sente mai la necessità di verificare il ritmo del testo di partenza: i versi di Crocetti scorrono vivi, armoniosi ed eleganti come se l’autore stesso li avesse concepiti nella nostra lingua. Non è un merito da poco.