Sereni, Mengaldo e la vergogna della sua poesia
Nella Nota alla nuova edizione dei suoi fondamentali saggi dedicati a Sereni (la precedente è del 2013, sempre per Quodlibet), Pier Vincenzo Mengaldo riporta un aneddoto già noto, ma illuminante: la moglie del poeta sta leggendo a una delle figlie una sua poesia (Sereni è nel suo studio, lì accanto). Terminata la lettura, e esposta la propria interpretazione, chiede al marito: “È così, Vittorio?”. Il poeta risponde: “Anche”.
“Anche,” – commenta Mengaldo – “eccellente categoria non solo per la sua poesia ma, si può dire, per l’intera lirica della modernità”.
Gli studi di Mengaldo intorno a Sereni si muovono nel rigoroso rispetto di quell’apertura. Anche quando scava a fondo nei testi, rivelandone caratteri, rimandi e strutture che a una lettura superficiale resterebbero nascosti, il critico non impone mai un’interpretazione definitiva, dall’alto. Questo atteggiamento si rispecchia perfettamente nel titolo scelto: non scritti su, ma per Vittorio Sereni.
In effetti, queste pagine colpiscono proprio per la non comune tensione affettiva che ne emana: oltre che uno dei suoi maggiori interpreti, Mengaldo è stato amico intimo del poeta, e nel libro ce ne offre un ritratto vivissimo, pieno di ammirazione e di emozione.
I due saggi collocati all’inizio del volume, Ricordo di Vittorio Sereni (1983) e Vittorio Sereni (1978), mettono a fuoco – oltre all’opera – la personalità dell’autore. Più che per altri poeti, questa attenzione sembra opportuna, anzi indispensabile; in Sereni infatti, come sottolinea Mengaldo, “l’uomo e il poeta facevano tutt’uno”. “Sereni – osserva – era l’antitesi del poeta orfico; era un poeta esistenziale”; “non inventava nulla. La sua poesia nasceva a stretto contatto coi fatti e i fenomeni” e lui “aveva un senso fortissimo della responsabilità della poesia”.
Anche la caratterizzazione sociologica, che per altri autori potrebbe risultare forzata e fuori luogo, qui non stona affatto, e anzi si lega profondamente con l’opera. “Sereni – scrive Mengaldo – era “l’incarnazione della borghesia italiana, o se si preferisce settentrionale, al suo meglio”. Altrove, il critico ricorda la “proverbiale cortesia di Sereni”, e parla di “quell’autorità che tanto più emanava dalla sua persona quanto meno egli soleva e voleva usarne”. Nello stesso contesto si allude al riserbo caratteristico del poeta, alla sua “vergogna della poesia” (che rinvia a Gozzano, su cui Sereni scrisse la sua tesi di laurea, ma assume in lui un carattere più genuino, e meno esibito).
A questo proposito mi sia permesso un breve aneddoto personale che può forse testimoniare ulteriormente quell’insolito pudore. In occasione del mio matrimonio, nel 1976, mio suocero mi presentò uno degli invitati: era Vittorio Sereni, suo amico. Io – che avevo letto le sue poesie fin da ragazzino – restai di stucco, come se avessi di fronte una rockstar. Cercai di farfugliare qualcosa per esprimere la mia emozione e la mia ammirazione, ma non mi uscirono che banalità. Sereni – questo è il punto – sembrava ancora più imbarazzato di me: tagliò corto, si defilò (solo in seguito ci incontrammo più tranquillamente). Qualcosa gli impediva di interpretare pubblicamente il ruolo del Poeta.
“Coi più giovani di lui – scrive ancora Mengaldo – Vittorio non voleva né sapeva assumere la figura paterna; sì invece quella fraterna”. Anche di questo aspetto della sua personalità ho avuto la fortuna di fare esperienza diretta: ogni volta che ci ripenso, mi meraviglio della cordialità, della familiarità con cui trattava un principiante com’ero io allora, della sua disponibilità, della sua capacità di mettersi al mio livello.
“Nella poetica di Ungaretti o di Montale, o anche di poeti successivi profondamente intrisi di orfismo come Luzi e Zanzotto – osserva ancora Mengaldo – c’è qualcosa non solo di perentorio ma, in senso stretto, di intimidatorio: sono poeti che ancora pretendono di comunicare, attraverso la poesia, una verità. (…) Per Sereni, e così per Bertolucci o per Caproni, tutti poeti antiorfici, si tratta di molto meno: di comunicare un’esperienza. La poesia di Sereni non ha nulla d’intimidatorio, le è del tutto estraneo il gesto di chi esclude dal tempio i profani”.
“Nel mondo poetico di Sereni uno vive come a casa propria” si legge in un’altra pagina. Forse la ragione fondamentale di questa familiarità, scrive Mengaldo, è “la costanza del suo timbro”; e a questo proposito sottolinea “la particolare naturalezza della sua pronuncia. Non conosco nel nostro secolo nessun poeta che abbia saputo come lui conservare nella parola scritta il tono e le inflessioni della parola parlata; anzi: della voce che parla. E ciò senza alcuno di quei vezzi e quelle controscene che caratterizzano la tradizione crepuscolare, dove in realtà il parlato non è – come in lui – integralmente assunto nella scrittura, ma è sempre ‘citato’”.
Il volume non si limita, com’è ovvio, a presentarci un ritratto di Sereni uomo e poeta. Dei diciassette scritti che lo formano, composti nell’arco di quarant’anni, i più sono dedicati a una accurata analisi tematica e formale dell’opera. Particolarmente sorprendente –almeno per me – è quello intitolato Da Cechov a Sereni (2011), dove il critico indica la presenza, nella poesia di Sereni, di alcuni rinvii ai lavori teatrali dell’autore russo, da Zio Vania a Il giardino dei ciliegi a Tre sorelle.
Nelle Note sul Diario d’Algeria (1999) Mengaldo confronta tra l’altro la lingua del libro del 1947, ispirato dall’esperienza di prigionia, con quella del giovanile Frontiera (1941): “Cos’è allora – si chiede – che rende il Diario soprattutto a partire dalla sezione centrale, così diverso anche linguisticamente (o meglio stilisticamente) da Frontiera? È, o almeno a me sembra, che una stessa o simile lingua è completamente rifunzionalizzata. Mentre in Frontiera la lingua elegante, essenziale e rastremata dell’ermetismo e dei suoi vicini ci raccontava di una tremante individualità, di un’esile, perplessa giovinezza, di sfocate attese, nel Diario essa diviene, inserita in magre profilature testuali, il linguaggio adeguato a una vita ridotta ai minimi termini, a un io insieme disperso e immoto. L’essenzialità del linguaggio, qui perseguita all’estremo in modo da lasciare anche fra un enunciato e l’altro enormi vuoti, è la figura della riduzione e disseminazione del soggetto”.
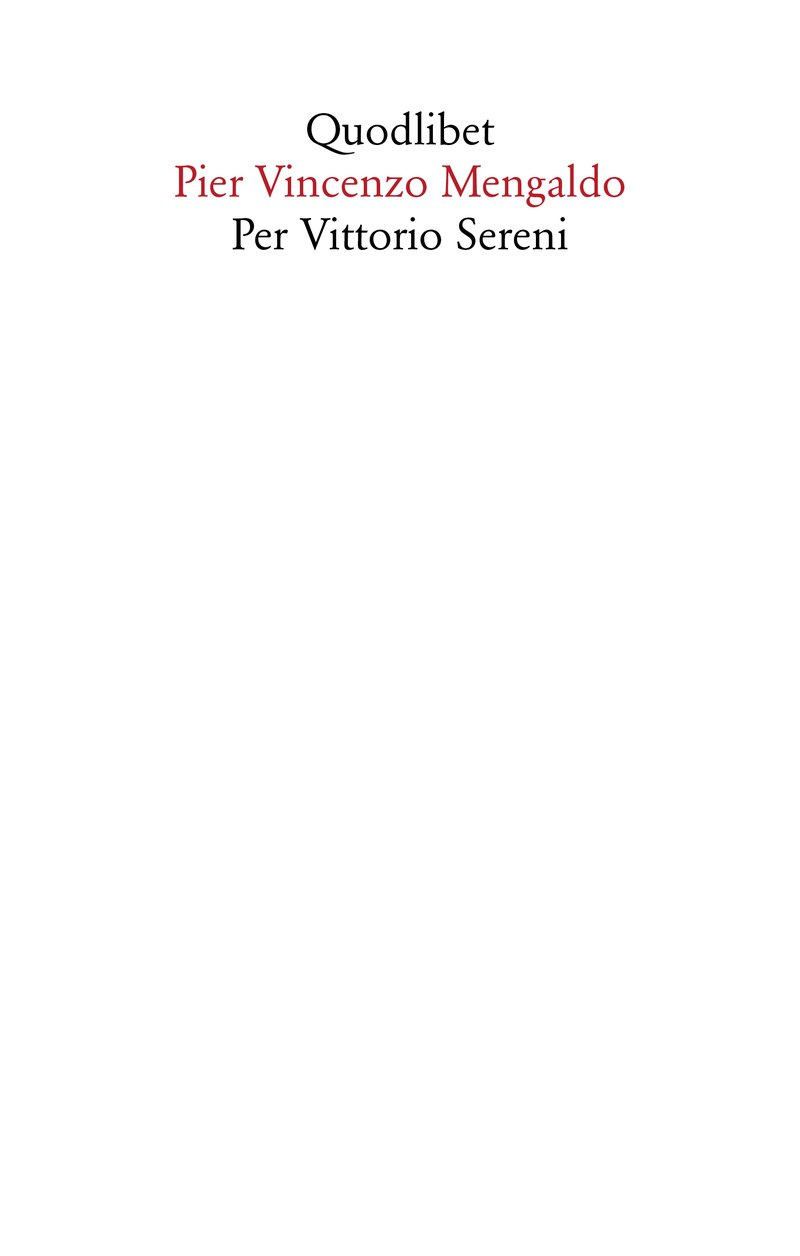
Uno dei saggi più noti, Iterazione e specularità in Sereni (1972), ripubblicato nel 1975 in coda alla riedizione di Gli strumenti umani nella “collana bianca” Einaudi (la prima edizione, nei “Supercoralli”, è del 1965) è probabilmente il contributo più significativo di Mengaldo a un’analisi formale della poesia di Sereni. A partire dalla poesia intitolata Amsterdam, il critico individua nella ripetizione (iterazione) e nella specularità le caratteristiche salienti della scrittura del poeta, fornendo molti esempi tratti dai testi. “Io credo – scrive – che proprio alla continua presenza di questo modulo sia in gran parte dovuto quel che di inconfondibilmente legato, fuso e come agglutinato ha lo stile dell’ultimo Sereni, quella sua tonalità di spenta grisaille.
Iterante lentezza ritmica, affidata bene spesso alle sequenze e come lasse di versi lunghi, e programmatica parsimonia cromatica fanno l’incanto di uno stile che punta tutto sull’apparente uniformità con cui gioca ogni volta sulla sua scacchiera pochi elementi-base, rinunciando a splendore timbrico e varietà e facilità di ritmi in favore di un lavoro più sottile di parca, sapiente modulazione armonica (e il sovrapporsi e incrociarsi di temi verbali ripetuti e variati rende infatti la forma poetica di Sereni spesso così simile a quella musicale della fuga). Che è anche il modo con cui il poeta supera vittoriosamente il suo difficile compito di postermetico, di conciliare e fondere colloquialità narrativa e liricità”.
Insieme e in connessione con gli aspetti formali, Mengaldo indica i temi ricorrenti nella poesia di Sereni (la memoria, la riemersione del passato, il viaggio, i morti, l’amore, l’amicizia, un io che si rispecchia in altri o in un proprio doppio), e lo qualifica come “poeta dell’insicurezza, dell’identità minacciata”.
Due saggi tra i più importanti del libro sono dedicati all’analisi di singole poesie. Il primo, del 2008, riparte da Amsterdam (da Gli strumenti umani, 1965), con la quale già si apriva lo studio citato su Iterazione e specularità in Sereni, del 1972. Il testo è diviso in due strofe, ma Mengaldo identifica una diversa articolazione: “A guardar bene però i momenti sono tre: l’agnizione ‘casuale’ della Casa di Anna Frank (prima strofa); la reazione del compagno di passeggiata dell’autore, vv.8-13 (…), infine la reazione intima dell’io poetico, staccata perentoriamente da quel Ma, da 14 alla chiusa, e che conta dunque, significativamente, quasi altrettanti versi delle prime due parti e anche (…) una diversa metrica, avvolgente, e un diverso stile”. Con questa osservazione formale, Mengaldo sottolinea un aspetto caratteristico della poesia di Sereni, la narratività: “Ogni (o quasi…) poesia lirica, anche se breve o brevissima –scrive – è simultaneamente una narrazione, e certo Amsterdam ne è una.”
Un’altra rilevante lettura, del 1997, ha per oggetto La spiaggia (ancora da Gli strumenti umani). Qui Mengaldo parte dalla struttura metrica della poesia. La spiaggia – scrive – “è un testo che di solito si dice in versi liberi, e che io preferisco chiamare in ‘metrica libera’”, e osserva la quasi assenza di rime, di assonanze e di versi tradizionali, che però si riscontrano in qualche caso. “In una metrica slabbrata e a fisarmonica – spiega – i versi regolari adempiono a una doppia funzione, di rialzare lievemente i momenti di ‘prosa’ e invece di sottolineare fortemente gli scatti ‘lirici’” e parla di “una struttura mossa, irregolare, priva o quasi di marcature tradizionali, tipica del poeta che con più decisione e bravura nel dopoguerra ha infiltrato la prosa nella poesia e d’altra parte ha fatto scaturire i lampi candenti, le fusées della lirica dal fondo grigio e magmatico della prosa, la forma dall’informe; detto altrimenti, che ha utilizzato anche lo scontro fra lingua piatta e lingua solenne come segno di quello fra quotidianità inane e luce di lampo”.
L’ultima parte del libro si occupa dell’attività di traduttore del poeta, raccolta in volume in Il musicante di Saint-Merry (1981). Tra gli autori tradotti ne spiccano tre: René Char, Guillaume Apollinaire e William Carlos Williams. Generalmente si è portati a pensare che la scelta dei poeti da tradurre nasca da un’affinità di fondo; nel caso di Sereni, invece, si ha l’impressione che il traduttore abbia programmaticamente cercato voci da lui in vario modo distanti. È lo stesso poeta a dichiarare, a proposito di Char, di essersene sentito in un primo tempo respinto, pur essendone oscuramente affascinato. “Nulla – osserva Mengaldo – vi può essere di globalmente più diverso, da Sereni poeta, della ‘ascensionalità’ costante, dell’‘aggressività’, del carattere ‘oracolare’ della poesia di Char” (e, aggiungo, di quanto permane in lui di surrealismo)”.
D’altra parte, scrive il critico, “Apollinaire non è meno lontano da Sereni di Char, anche se per ragioni diverse anzi opposte”. La sua attrazione per Apollinaire è, secondo Mengaldo, “quella di un poeta condannato ad essere modernamente ‘sentimentale’ verso chi è riuscito, nella modernità, ad essere miracolosamente ‘ingenuo’. E così è impossibile assimilare a Sereni la tendenza epica da ‘nuovo mondo’ e la poesia a 360 gradi di Williams”. A partire da un’osservazione di Franco Fortini, Mengaldo spiega queste scelte con la volontà di “lottare, così anche concedendoselo, con un fare poetico che in proprio gli è negato”.
Oltre che un contributo prezioso alla lettura dell’opera di Sereni, il libro di Mengaldo costituisce un ritratto a tutto tondo di uno dei più importanti poeti del Novecento, di cui si avverte sempre di più la mancanza.









