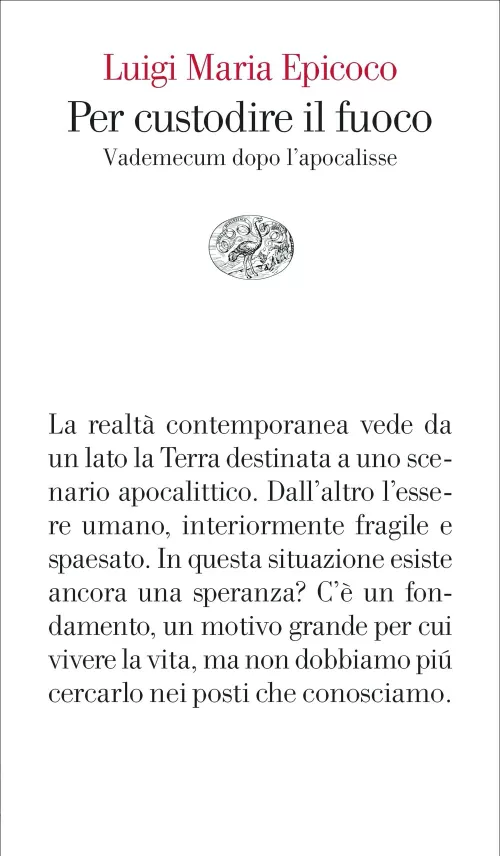Per salvarci dalla disperazione
In un mondo devastato, probabilmente a causa di una guerra nucleare, un padre e un figlio, dei quali non vengono mai rivelati i nomi, camminano trascinando con sé un carrello scassato con tutto ciò che rimane della loro vita. Tutto è grigio, desolato, morto. I due si dirigono verso sud, dove forse qualche brandello di civiltà è sopravvissuto, cercando di non soccombere, un giorno dopo l’altro, e di non cadere in mano alle bande di disperati sopravvissuti ridotti al cannibalismo dalla fame.
È questa la trama del romanzo di Cormac McCarthy La strada (dal quale è stato tratto un film angosciante e bellissimo, The Road, diretto da John Hillcoat e interpretato da Viggo Mortensen e Kodi Smit–McPhee), e Luigi Maria Epicoco ne segue la falsariga nel suo recente saggio Per custodire il fuoco, pubblicato da Einaudi.
Cosa tiene in vita i due personaggi durante il loro tremendo viaggio? Come si sviluppa il rapporto tra loro e, soprattutto, cosa li spinge ad andare avanti apparentemente senza alcuna realistica speranza di sopravvivere? Il padre sembra perdere ogni residuo di umanità nel tentativo di salvare il figlio da sempre nuove minacce – ed è questa la forza che arde dentro di lui e gli permette di non crollare – mentre il figlio, con il suo cuore di bambino incapace di capire l’orrore, gli impedisce di sprofondare nella bestialità. In tal modo, osserva Epicoco, il figlio redime il padre e lo salva. Significativo è un episodio citato dall’autore in cui il padre, dopo avere ucciso un disperato che aveva tentato di rubare il loro cibo, cerca di spiegare al figlio sconvolto le sue ragioni. Finché spazientito gli dice: «Non tocca a te preoccuparti di tutto». Al che questi risponde: «Sì, invece. Tocca a me». È come se dicesse al padre: sì, tocca a me salvare l’umanità dei nostri cuori, l’umanità che è scomparsa dal mondo.
L’apocalisse che fa da sfondo al libro di McCarthy, nota Epicoco, in realtà non racconta il futuro del mondo, ma parla della condizione umana, riguarda l’interiorità dell’essere umano. Il mondo esteriore è metafora di quello interiore. «Se tutto il mondo che conosciamo crollasse lasciando solo macerie e rovine? Che ne sarebbe di noi?» si domanda l’autore e spiega che l’interrogativo non riguarda soltanto chi vede la propria realtà distrutta dalla guerra o da altre catastrofi. Al contrario, interpella tutti perché ci sono momenti in cui, per i più diversi motivi, la nostra vita ci sembra soltanto un accumulo di rovine, un disastro insensato. Dove e come allora trovare la forza di ripartire, di ricostruire se stessi e rimettersi in cammino? Seguendo il filo del racconto di McCarthy, Luigi Epicoco vuole dire «una parola di resurrezione per il nostro tempo», invitando innanzitutto a non cercare al di fuori di sé, a non sfuggire la realtà, ma a guardare piuttosto proprio lì, nel bel mezzo della distruzione, nel fondo della nostra disperazione. Per ricostruire è necessario prima rientrare in sé, anche se «il nostro mondo interiore non è un giardino, ma un deserto pericoloso». Quando si trovano il coraggio e la forza per farlo si sperimenta che anche la più amara delusione ci apre gli occhi a un realismo duro, forse, ma fecondo perché la realtà si rivela «sotto i pezzi infranti delle nostre illusioni…, ha bisogno di essere scoperta, disseppellita, trovata così come si trova un tesoro disseppellito in un campo». Nelle circostanze più dure talvolta si scopre il senso che la vita offre alla nostra esistenza. Un senso che spesso si presenta sotto forma di una responsabilità che ci dobbiamo assumere, e che soltanto noi possiamo assumerci.
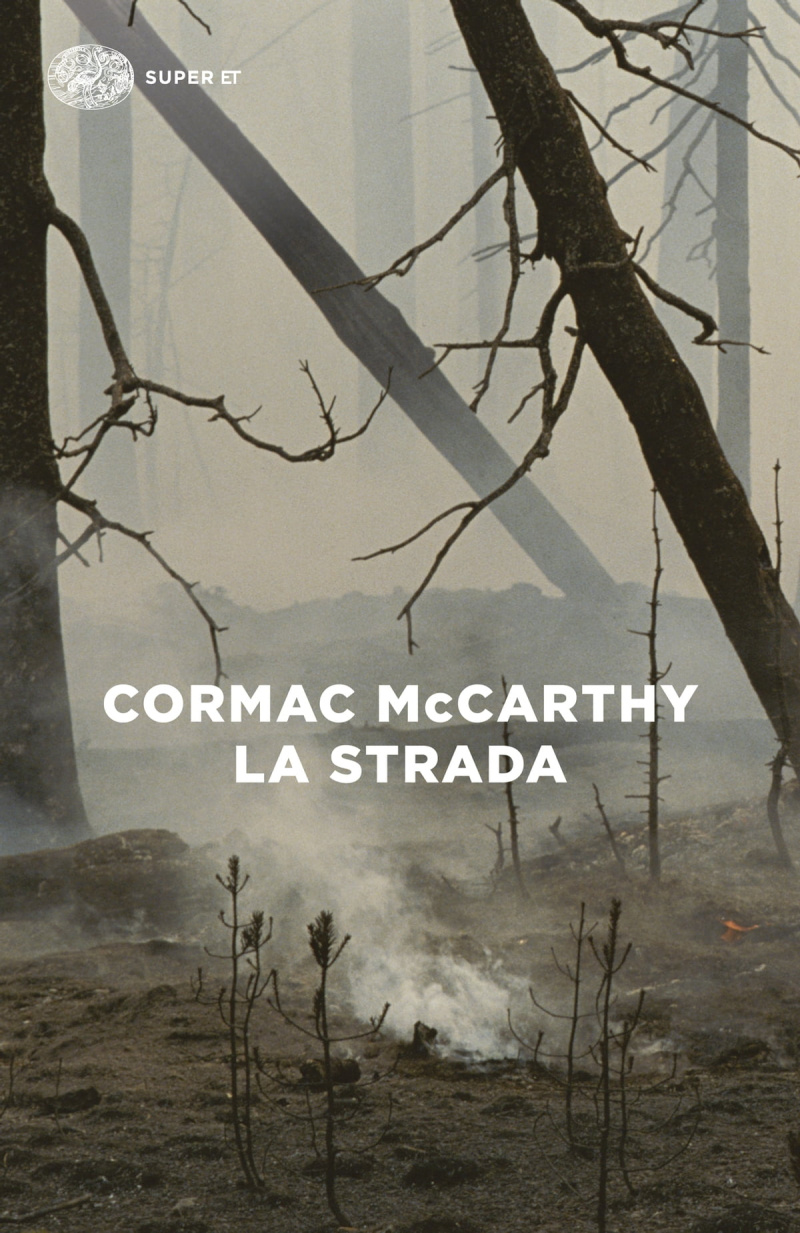
Il padre e il figlio, sono i buoni – così dice il padre al figlio – perché custodiscono il fuoco, metafora di una passione per la vita la cui «anticamera» è il desiderio. Nella società odierna il desiderio è in crisi, ha dichiarato Epicoco in un’intervista facendo riferimento alla sua esperienza di educatore; i giovani spesso non sanno desiderare veramente e confondono «il desiderio con le aspettative degli altri o con la “pancia”». La vita priva di aspirazioni profonde, di una passione capace di portare oltre noi stessi e di spingerci verso l’altro – una persona, un’idea o il divino – assomiglia tragicamente al mondo descritto da McCarthy: è fredda, vuota, ridotta a un preambolo insensato della morte. I «grandi desideri», invece, la riaccendono.
Avere il coraggio di desiderare intensamente comporta anche il sapersi opporre a chi, seppure per proteggerci dalla sofferenza o dal male, ci spinge verso una prudenza che diventa ignava rinuncia a lottare. Spinto al limite, questo atteggiamento è rappresentato dalla madre del bambino che sceglie il suicidio per non dovere affrontare tutto il male e il dolore che immagina li aspetti. Conoscere i propri desideri è il primo passo per una possibile ricerca della felicità. Dovrebbe essere questo l’obiettivo della vita, non un riduttivo accontentarsi di stare meglio rispetto al dolore che proviamo, scrive Epicoco. Noi possiamo aspirare alla felicità. «Ecco allora la sequenza del fuoco: desiderare la felicità; a partire da questo desiderio coltivare una passione. La passione può generare conflitto; ma essa va difesa e alimentata perché è lì il fuoco» che fa perseverare nella ricerca del bene possibile. E altrimenti come avrebbe potuto Gesù affermare: Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! (Lc 12,49)? Nell’Apocalisse di Giovanni è detto chiaramente come Dio detesti la tiepidezza prudente di chi semplicemente si astiene: Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca (Ap 3, 15-16). Sono parole forti, senza ambiguità è pronunciato un duro giudizio su chi è incapace di sentire intensamente qualcosa, nel bene e nel male, su chi non vuole rischiare né sa emozionarsi. Nella durezza di cuori così, incapaci di provare passione, si trova la sorgente del male secondo l’insegnamento biblico (cfr. A.J. Heschel, Il messaggio dei profeti, Borla ed.).
Cosa ci può salvare allora dalla disperazione nelle situazioni disperate? Dal punto di vista del padre, tutta la storia raccontata da McCarthy è una lotta contro la disperazione. E la salvezza viene dal figlio. Il bambino, scrive Luigi Epicoco, «è la personificazione di ciò che trattiene la vita dalla morte, dalla totale distruzione, dalla totale resa». Per Epicoco, che è uno scrittore e filosofo ma anche un sacerdote, la fonte ultima e possibile della speranza e della forza nella desolazione naturalmente è Dio. Il suo discorso, però, non è confessionale, perché riguarda l’interiorità che «è la cifra del nostro essere umani e non del nostro essere credenti». Alla fine, abbiamo bisogno di sapere che il nostro vissuto ha un senso: chi ha un perché, sopporta quasi ogni come sosteneva Nietzsche. Siamo cercatori di senso, «esseri malati di Senso» e come può essere possibile che non esista qualcosa che tutti cerchiamo, si chiede l’autore? La sete non ci parla forse dell’esistenza dell’acqua? C’è chi sostiene che l’intero Universo non abbia alcun senso; ma non è strano che qualcosa di totalmente insensato dia vita a frammenti – gli esseri umani – che vogliono disperatamente sapere il senso delle cose, e soprattutto della propria vita? Tutti abbiamo bisogno di qualcosa di solido su cui radicare la speranza, e per tutti a ben guardare e in ultima istanza, quel qualcosa è il profondo interesse per la vita di un altro. L’insegnamento che ci lascia McCarthy, conclude Epicoco, è che «abbiamo la responsabilità di vivere non solo per noi stessi, ma per amore di qualcun altro». Questo ci salva dalla disperazione.