Sotto il segno del genocidio
1. Monster
Nei muri delle città tornano le stelle e le svastiche.
Su una strada di New York un passante inveisce contro manifestanti pro-Israele: “My family fought Hitler, not like you Zionist cowards. Children are being murdered and you stand here. You’re a fascist and a genocide monster”.
A Washington, in una delle manifestazioni più affollate di sempre, un uomo scrive: “Largest protest demanding #CeasefireNOW #FreePalestine #StopGazaGenocide”. Marea di condivisioni. Nella stessa giornata, Benjamin Haggerty, un rapper americano, grida dallo stage: “I don’t know enough. But I know enough that this is a genocide”. Ondata di applausi.
In uno show televisivo un ex ambasciatore di Israele tuona: “Per noi, lo scopo è distruggere Gaza, distruggere questo male assoluto”. Rispondendo agli appelli umanitari, il primo ministro israeliano libera l’equazione del suo governo: “essere pro-Palestina equivale a essere pro-Hamas, essere pro-Hamas equivale a essere anti-semiti”. Tempesta di reazioni.
Sono istanze, azioni e passioni, del mondo comune. Tessiture dello spazio semiotico, sotto il segno di terribili mostri. Intanto nel feed si tessono frammenti di guerra: ospedali bombardati, bambini dallo sguardo spento, fratelli che piangono i resti della madre, giornalisti che muoiono, vita senza futuro. Qui è dove sono gli altri.
Da dove arriva “il mostro”?
2. Lo spazio estremo
Per rispondere intanto conviene non farsi prendere dai mostri.
Piuttosto, volendo sopravvivere dobbiamo ricordare che i mostri affiorano sempre dalla nostra coscienza, vanno sconfitti dall’interno.
Da dove iniziare? Un buon metodo è consultare un buon libro. Nel corposo volume sul rapporto fra Cultura e imperialismo (Feltrinelli, 2023), Edward W. Said mostra bene come la nascita degli Imperi di Oriente e Occidente sia sempre segnata dal meccanismo di costruzione dell’Altro. Il suo innesco produce una forma di soggettivazione – disconosciuta, ma attiva –, attraverso cui si condanna il Diverso alla condizione di marginalità. Nel caso più estremo questo rituale implica diverse forme di violenza, fino all’eliminazione fisica dell’altro. E il mostro? Ci sembra che esso affiori dal fondo della nostra coscienza, per indicare lo spazio estremo che l’Impero espelle fuori da sé, (s)oggettivandolo in un qualche altro e altrove, ma che il Mostro ha il compito di riportare nel qui della nostra coscienza.
A partire da questi presupposti il piano di gruppi come Hamas si concretizza nell’agire una pressione dall’interno, per far affiorare l’asimmetria delle relazioni, rendere visibile lo “lo spazio estremo del sistema”, dove si misura la soglia dell’identità. È dall’interno di questo spazio che affiora il mostro del genocidio – e altri mostri del nostro tempo, come l’eccidio dei migranti nel Mediterraneo. La sua emersione si situa a monte e a valle di un piano della cultura, capace di mostrare la presenza dell’altro, situato fuori di noi (come nella West Bank e a Gaza) e dentro di noi (la soglia interna del confine), portandovi la nostra sensibilità.
La presentificazione del genocidio fa affiorare le contraddizioni del collettivo. Il mostro rievoca il ricordo della violenza dell’uomo sull’uomo, dell’uno sull’altro. Esso non è situato fuori, ma dentro l’impero.
È d’altra parte al cuore dell’Occidente, dalle radici del suo trauma, dall’estremo dell’impero che si definisce il termine di genocidio per il “mondo civilizzato”.
3. L’invenzione di genocide
Si dice che il termine genocidio sia un’invenzione di Raphael Lemkin.
In realtà, l’avvocato lo traduce dal vissuto. In prima istanza da studioso di giurisprudenza quando scopre la mancanza di una fattispecie giuridica per trattare lo sterminio degli armeni perpetuato dall’impero Ottomano. Prima di Lemkin quelle stragi di innocenti erano un crimine senza nome, come le definì Churchill anni dopo in riferimento al nazismo. È da questo vuoto che il giovane Lemkin inizia il percorso di costruzione dello spazio del diritto.
All’inizio negli anni trenta per rendere conto di questi atti convoca i termini di barbarismo e vandalismo, indicando rispettivamente la distruzione dell’esistenza del popolo e della cultura. Il fato volle che pochi anni dopo Lemkin subisse direttamente i vissuti studiati perdendo i suoi cari nell’esperienza dell’Olocausto. L’evento rinforza nello studioso il convincimento della necessità di affermare un termine capace di contrastare il male e, in estremo, spazzarlo via dall’orizzonte della storia.
Da qui si mette all’opera per scrivere Axis Rule, un libro sulle leggi di occupazione nazista in Europa, in cui per la prima volta compare il termine genocide. La parola contiene una doppia radice: il tema greco γένος che rimanda all’idea di stirpe, e quello latino ex-cìdium cioè di grande uccisione. L’assemblaggio funziona. Nella lingua inglese evoca tanto l’idea di una qualche origine – il genos –, quanto quella di un crimine per l’assonanza con homicide. Inoltre, possiede un senso di autorevolezza, funzionale alla scientificità del discorso giuridico, dato dalle lingue greca e latina. Proprio questa scelta genera un ponte fra gli Stati Uniti e il mondo europeo, come se il termine scaturisse da una memoria lontana, alla quale era destinato a fare ritorno.
Il conio in inglese è dovuto alla necessità sentita da Lemkin di trovare un’autorità che legittimasse il neologismo. Per questo cercò, e alla fine trovò, un riconoscimento nel mondo statunitense. In questo progetto, come mostra Flores (Il genocidio, Il mulino 2021), scrive a Franklin D. Roosevelt per denunciare la condizione degli ebrei in Europa, ma il presidente gli risponde che deve attendere. Col libro invece ottiene la visibilità auspicata. Il New York Times Book Review gli dedica la copertina, perché “al di là dell’asciutto legalismo, emergono i contorni del mostro che cavalca il mondo”. La pratica di sterminio di un popolo inizia il suo processo di definizione, se pure dovrà aspettare qualche anno per la sua codificazione giuridica.
Mancano ancora due prove da superare affinché il nome penetri nella sfera del diritto assurgendo al meta-livello della cultura (Lotman 2022). La prima è partecipare al Processo di Norimberga da assistente del procuratore Robert Jackson, grazie a cui riesce a inserire il termine nel capo d’imputazione relativo ai crimini di guerra. La seconda, quella decisiva, sarà partecipare da protagonista ai lavori della Commissione per la Convenzione sul Genocidio (1948). Il testo finalmente sancisce il crimine di genocidio come “ciascuno degli atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. Va precisato che la definizione giuridica del 1948, innerva le due isotopie della prevenzione e della repressione del crimine. Queste definiscono la dimensione performativa del termine con misure inderogabili che vanno: dall’istituzione di procedimenti giudiziari internazionali, alle indagini per stabilire il rischio di reato, al ricorso dell’azione militare.
Non possiamo entrare nel dettaglio delle vicende legate alla definizione del termine in quel laboratorio del diritto che fu la Commissione. Basti sapere che Lemkin dovette cedere alle pressioni delle super potenze del tempo – Francia, Stati Uniti, Unione Sovietica – che, temendo di perdere i loro privilegi coloniali e politici, gli impedirono di inserire le fattispecie di genocidio culturale e politico. Invero, elementi fondamentali del suo Axis Rule, dove argomenta: “il genocidio fisico e biologico sono sempre preceduti da genocidio culturale o da un attacco ai simboli del gruppo o da un’interferenza violenta delle attività culturali”. Dunque, per il suo creatore, il genocidio si configura nella negazione della vita della cultura, prima ancora di quella del suo popolo.
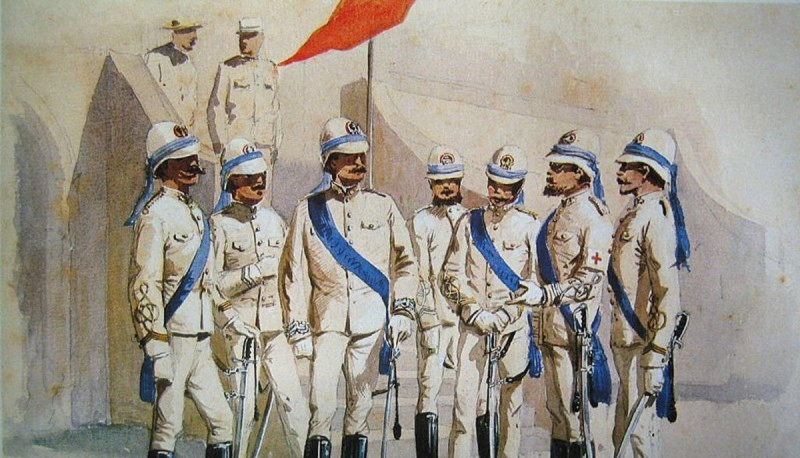
Oggi il concetto di genocidio culturale segna la nuova frontiera del diritto internazionale.
4. Alla radice del simbolo, le guerre semiotiche
In realtà, il genocidio è una materia che si traduce nei differenti linguaggi della cultura, ciascuno dei quali definisce la propria sostanza. Dal vissuto degli armeni si traduce nell’esperienza di Lemkin. Dall’esperienza dell’autore, si trasforma nel nome. Dal nome al diritto. Da qui, sarà oggetto di storiografia, sociopolitica, sociologia e così via. Ciascun processo definirà dal proprio interno un piano di esistenza del genocidio, dal quale sarà mobilitato nello spazio comune.
C’è da chiedersi se esista un piano trasversale alle diverse forme di genocidio. La nostra idea è che esso corrisponda ad uno spazio radicale, matrice dell’(in)umano, nel quale il soggetto si afferma nella sistematica negazione violenta dell’altro. È dal fondo di questo spazio estremo che il genocidio si traduce nei differenti piani della cultura. Da qui risale in superficie per tradursi nei vissuti di genocidio: Holodomor, Terrore Rosso, Anfal. Da qui risale e si traduce nelle sue molte lessicalizzazioni: eccidio, etnocidio, urbicidio, femminicidio eccetera. C’è quindi una correlazione fra lo spazio estremo del profondo e le sue manifestazioni di superficie.
Fra le altre, il genocidio si traduce nelle forme dei procedimenti giudiziari: Bosnia, Ruanda, Cambogia. Tuttavia è con l’evento dell’Olocausto che il termine assurge al livello simbolico globale. L’Olocausto diviene il genocidio per antonomasia e attraverso esso il termine diviene simbolo del male assoluto. Da questo piano viene mobilitato nello spazio della comunicazione contemporanea. In questa forma, per dirla con Umberto Eco, rientra nei processi di costruzione del nemico. Ciò non toglie che esso continui a divenire nel suo piano di esistenza giuridica. Si pensi alla recente dichiarazione degli esperti dell’Onu, per i quali il popolo palestinese “corre un serio rischio di genocidio”.
Contemporaneamente viene mobilitato nelle forme ibride e dinamiche dell’interazione politica. In tal senso lo si è visto nella guerra russo-ucraina, quando Putin accusa l’Ucraina di genocidio nel Donbass. Qui l’impiego è principalmente giuridico: fa appello alla Convenzione allo scopo di legittimare l’attacco. Tuttavia, seguendo lo schema d’azione, l’accusa viene rispedita al mittente dallo stesso Zelensky, che denuncia il presidente russo di genocidio a Bucha. Così il termine è mosso sul piano simbolico per caratterizzare la figura di Putin. La denuncia viene poi rilanciata da Biden, che a titolo di garante conferma l’accusa. La catena viene interrotta dal veto di Macron che riporta il termine al piano giuridico: “spetterebbe al tribunale penale il pronunciamento sull’esistenza del reato”. Il meccanismo funziona. Ma nel complesso la dinamica fa emergere un paradosso: le soluzioni ai problemi, sovente ne producono di nuovi. Come la Convenzione che da strumento di pace, viene usata per muovere guerra.
Infine, il caso illumina aspetti più generali della mobilitazione politica del simbolo. Da una parte, rivela le posizioni di un governo rispetto alla guerra. Dall’altra, mostra che l’interazione è doppiamente simbolica. Il simbolo si definisce nell’interazione, e questa nel gioco del simbolo.
Certo, non stiamo sostenendo che gli unici legittimati all’uso del termine siano i magistrati (sic!). Al contrario, preferiamo che il genocidio non sia oggetto né negazionismo o banalizzazione, né di sacralizzazione.
Piuttosto, per la nostra salvezza, confidiamo nel potere dei simboli, nel loro essere tenaci custodi della memoria e alleati della trasformazione.
6. Il testo nel testo
Possiamo ora tornare alla catena di azioni e passioni che ci avviluppa – assalti, aggressioni, manifestazioni, invettive, grida, urla –, per chiederci se considerarla come espressione di qualcosa o piuttosto come il contenuto di un’altra. Una forma di testo nel testo, per dirla con Lotman.
Crediamo che per rispondere si debba tornare nella zona estrema del confine, da cui considerare gli eventi come parti di un piano nel quale l’azione di Hamas si intreccia fatalmente con la passione dell’Occidente. Nei limiti del nostro spazio dovremmo quindi penetrare il groviglio di relazioni che connette Gaza e Hamas, Israele e Palestina, Oriente e Occidente.
Partiamo dalle dichiarazioni rilasciate da Khalil al-Hayya ai corrispondenti del The New York Times (9.11.23). Secondo il leader di Hamas, l’azione delle frange armate, le brigate Izz al-Dīn al-Qassām, aveva un solo traguardo: “change the entire equation and not just a clash”. Nel dettaglio, dichiara, mentre il quartiere generale non si attendeva che l’attacco del 7 ottobre avrebbe avuto quella intensità – mostrando un mondo più composito, rispetto al suo ritratto in Occidente –, tutti sapevano quale concatenazione di eventi avrebbe generato. In sintesi, la vendetta di Israele era già contenuta nel piano di Hamas.
Ma c’è di più, affinché l’azione generasse la trasformazione in Medio Oriente, l’attacco del 7 ottobre doveva provocare una catena di azioni e passioni principalmente nello spazio dell’Occidente. Insomma, nel piano di Hamas l’azione doveva generare la vendetta di Israele, ma per portare la crisi in Occidente e da qui cambiare lo stato di cose in Medio Oriente. Una crisi generata dal presentificarsi in Occidente, attraverso la sua presa di attenzione mediatica, del simbolo, del trauma di fondazione, del mostro del genocidio. E infatti, il termine è diventato subito la parola d’ordine in nome della quale si è organizzato il dissenso. Da qui le grandi manifestazioni in capitali come Washington, Londra e New York. Un movimento che riempie gli schermi, al quale partecipano organizzazioni civili, leader e attivisti, occidentali e del mondo arabo, sotto il segno di “Ceasefire NOW”.
D’altra parte è proprio nella tensione dinamica fra movimento e istituzioni che affiora la crisi dell’Occidente. Un meccanismo inceppato che si concretizza – si pensi alle tensioni fra Guterres, Netanyahu e Biden – nell’incapacità di intervenire nel massacro di Gaza.
C’è un episodio di Fauda in cui Abu Ahmad, il capo di Hamas, spiega la natura del piano terroristico. L’attentato avrà luogo in una sinagoga per provocare “la passione di Israele”. Così, afferma, accadrà l’inevitabile: la rivolta del mondo, la fine del sionismo.
Per saperne di più
Sul ruolo del simbolo nella contemporaneità, si veda: D. Mangano e F. Sedda (a cura di), Simboli d’oggi, Meltemi 2023.
Sui temi del mostro e della violenza, vedi: T. Lancioni, E inseguiremo ancora unicorni, Mimesis 2020.
Sul rapporto fra trauma e coscienza collettiva, si rinvia a: F. Sedda, Tradurre la tradizione, Mimesis 2019.
Sull’interazione semiopolitica: F. Sedda, Imperfette traduzioni, Nuova cultura 2012.
Il testo citato in rapporto al meta-livello della cultura è: Juri M. Lotman, La semiosfera, La nave di Teseo 2022.
Sulla (im)prevedibilità delle dinamiche storiche, vedi: Juri M. Lotman, La cultura e l’esplosione, Mimesis 2022.
Sull’opera di Lemikin e la definizione giuridica di genocidio, si veda: C. Leotta, Il genocidio nel diritto penale internazionale, Giappichelli 2013.
Per l’idea di lavorare sul concetto di estremo siamo debitori ad una conversazione con Paolo Fabbri.
Leggi anche
Alberto Mittone, Per fare chiarezza | Aggressione, crimini di guerra, genocidio
Alberto Mittone | Philip Sands. La strada Verso est. Gestire la memoria









