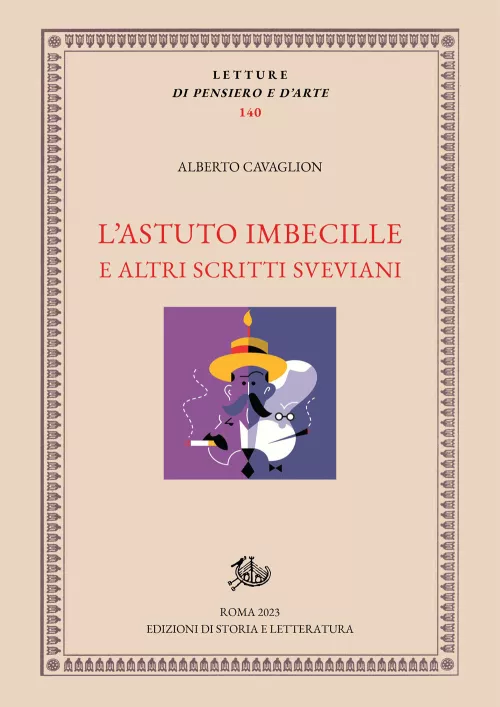Svevo l’astuto imbecille
Giustapporre due termini antitetici. Tenerli entrambi lì. Farli vivere l'uno accanto all'altro. Non ci sono modi migliori di definire la personalità artistica, la poetica, la visione del mondo di uno che ha scelto di chiamarsi Italo Svevo, l'italiano tedesco. E che è anche un artista industriale, un ebreo cattolico, un giovane vecchio, un dotto ignorante, un sano malato, un fumatore che ha smesso, smette, smetterà. E ha ragione Alberto Cavaglion quando, nel suo saggio che dà anche il titolo a questa raccolta (L’astuto imbecille e altri scritti sveviani, Edizioni di Storia e Letteratura, 2024), sostiene che la «parola che hanno i greci: astuto imbecille», quella che Zeno elargisce all'amato-odiato cognato, rivale e socio Guido Speier, non può essere quella che descrive retoricamente l'espressione: ossimoro. Deve trattarsi invece di un termine che, appunto, significa assieme “astuto” e “imbecille” senza che la forza e la proprietà di uno dei due termini finisca per sopraffare l'altro, né che ne derivi una sintesi in cui entrambi si fondono. La parola cercata, infatti è κουτοπòνηρος (kutopòniros), che è composto da κουτός (koutòs), «“tonto”, “sciocco”, “stupido” (mona?)», e πονηρός (poniròs), «“furbo”, “astuto”, “intrigante”», e che mantiene entrambi i significati, come Italo Svevo vuol dire sia italiano che tedesco. Lo pseudonimo giusto per uno che, a dirla tutta, era austriaco ma non ci si sentiva.
Quello che Cavaglion mette al centro sottolineando questo passaggio è uno dei momenti in cui l'ambiguità (necessaria l'ha definita Giulio Savelli) della scrittura di Svevo si fa densa: a Zeno viene in mente la parola greca perché anticipa già il momento in cui, sistemato il rivale, ne oltraggerà addirittura la memoria sbagliando il funerale e seguendo, al posto di quello di Guido, il feretro di un defunto della comunità greca. Del resto il rapporto fra Zeno e Guido è uno dei più indecidibili momenti di ambiguità del testo. Certo, per un freudiano come il dottor S., ma anche per un critico freudiano come Elio Gioanola, che ha definito Zeno “un killer dolcissimo” (altro ossimoro) sostenendo che Zeno, con le sue arti peculiari è addirittura l'assassino di Guido, è chiaro che il sentimento profondo di Zeno per il cognato non può che essere di invincibile, feroce ostilità, sia pur semiconscia.
Anche la cognata, l'amata Ada, pensa che Zeno non lo abbia mai perdonato per averla rubata a lui, e che con i suoi atti “in morte di Guido” abbia voluto dimostrare tutta l'insipienza, la pochezza dell'altro, facendo «in modo ch'egli è morto proprio per una cosa che non ne valeva la pena!» (e così dimostrando, per altro, che non ci voleva una laurea in psicologia o un training psicanalitico completo per intuire questo tipo di dinamica). Ma Zeno non è affatto d'accordo e, quel che più ci interessa, non lo è forse neanche Svevo, che in una lettera da poco ritrovata al suo editor presso l'editore Cappelli, Attilio Frescura, dice che Zeno è «uno strano uomo che senz’accorgersene (nel penultimo capitolo) spinge alla morte un suo amico dopo di averlo spinto alla rovina».

Riflettevo su questa elasticità, su questa persistenza dell'ambiguità e mi pare di capire, perché Svevo, nei due ultimi capitoli del libro di Cavaglion, quelli più sorprendenti, finisca per rappresentare una lettura molto importante per due intellettuali relativamente lontani da lui, se si esclude la comune origine ebraica, in condizione di privazione della libertà e rischio della vita: Vittorio Foa in carcere e Primo Levi nel lager. La violenza della storia semplifica l'antico dilemma del vecchio Zeno che a un certo punto (naturalmente quando rammenta che, anni prima, per qualche istante, lui davvero aveva voluto uccidere Guido) si chiede: «ero io buono o cattivo?». Quando la sopraffazione ha caratteristiche così brutali e cieche, i dubbi diventano reliquie del passato e chi siano i cattivi, per lo meno, è perfettamente chiaro. E in quel momento, per chi patisce quella violenza e quella sopraffazione, il gracidare delle rane di Svevo, le rane del dubbio, perenne, invincibile, può parere musica.
Svevo diventa escapista, come lo definisce Cavaglion, non perché possa offrire scampo dalla vita orrida vera, le chiavi della cella, un varco nei reticolati, ma perché offre preziosi suggerimenti per continuare a vedere la complessità del reale anche dentro quelle mostruose macchine semplificatrici che sono il carcere e il lager. Vittorio Foa colpito, come Ada nel romanzo, dal morbo di Basedow sente che la sua malattia che comporta un dissennato dispendio delle energie vitali è la condizione dei giusti, di quelli che si impegnano, si oppongono e soffrono, contrapposta a quella dei “sani”, conformisti, vigliacchi e poltroni. Come nel modello sveviano, nelle lettere dal carcere di Foa, la malattia si converte in salute e viceversa. Lo stesso capita, in altro modo, a Primo Levi, l'altro grande scrittore nelle cui pagine Cavaglion va alla ricerca di un'affinità, più che di un'influenza, sveviana: ad Auschwitz è la «provvidenziale scarlattina, che lo sottrasse alla tremenda marcia d'evacuazione» che salva la vita di Levi, la malattia che si converte paradossalmente in salute, nel senso etimologico latino di “salvezza”. Ma i punti di contatto fra l'opera di Svevo e quella di Levi, che cita il romanziere triestino in diverse interviste e in diversi luoghi della sua scrittura letteraria, ci mostra Cavaglion, sono più profondi.
Più profondi ancora di quelle circostanze biografiche che pur ci sono, e colpiscono: l'altro mestiere che, per entrambi si svolge in uno stabilimento chimico di produzione di vernici, la radice ebraica vissuta in modo diversamente problematico, la diffidenza verso la psicanalisi. Li accomuna una ribellione contro la semplificazione estrema della vita animale, quella che Levi dice essere propria del Lager, là dove non c'è nulla più che l'opposizione binaria vita/morte. Li affratella una sensibilità verso la ruvidezza della «vita orrida vera» soprattutto, ci mostra Cavaglion, quando deposita sull'ultima riva, sospinti dalla risacca dell'ultimo respiro affannoso, il vecchio Cosini, il padre di Zeno, e il povero Sómogyi, sfortunato compagno di prigionia di Levi.
Non c'è solo questo, in questa agile e preziosa raccolta di saggi sveviani di Alberto Cavaglion, che dall'interesse per il tema della salute e della malattia sviluppa una disamina gustosissima della figura – sempre compromessa, spesso vituperata – del medico nella narrativa sveviana. Così come ci ritroviamo uno studio dedicato al peculiare darwinismo di Svevo (e dei suoi contemporanei) che coinvolge il mitologico episodio della “cavalla di Lord Morton”. E poi alcune “note musicali”, sempre interessanti in campo sveviano, ulteriori riflessioni sul rapporto, che non si finisce mai di indagare, di Svevo con Joyce e, naturalmente, più distese e precise riflessioni sull'antidogmatico ebraismo di Svevo, spesso al centro di superficiali notazioni e qui invece indagato con puntualità.
Ma è il carsico riemergere della parola sveviana – ironica, autoriflessiva, ossessivamente e necessariamente duplice, polare, come si diceva – nelle pagine di autori così lontani per epoca storica ed esperienza di vita che mi colpisce in primo luogo. Autori come Foa e Levi, come detto, ma anche come Luigi Meneghello, che viene introdotto alla voce di Zeno dal suo “piccolo maestro” di antifascismo Antonio Giuriolo. Un'inattesa convergenza sul romanziere del dubbio sistematico da parte di autori che, per motivi differenti, si sono trovati a compiere scelte precise e che hanno capito il valore di portare con sé quell’apertura e quella polarità nella nuova esperienza, non per confondere ma per chiarire.