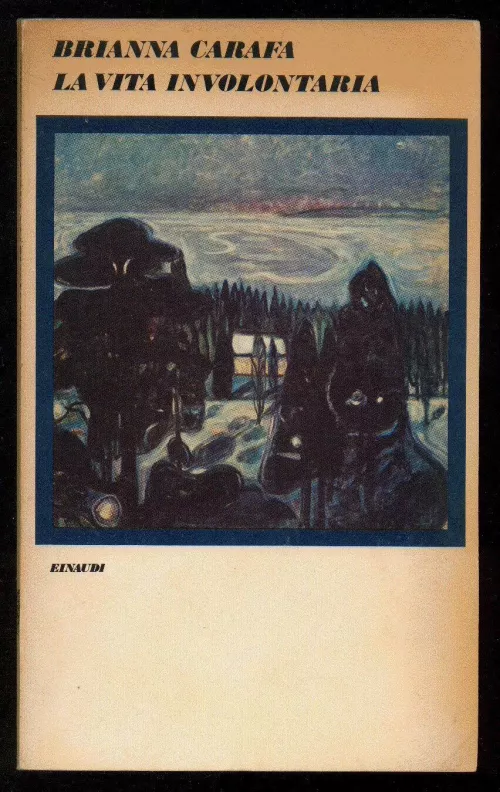La riscoperta di una narratrice / Brianna Carafa: follia della parola
Vita: niente è così carico di possibilità, e così al limite del pensabile; così ambigua, così colma di voci e di molteplici forme di apparire e, insieme, così sola. Già i primi racconti di Brianna Carafa (quelli di Botteghe Oscure, e poi di Paragone-Letteratura tra gli anni ’50 e ’70 ) stupiscono davanti ai tratti visibili delle sue – della vita – sembianze, che la scrittura nel tempo continuerà a inseguire tra le fibre più intime, sviscerandone e facendone emergere i meccanismi che la governano, con l’animo di chi ne coglie i minimi spostamenti: vita che nel suo darsi si fa insieme prodiga e ammiccante e, subito dopo, di una sterilità che respinge; che sfila a distanza nella moltitudine, nel regno dell’indifferenziato essere uomini (uguali in fondo, tutti uguali) per poi sprofondare in un’identità che si fa inquieta solitudine senza aperture: luogo appartato e intimo a cui il pensiero può accedere solo se scosso dalle vertigini della sofferenza. Due romanzi completeranno quest’opera di esplorazione, aprendo e chiudendo velocemente – per una strana sorte – la parabola letteraria della scrittrice: La vita involontaria, opera d’esordio edita da Einaudi nel 1975 (ripubblicata oggi dall’editore romano Cliquot); e tre anni più tardi Il ponte nel deserto, già romanzo postumo, che segnerà l’inizio di una rimozione dell’autrice durata sinora.
Protagonista della scrittura è qui la vita come si dà: ossia colta nel suo fragilissimo apparire, nell’intermittenza che la mostra ora totale, unica, irripetibile; ora illusoria, inaccessibile, persino insignificante. E se non emerge mai, dalle parole, un sentire che sia sentimento (come se questo fosse già un eccesso – cosa di troppo – da raggiungere solo cautamente e a fatica, nell’attitudine insistente e dolorosa di un voler capire), ne viene invece un sentire più lieve e più pungente: un sentire la vita che si dà sempre come frusciare vago, inconsistente ma pregnante, quasi fosse materia di fantasmi – opera dei sogni o della fiaba – al cui interno è possibile trovare la nascita di una coscienza di sé e del mondo.
È tutto uno schiudersi di immagini quello che si spalanca, che si danno come vertigine del tempo e che risvegliano il dubbio dello stare, lo sbigottimento di un ritrovarsi al mondo: che è anche intuizione – paura cieca – della propria inutilità, della propria inadeguatezza alla vita. Lo scrivere, qui, nella sua sapiente misura, avverte la durezza dell’istante che ha mostrato un fondo vuoto: dove l’azione lascia posto a sospensione e attesa, dove la parola si incanta nelle sue assonanze e gira a vuoto, sospendendo la mente e aprendola ipnoticamente alla superficie del proprio suono (volo, solo, dolo, duolo… cantilena Berla nel Ponte).
L’intuizione della vita, in quel suo continuo superamento di se stessa, è nel fondo, l’inquieta, inebriante e terrifica apparizione del nulla dentro cui scorre, come se quotidiani gesti e consuetudini (presi nella loro fragile umanità) fossero solo parvenze, abiti deputati a rivestire il niente e a mascherare l’inconsistenza che vi regna al fondo.
La scrittura della Carafa muove lì dentro con coraggio, nel riconoscimento di questa divaricazione: tra piega e piega esplora il margine dello scostamento, ne scruta i tessuti (bellissimi quelli dilaniati e lisi che imbastiscono le figure dei suoi protagonisti) costringendo lo sguardo agli spiragli, agli interstizi e ai vuoti che vi si aprono.
È questo provare a guardare, questo chiedere e tentare senza mai presupporre un sapere, senza che abitudini e rassegnazioni ne compromettano il gesto, a mettere in moto le narrazioni: una forma di malattia (così, nell’imbarazzo, si pretende chiamarla, questa ostinazione a voler guardare, questa domanda insistita posta alla vita senza protezione) che certo, di fronte alla legge regolata del vivere, è una maleducata forma di spaesamento, uno sviamento che si disassa continuamente dalla regola sicura, dall’affettata e composta consuetudine: che non la riconosce e la dissipa, piantandovi il seme del pensiero. “Darum! – Perché è così!” risponderà la Governante alla bambina tendando di ricoprire definitivamente, con una cieca imposizione, le crepe mosse dalla sfrontata domanda del perché … (La Governante, 1971).
Ma si è già sul crinale in cui il guardare fa nascere lo sguardo disgiungendo l’immagine dal suo punto di vista; e l’estraneità che staziona al cuore del linguaggio (di immagini, di parole) ci fa assistere alla nascita del pensare.
Interpellare la nuda vita significa, per prima cosa, riconoscervi lo scarto inavvicinabile della distanza che vi serpeggia al fondo.
Vita: parola inafferrabile che sfugge al pugno stretto nella forma aggressiva di un potere volto a coglierne e a intrappolarne definitivamente un senso. È parola che sfida il tempo, e lo gioca per trarvi qualcosa di visibile – una ragione – dalle sintesi estreme dei suoi passaggi: anche dallo splendore delle sue morti che, richiudendola, ne domandano il conto. Ma è come un disegno che ad ogni momento impazza e rifugge il suo contorno marcando quella distanza che separa la vita dalla sua definizione, dentro lo spazio aperto della parola.
Con lo scrivere Carafa porrà insistentemente le sue domande alla realtà tutta, interrogandone sino in fondo l’esistenza: cosa è veramente reale? cosa davvero esiste? e in quale forma di possibilità ci viene data quest’esistenza – comunque irripetibile – che passa sempre al vaglio di immagini e parole?
In La vita involontaria sfilano i meccanismi – espedienti, sotterfugi – con cui provare a colmare il punto centrale (pauroso, inquieto) della vita: ci sono lusinghiere e allucinate affabulazioni in grado di ammiccare alla possibilità di vivere, non una, ma infinite vite; c’è il lento scivolìo nel letto già scritto della vita d’altri per poter suggerne la promessa di un’esistenza sicura (Altrove, 1972); ci sono i piccoli gesti necessari a cristallizzare una quieta sopravvivenza quotidiana: l’addomesticamento alla monotonia della ripetizione e alla doverosa contentezza, come tentativo di arginare – irrigidendolo, confondendolo, inebriandolo – lo sfarsi inarrestabile delle cose; c’è il posto per la parola come menzogna, e quello per un silenzio potente e dominatore. C’è, poi, vertiginosa, la spaccatura tra realtà e il dovere di realtà: dove prende forma il nugulo di incitamenti, desideri, obblighi e costrizioni in cui Paolo (lo studente di La vita involontaria) e Bobi (l’ingegner Berla di Il ponte nel deserto) vedono stringersi e mancare lentamente le loro esistenze.
Se c’è una malattia, se c’è supposta follia nella vita, è già nella parola stessa: vita che è stata presa dentro un linguaggio che ne ha dissaldato i lembi, che già si è esposta a uno specchio che ne ha mancato il riflesso e sviato il riconoscimento: perduta l’illusione che ne copriva il fondo insicuro, si è esposta alla vertigine di un pensiero che però è sempre potentemente impotente. Così la volontà di presa sul reale – di parola definitoria, coercitiva – è il primo contorno dell’esistere che si disfa. E che cosa rimarrebbe potendo arrivare a pensare senza immagini, né parole? o potendo togliere, scartare dal nostro orizzonte un’immagine-parola dopo l’altra alla ricerca di quanto può essere detta la ‘realtà vera’?
I fatti vanno ricercati non le parole, prova a insegnare a Paolo il padre; l’evidenza e la concretezza di quei fatti che, nella spaesante accusa a Bobi, avrebbero solo “riempito poche pagine di un verbale, tutto l’accaduto in poche righe”. Ma la scrittura del romanzo è altro: parola dalla verità molteplice, o di una verità che si fa impossibile a dire, capace di dissaldare la vita, facendola più esposta – all’immaginazione, come all’incostanza del vento – e più insicura.
Si dispiegano nel Ponte le vertigini e le incongruenze di un dibattito processuale che si fa amalgama di visioni dentro cui è necessario cercare una verità che è più prossima all’anima che alle cose (e per questo – sentenzia in fondo il verdetto – da condannare, da rifuggire come una colpa…); una realtà che si dà solo per frammenti scomposti e impenetrabili, implicata di continuo in logiche e sequenze stravolte. Le parole che allora emergono ripetutamente nella trama nitida del testo sono l’accesso a un tempo tutto simultaneamente percorribile, tutto visitabile nell’estensione di una superficie; dove però il passaggio, da un tempo all’altro, è sempre manifestazione di una lacerazione dentro cui alberga un dolore che la scrittura non rifugge: che invece accoglie, dispiega, fa vibrare in continuazione.
Quando la verità (come per Bobi) è un sogno che alberga nascostamente dentro la persona, tutto viene improvvisamente travisato, e le parole che cercano di afferrare, distinguere, e addomesticare l’evidenza dei fatti, si incrinano: perché l’evidenza è altrove dall’animo e dall’esperire umano; e se ve ne è traccia, è solo nell’indecifrabile superficie di un pozzo senza fondo su cui riaffiorano, per riflessi, tutti i tempi della realtà nell’immediatezza del momento. Provengono, dall’infanzia dell’esistere, parole penetranti (“Mauvais sujet… Mauvais sujet…”: torna all’orecchio di Bobi il marchio d’accusa della Governante) che si impongono come tratti di un destino già scritto: un futuro già dato nel passato e che detona, bruciante, nel presente.
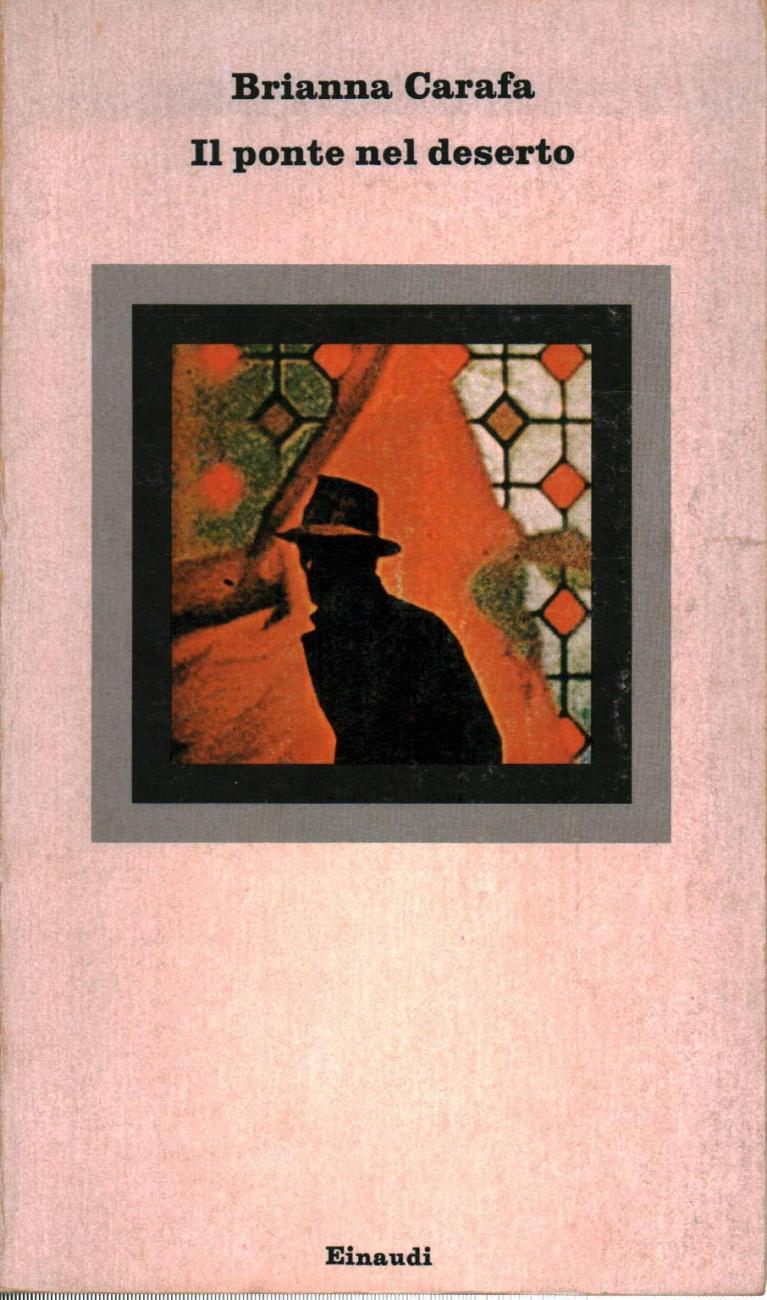
Sono parole disconosciute, che si avvicinano nella loro estraneità: parole-immagini che provengono, che aspirano a farsi riconoscere, ma che si danno solo in una distanza. E tornano, come cose già vedute, su uno sfondo inaccessibile, che solo un sogno o un autentico desiderio sembra poter riavvicinare. È l’instabile terreno – sempre una mancanza – dentro cui la letteratura dà forma alle cose. E i protagonisti di queste storie vi si espongono, indifesi: seguono le parole, il canto (sempre difettoso) di Sirena, per andare, ignari, verso il luogo duro del loro sconosciuto desiderio, in un viaggio che – senza consolazione né soccorso – si dà a ritroso verso l’inizio: sempre più in balìa dei marosi.
L’auspicio sotto cui prendono avvio, qui, le storie è quello della rinuncia e dell’abbandono: la vita di Paolo mossa dall’urgenza della liberazione; quella di Bobi, più sottilmente, che ne asseconda un vagare per inerzia, senza presa (di nave non più guidata dal timone), e senza quasi comprenderla.
Sono narrazioni che scaturiscono per mancanza, che scostano il sentimento (l’amore: è già un gesto di possesso, una stretta, da cui fuggire) e insistono a guardare il punto inavvicinabile, inconoscibile dell’essere al mondo, accettandone – cercandone – sempre più insistentemente la necessaria solitudine.
Un movimento sotterraneo di contrazione alimenta il racconto: rilascia le figure al limite della dispersione, per poi costringerle nel tumulto di cambiamenti improvvisi, momenti di una rivolta cieca che si schiudono imprevisti quando tutto sembra perduto e il meccanismo della vita pare definitivamente richiudersi su se stesso. Sono eccessi, istanti in cui la vita si intensifica, e deborda in moti impensati e involontari: è quel continuo ritrarsi di Paolo con scarti prossimi al gesto stizzito e incontrollato di una fuga, di chi si sente braccato; gesti di una semplicità allarmante, messi in atto nell’impensato della pura superficie: come moti di rabbia o di ripicca, dove il dolore ha acquistato la forma acuta della rivolta.
E al fondo resta il tempo vuoto e un incedere verso il niente – il vagare indeciso, senza desideri – che mette in scena le sue figure: di perdenti, di vagabondi, di sconfitti. Ma è il sorriso dell’ingegner Berla – involontario, leggerissimo, sempre fuori luogo –, è quel suo vago ottundimento, la sua opacità al dolore, la sua incapacità ad afferrare il nesso tra causa e effetto (tutte rare qualità in negativo che proteggono, dell’angelica figura, l’innocenza), a divaricare l’idea di realtà, a mettere in luce l’eccezionalità del reale.
Al cospetto della disciplina della vita, qui è sempre in atto una distrazione, un rilascio di tensioni; e la volontà, che si è inceppata, fa spazio a un improvviso apparire di immagini – un turbarsi dell’aria e della luce, un baluginare della fantasia: quasi un moto di liberazione che si dà solo per perdita e per sottrazione, affamato di un respiro che sembra sempre mancare.
L’unicità della vita si spalanca, allora, in un movimento inconcludente e gratuito che sente il peso che la libertà gli impone. E c’è tutta la bellezza, dolorosissima, del riconoscimento di questa libertà: che è accesso a quel punto in cui tutto si fa incomprensibile, ignoto, immenso.
Il piano è quello di una lotta, dentro cui si formano, un’esperienza dopo l’altra, le mute in divenire del proprio esistere: La vita involontaria ne tiene vivo il dramma, il soffrire dei singoli atti, per provare a raccogliere il senso di tutte le immagini che vi turbinano dentro; Il ponte nel deserto dà invece posto a un dolore che, dal dentro del vivere, sbanda sempre i confini del presente, per richiudersi nella solitudine del suo protagonista, verso il ritrovamento della sua vera immagine e del suo vero nome.
Vita: come presa di forma e doveroso tentativo di cercarne il sembiante – solo illusoriamente al singolare –, come se il faticoso dovere di imparare a vivere fosse, in fondo, sempre opera d’immagini e di parole: apprendimento al nitore e accettazione di finzioni – necessarie, talvolta meschine – capaci di saldare i fori aperti dalla propria fantasia e allontanare da sé malformazioni e morte. Così che quel tastare, provare, verificare; quel sedurre – gli altri, la materia, le cose – accarezzandole e distruggendole, è un tentativo di circoscrivere il limite dentro cui potersi dire reali, tanto la nebulosa dell’esistere è intrisa di apparenze, di nebbie, di vapori, col rischio di vederla sfaldarsi a ogni momento.
Limite estremo, quasi impensabile nella sua semplice aderenza alla vita, è quel dovere di esistere a tutti i costi, quell’essere qui e ora a cui non ci si può sottrarre (il “Vietato scendere!” cui allude l’autobus del sogno, L’Autobus, 1976). Che poi è il riconoscere la vita come visibile presenza, che non si può nascondere o cancellare d’un colpo; e che, ancora, riconosciuta, – quasi per un maligno sortilegio – si spezza, forse già infranta nella sua stessa origine, da cui provengono gli echi delle colpe di un’innocenza perduta.
Uno sguardo insistito sulla vita, tra frammenti e scorze di reale, mostra il vuoto di un mistero impossibile da raggiungere, che non può essere afferrato sino in fondo: un luogo che vive escludendoci – per quanto se ne coglie la presenza, per quanto se ne deve la vita. La misura calma della scrittura ne lascia svaporare il malessere di fondo, che già risiede nelle profondità del pensiero e nelle trasformazioni che accoglie.
C’è qui l’uomo, il ragazzo, che preso di fronte alla cruda verità dell’esistere pone domanda alla propria esistenza nel punto in cui viene autenticamente avvertita: che si incanta, e stupisce del suo movimento e che, al culmine della sua insoddisfazione e della sua sconfitta, chiede ragione di quel dispiegarsi, giorno per giorno, in un vissuto.
L’estraneità e il vuoto a cui la scrittura sottilmente conduce sono qui le soglie care su cui si infrange ogni certezza del vivere: dove il vivere torna ad essere un regno sconosciuto e inesplorato, colto da terrori e intensità che, come l’infanzia, si fanno più propensi a coglierne le disgiunzioni, i divaricamenti, persino il non senso.
Le immagini continuano a essere sfingi contro cui batte testarda la costruzione della vita: dove ogni protagonista è incapace di dispiegare l’indovinello che gli è stato teso. Come se immagini e parole non trovassero qui un fondo, ma che proprio nello spazio insicuro, dilatato da quell’instabilità – nel disequilibrio e nell’incomprensione che vi alberga – ne venisse infine una possibilità di capire. Immagini e parole (Carafa tra studi di architettura e psicologia, la direzione di Montaggio-Rivista di poesia e fotografia, ne conosceva bene il nodo) abitano un loro regno che sospende il quotidiano vivere, ma sempre per scarti, sempre rifrangendolo: fotografia o specchio che non potrà mai essere coincidente, trasparente al reale. Che si fa invece figura sfocata e opaca, dai molteplici contorni (la fotografia del Bobi bambino); che si fa punto cieco, superficie annerita e consunta (specchio della Regina Claudia), dentro cui guardare: come se nell’inquietudine di quella mancata perfezione, di quella perduta nitidezza ci fosse il movimento autentico (malvagio, malato, perché libero, perché votato all’inconcludenza, e a trarre dalla vita il suo fondo di insicurezza e di paura) di una ricerca della vita.
C’è una forma di stordimento benigno nell’immagine: quando si incanta nel suo trasmutare, nella giostra del suo scomporsi, e diverge sull’orlo del suo proteiforme apparire, senza farsi acciuffare da una forma conclusa. Fa danzare, anzi, la vita, sui bordi della sua esistenza dove “tutto è sempre possibile, dalla gentilezza all’assassinio, dall’intelligenza alla perdita della ragione, dalla vita al nulla”. E poi, presa a distanza, nello splendore di tutto il suo infinito apparire, la scrittura ne accosta l’inconsistenza (leggera, liberatoria) che vi regna al fondo: “oh lo sciamare insensato della folla sul viale, lo stolido chiacchiericcio, l’intersecarsi in un punto, un solo punto di labili esistenze tracciate a caso! Macchie di gonne colorate, sagome nere, nodi di gente all’entrata del cinema, curve figure sulle panchine dietro ai giornali, immerse in un pulviscolo luminoso”.
Ci sono momenti, rari, di leggerezza a cui questo scrivere tende; momenti in cui la mente pare distendersi e le imposizioni del vivere – le sue trappole, i suoi spasmi – per un poco si rilasciano e prendono fiato. Forse già nel gesto di sollevarsi da terra per inghiottire aria del ragazzo dei Tetti Rossi che Pintus, di ritorno – come dottore – alla casa manicomiale su cui avevano preso forma le sue immaginazioni di bambino, emula: ancora una volta per provare, per capire. Ma che improvvisamente si scopre ricongiungere alla sua più intima formazione, alla vita da cui proviene: e farne, per la prima volta, immagine meno estranea, più vicina.
Il movimento alterno di dilatazione e di compressione che dal gesto scaturisce, porta in sé, vivida, una spalancatura, che è la necessità liberatoria di un’apertura che la scrittura qui regala. In Il ponte sarà lo schiudersi di immagini gratuite e limpidissime, semplicemente votate alla bellezza del loro apparire.
Non quindi un senso, uno scopo, un eroismo quanto si persegue: ma il faticoso affioramento – come su una lastra fotografica – di quelle immagini a cui i protagonisti, inconsapevolmente, sono rimasti da sempre fedeli, verso cui hanno consumato le loro figure, i loro sofferenti distacchi.
Come a dire che il senso della vita a cui Paolo e Bobi hanno da sempre inavvertitamente teso, era già compreso – qui, come nelle tragedie – in un suo iniziale compimento: luogo unico, dentro un paesaggio di frammenti, in cui si dà – possibile – una coincidenza. Ed è il punto in cui si fa largo un’apertura sull’esterno: splendente in tutto il suo vuoto, in quella spaccatura d’aria e di mistero che lo forma. Ne nasce un’immagine (poetica) di leggerezza, sola capace di coincidere l’esterno all’immagine densa, profonda, intensiva di sé: nel punto in cui avviene il riconoscimento del proprio destino. È visione realissima dell’anima, quel ponte nel deserto progettato dall’ingegner Berla/Miguel, e destinata, per poter vivere intatta nella sua libertà, a farsi invisibile e a sperdere fin le ultime tracce – calcoli, disegni – della propria esistenza.
Ma ancora resta nella mente di chi legge – incanto, follia della parola – lo splendore di una campata sottile che collega il niente al niente, che come un arcobaleno si inarca nello spazio, che si muove leggera come suono ecc.
Prose di Brianna Carafa:
La porta di carta, in «Botteghe oscure» n. XIX, 1957, pp. 549-554;
Il sordo, in «Botteghe oscure», n. XIX, 1957, pp. 554-557;
Il Giardino perduto, in «Paragone-Letteratura», n. 198/18, agosto 1966, pp. 84-97;
La Governante, in «Paragone-Letteratura», n. 256, giugno 1971, pp. 74-104;
Altrove, in «Paragone-Letteratura», n. 274, dicembre 1972, pp. 18-35;
L’autobus, in «Paragone-Letteratura», n. 312, giugno 1976, pp. 62-76;
Ritratto di straniera, in «Paragone-Letteratura», n. 338, aprile 1978, pp. 3-34;
Le marionette (inedito).
La vita involontaria, Einaudi, Torino 1975.
Il ponte nel deserto, Einaudi, Torino 1978.