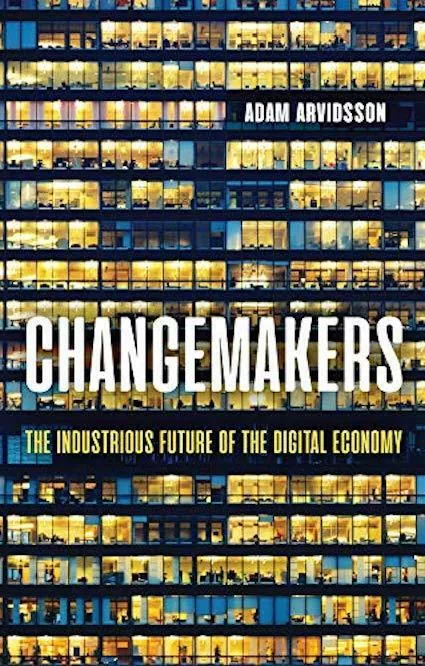Capitalismo e micro-reti / Changemakers: i pirati della modernità
Nonostante sia un libro agile e scritto per essere accessibile al famoso pubblico al di fuori dell’accademia, Changemakers (Polity Press, 2019; trad it, Luca Sossella editore) di Adam Arvidsson è un libro che condensa anni di viaggi di ricerca, interviste, osservazione partecipante da Bangkok a Hong Kong, da New Delhi a Napoli, da Parigi a Londra e Milano.
È innanzitutto un libro sulla storia del capitalismo, sulle sue dimensioni attuali (sia quella americana che quella cinese), sul suo futuro e sostiene che l’attuale capitalismo digitale, figlio del capitalismo industriale, è alle corde. Ma a differenza di tanti critici superficiali del capitalismo, non ci illude né con la prospettiva di un nuovo commonalismo all’orizzonte, né ci consola dicendoci che il capitalismo finirà con una rivoluzione.
Mentre tutti i critici del Capitalocene (una visione più critica dell’Antropocene, che sostiene che l’impatto negativo dell’uomo sull’ambiente è da imputarsi non tanto all’uomo in sé ma al modello produttivo capitalista) volgono lo sguardo al parallelismo tra gli anni 20 e 30 del Novecento e i giorni nostri, Arvidsson ci invita a spingere lo sguardo molto più indietro e trova che il periodo storico che stiamo attraversando non è tanto simile a quello di cento anni fa, quanto piuttosto è in continuità con il lungo cambiamento storico iniziato con la crisi del feudalesimo nel XIV secolo e che ha attraversato il XVI e il XVII secolo aprendo la strada alla formazione del capitalismo industriale.
Il suo lavoro batte le stesse tracce di libri più recenti, come Post-capitalismo (2017, Il Saggiatore) di Paul Mason, La società a costo marginale zero (2014, Mondadori) di Jeremy Rifkin e il libro di Naomi Klein sul clima, Una rivoluzione ci salverà (2014, Rizzoli), ma a differenza di questi saggi, tutti scritti da giornalisti, ha la forza e il rigore di un saggio accademico, scritto da uno scienziato sociale che ha dedicato anni di ricerca a questo lavoro. Mentre i libri di Mason, Rifkin e Klein, per quanto offrano spunti interessanti, sono tutti viziati da una serie di superficialità e visioni naïf o tecno-deterministe della società, il lavoro di Arvidsson è il frutto di una ricerca storica e di una prospettiva teorica solidi, che restituiscono un quadro più complesso della realtà rispetto ai lavori di questi autori. Per prospettiva e metodo è piuttosto un libro “arrighiano”, quasi una continuazione del libro più famoso di Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo (1994) e condivide col predecessore la stessa capacità di leggere il presente attraverso un profondo sguardo storico-politico sulla lunga transizione che ha portato all’emergere del capitalismo industriale.
Mentre in Italia tutti i critici del capitalismo si riducono a imbracciare Mark Fisher per uscirne annichiliti (ma anche compiaciuti) dalla prospettiva di un “realismo capitalista”, una condizione ormai naturalizzata e astorica da cui non si può sfuggire, Arvidsson (come in passato avevano già fatto Polanyi e Arrighi) restituisce al capitalismo una dimensione storica che ne enfatizza le cicliche fasi di espansione, dominio e declino.
Fisher è il giocattolo dei critici superficiali del capitalismo, il prodotto perfetto per compiacere il carattere crepuscolare dei giovani lavoratori cognitivi figli dei ceti medio-alti frustrati dalla crisi economica. Il libro di Arvidsson dovrebbe rappresentare invece il contrario: il prodotto perfetto per i “changemakers”, i “fuori-casta”, gli outsider e più in generale tutta quella classe globale emergente che sta crescendo al di fuori del perimetro del capitalismo industriale.
Arvidsson sostiene che il capitalismo industriale è in crisi, che nemmeno la sua trasformazione in capitalismo digitale è riuscito a salvarlo. Sostiene che il modello delle start-up della Silicon Valley non è capace di produrre valore e di assicurare lavoro e che, al contrario di quanto dice Zuboff (Capitalismo di sorveglianza, 2019), il capitalismo digitale non è capace di “sfruttare” in maniera particolarmente efficiente il surplus di lavoro gratuito fornito da utenti delle piattaforme e lavoratori della Gig Economy. Il modello della Silicon Valley tende a standardizzare l’innovazione e a soffocare la crescita economica, senza riuscire ad essere davvero redditizio né a creare lavoro. L’autore afferma che siamo entrati in una fase di declino del capitalismo industriale e apre all’esistenza di un futuro oltre il realismo capitalista, un futuro che chiama “industrioso” e che potrebbe assomigliare a una sorta di “modernità pirata”:
“All’orizzonte, possiamo forse intravedere dubbi imprenditori clandestini che sfornano semi di pomodoro modificati geneticamente per sopravvivere alle condizioni alterate dell’antropocene” (p. 16).
Seguendo la traiettoria di Arviddson e provando a interpretarne il pensiero, potremmo immaginare un futuro in cui forse l’università sarà scomparsa, o esisteranno università gestite da corporation tecnologiche, ma accanto a queste, a Bombai come a Napoli o a Città del Capo, potrebbero sorgere micro-università fatte di “professori/imprenditori clandestini”, che esercitano autonomamente la propria professione, magari associandosi a piccoli cluster di professori con cui condividono metodi e pensiero. Queste micro-reti di professori che non hanno ricevuto alcuna abilitazione ministeriale, potrebbero accettare con sé un numero limitato di discepoli, dislocati in tutto il mondo, che seguono i loro corsi su piattaforme sviluppate non da grandi corporation ma da micro-imprese indiane o brasiliane e li ripagano tramite monete digitali. Sarebbero dei professori/pirati, che potrebbero anche ricreare lo spirito primitivo delle università medievali e dare vita a una rivoluzione dell’educazione.
Questa modernità pirata potrebbe dispiegarsi non solo nell’educazione, ma anche in altri settori, come in parte sta già accadendo: esiste una “globalizzazione dal basso”, una rete di flussi economici tra imprese di piccola scala, che è parallela alla globalizzazione delle grandi imprese, e che sta trasformando i paesi del Sud Globale.
Se le istituzioni della modernità industriale (fabbriche, partiti politici, sindacati, università) stanno lentamente collassando, cosa abbiamo di fronte?
Van Dijck et al. sostengono che abbiamo di fronte una società “piattaformizzata”, dove le piattaforme digitali gestite da venture capitalist estendono il proprio ruolo di intermediari su porzioni sempre più ampie della società e dell’economia. Non solo partiti digitali, non solo gig economy e lavoratori che hanno per capo un algoritmo, ma anche sistemi educativi e sanitari gestiti da piattaforme digitali di proprietà privata. Lo specchio oscuro (Black Mirror) del Covid, ci ha permesso di osservare più da vicino scenari che sembravano ancora lontani, come università online erogate tramite piattaforme google o cura della persona monitorata tramite app.
Van Dijck e i suoi mostrano i pericoli di una società le cui funzioni vitali (politiche, culturali, economiche, sociali) siano mediate e governate da oligopoli di grandi aziende tecnologiche americane e (sempre più) cinesi. Di fronte ai rischi di una società governata da grandi corporation globali della tecnologia, propongono un modello europeo, social-democratico, di società di piattaforma, governato da investimenti pubblici e regolamentato dall’Unione Europea.
Arvidsson va oltre questo scenario, che oppone grandi multinazionali private a stati nazionali e organi internazionali, e prevede una modernità industriosa e pirata di cui, secondo lui, oggi stiamo soltanto intravedendo l’alba, ma che, come in un lungo cross-fade, lentamente emergerà dal declino più o meno traumatico della modernità industriale:
“In questo prolungato periodo di collasso sistemico, la modernità industriosa potrebbe offrire il progetto di un modello sociale diverso in grado di sopravvivere, e forse anche prosperare, in quello che rimane delle “rovine capitaliste” (p. 26).

“l’affermazione del settore industrioso è dovuta anche a nuovi beni comuni che derivano dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione della produzione e della cultura capitalista, oltre che all’affermazione di una serie di alternative come i software free o open source oppure le comunità di peer production. Questi nuovi beni comuni rendono più semplice ed economica l’organizzazione di operazioni aziendali complesse. Con poca spesa, è possibile avviare una start-up oppure importare e distribuire elettronica a basso costo sui mercati popolari europei e africani tramite il complesso coordinamento di una serie di produttori e intermediari su piccola scala. Proprio come i beni comuni che sostennero le “piccole aziende” nella creazione di un’emergente società di mercato in Europa durante il Medioevo, i nuovi beni comuni digitali hanno conferito una particolare forza all’imprenditoria industriosa contemporanea” (p. 16).
Arvidsson sostiene che, grazie all’abbattimento dei costi di produzione delle merci favoriti dalla proliferazione di strumenti digitali, sta emergendo una nuova forma di imprenditorialità diffusa, peer-to-peer, che non ha come unico obiettivo quello di “fare soldi”, ma vuole anche cambiare il mondo. Il declino del capitalismo industriale descritto da Arvidsson ha creato un crescente esercito di riserva di individui sottoccupati e altamente qualificati che stanno usando questi nuovi beni comuni digitali per realizzare un tipo diverso di modernità, sia in vista dei propri progetti di vita che di “comunità” più ampie.
“L’accumulazione di disfunzionalità che, molto probabilmente, segnerà il futuro del capitalismo aprirà nuovi spazi in cui un’economia industriosa decentralizzata potrà affermarsi e diventare più attraente man mano che risponde a un’ampia serie di esigenze popolari e fornisce le nuove forme di innovazione necessarie, proprio come la crisi del feudalesimo nel XIV secolo generò uno spazio in cui trovarono terre- no fertile le corporazioni e l’economia di mercato basata sui beni comuni supportata dalle corporazioni stesse. Magari un’economia industriosa decentrata di questo tipo potrebbe essere in grado di sfruttare il potere dello stato a proprio vantaggio, forse anche inventando, strada facendo, forme politiche radicalmente nuove. È possibile anche che questa economia somiglierà a un bazar globale regolato in maniera informale che opera dai vicoli del pianeta delle baraccopoli globali per creare nuova vita dalle rovine” (p. 17).
I motori di questa modernità industriosa che l’autore vede crescere all’orizzonte sarebbero due diversi soggetti storici. Così come il capitalismo industriale, secondo Weber, era stato modellato dall’etica e dall’industriosità/operosità dei puritani protestanti, la nascente modernità industriosa (o neo-industriosa) sarebbe opera di una nuova etica, imbracciata da due diversi soggetti storici: da un lato i lavoratori della conoscenza in discesa della società occidentale, che non sono stati capaci di riprodurre la posizione privilegiata di classe dei propri genitori perché non si sono inseriti nel lavoro d’impresa o lo hanno abbandonato per fondare una start-up; dall’altro persone dalle origini più popolari in ascesa, “come il migrante urbano che apre un negozio di riparazioni per telefoni cellulari e diventa a sua volta datore di lavoro” (p. 21). Questi due attori rappresentano la dimensione borghese e popolare della modernità industriosa e nonostante le differenze di classe, hanno in comune indici di produttività e guadagni (bassi) e soprattutto condividono una stessa visione del mondo, che Arvidsson chiama “etica industriosa” (p. 80) e che è fondata sulla volontà di cambiare il mondo attraverso la propria imprenditorialità. Questa etica industriosa rappresenta la risposta esistenziale più importante alla precarietà che deriva dal collasso sistemico.
Proprio come per Weber, l’industriosità di oggi è strettamente legata alla nozione di imprenditorialità. È in quanto imprenditori che è possibile cambiare il mondo. Questo cambiamento non è semplicemente di tipo economico ma, piuttosto, l’imprenditorialità è diventata una sorta di progetto esistenziale (p. 84). Per le nuove generazioni di lavoratori cognitivi entrati da poco nel mercato del lavoro, non importa guadagnare bene, importa realizzarsi, essere creativi, fare qualcosa di “significativo” e per questo sono pronti a sacrificare una carriera in una grande azienda per la fondazione di una piccola start-up, dalle dubbie fortune, che sia una nuova birreria artigianale, un servizio di food-delivery di cibo biologico o di gelati a domicilio prenotati tramite app. Abbracciano stili di vita differenti, sperimentano forme di vita neo-comunitarie nei sobborghi cool delle capitali del sud globale, si organizzano in co-working dove praticano il design-thinking e il networking, alla costante ricerca di senso e impatto sociale. In maniera analoga alle corporazioni e alle confraternite commerciali che ebbero origine nelle città europee dell’alto Medioevo, l’imprenditoria digitale è accompagnata da tentativi di creare e strutturare i mercati secondo idee comunitarie di equità ed etica (p. 137): ecco chi sono i changemakers del titolo. Ma lo spettro di questa comunità industriosa è ampio, abbiamo detto, mette insieme i figli del ceto medio occidentale in caduta e i figli del ceto popolare globale in ascesa, entrambi alla ricerca di un lavoro dignitoso al di fuori del circuito capitalista, evitando i “lavori di merda” (bullshit jobs, Graeber) dentro i magazzini neo-industriali di Amazon.
In questa formazione sociale eterogenea di ceti globali medi e popolari che cercano una propria strada nel mondo attraverso una forma di imprenditorialità di sé su piccola scala ma (secondo loro) a grande impatto sul mondo e che si affidano ai nuovi commons digitali, Arvidsson vede i semi di un diverso immaginario, l’emergere di una nuova “economia morale”, parente dei puritani che avviarono il nuovo ciclo storico del capitalismo industriale, e forse capace di traghettare la società contemporanea al di fuori del capitalismo industriale, verso una forma più sostenibile di produzione su piccola scala, più flessibile nell’adattarsi ai cambiamenti climatici ed economici. La (ri)apparizione storica di uno strato intermedio industrioso coincide con una ristrutturazione dell’economia capitalista.
La traduzione del libro di Arvidsson è importante perché rende il dibattito italiano sulla critica al capitalismo più vitale e gli impone di confrontarsi con le sue contraddizioni, liberandolo dalla facile critica stantia al capitalismo.
Ha però un limite, potenziale, un limite che potrà essere definito tale solo tra molti anni, quando io e voi non saremo più qui per dire “ecco, non è andata come prevedeva”.
Questo limite consiste nel riporre forse troppa speranza nella possibilità che questa nascente classe industriosa e piratesca sia capace di sostituire, nel lungo periodo, il capitalismo industriale.
Se guardiamo anche noi alla storia, vediamo come, in passato, simili appropriazioni di beni comuni fondate sul rifiuto delle forme capitalistiche delle loro epoche, abbiano poi portato non all’abbattimento, quanto alla rigenerazione del capitalismo, alimentandone un nuovo ciclo di accumulazione: la controcultura della New Left e degli hippies americani che negli anni Sessanta rifiutava la burocrazia e la gerarchia della società industriale dell’epoca, ha prima dato vita al movimento delle comuni e poi sottratto le tecnologie digitali (computer e internet) al comparto militar-industriale, democratizzandone gli usi sociali. I giovani che volevano cambiare il mondo negli anni Sessanta del Novecento e che rifiutavano un lavoro all’IBM o in una grande amministrazione pubblica, hanno fondato start-up e trasformato la società industriale in una società fondata su reti anti-gerarchiche. Sognavano la società conviviale che avevano letto sui libri di Illich, sognavano di cambiare il mondo progettando computer conviviali e hanno invece, inconsapevolmente, offerto al capitalismo dell’epoca i valori per rigenerarsi e adattarsi ai mutamenti della società. Hanno trasformato le rigide organizzazioni aziendali in una sorta di “comune” permanente (la start-up con il capo guru e l’amaca tra le scrivanie), ma le comunità virtuali e virtuose create da questi tekno-freak si sono poi trasformate, trent’anni dopo, in Facebook e Google, avviando un nuovo ciclo di accumulazione del capitalismo.
È la storia raccontata dallo storico culturale americano Fred Turner in From Counterculture to Cyberculture, un classico del 2006 rimasto senza traduzione italiana, e per certi versi è anche la storia raccontata da Boltanski e Chiapello in Il nuovo spirito del Capitalismo (1999).
Se i puritani di Weber hanno rappresentato i precursori involontari dello spirito del capitalismo moderno, forse questa nuova classe industriosa rappresenta il precursore involontario del capitalismo che verrà?
Questa nascente classe industriosa globale rappresenta forse il nuovo soggetto politico in grado di conferire un nuovo spirito al capitalismo contemporaneo, invece di rappresentarne un’alternativa.
Il limite del libro sta nel riporre troppe speranze in questa nascente moltitudine pirata dotata di tecnologie peer-to-peer, ma forse, più che un limite, è il punto di vista di cui abbiamo bisogno per poter continuare a credere che sia possibile cambiare il mondo e il capitalismo. D’altronde il libro apre con Gramsci e mantiene le promesse, perché in tutto il suo percorso rimane sempre in bilico tra pessimismo della ragione e ottimismo della volontà, tenendo a distanza qualsiasi facile naturalizzazione (alla Fisher) della condizione neoliberale contemporanea.