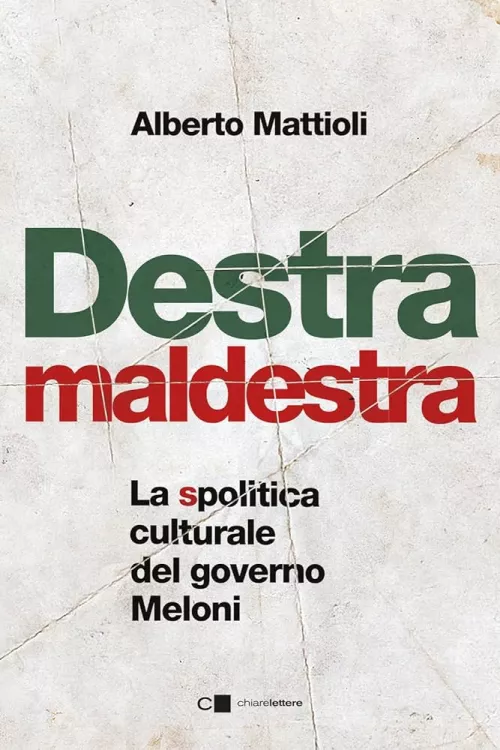Destra senza cultura e con poltrone
La sentenza di Alberto Mattioli, alla vigilia delle elezioni europee, è senza appello: “A questa destra, purtroppo, manca tutto quel che servirebbe per fare una vera politica culturale. Per questo resta una destra maldestra.” Così si conclude Destra maldestra. La (s)politica culturale del governo Meloni (chiarelettere, 2024), il pamphlet in cui uno dei massimi esperti italiani di teatro musicale si diverte (e ci diverte) a tracciare il bilancio di un anno e mezzo di governo di destra.
Genny-la-Gaffe e Bacchetta Nera
Mattioli non è un punk, né un avanguardista, né un provocatore. Non lo è per gusto, per inclinazione personale, per visione politica. Gli italiani che gli mancano di più, oltre a Federico Zeri, sono “Alberto Arbasino, Paolo Poli, Umberto Eco, Franca Valeri, Paolo Isotta, Claudio Abbado, Fruttero & Lucentini, Monica Vitti, Edmondo Berselli” (p. 61). Non gli piace il fascismo, ma non sopporta il riflesso condizionato di chi urla al lupo a sproposito. Il suo ideale sarebbe una destra moderna e liberale, ma la prassi politica di Giorgia & Co. – e in generale delle destre italiane – è ancora molto lontana da questa utopia.
Allora Mattioli se la spassa a prendere le misure al ministro Genny-la-Gaffe, a Bacchetta Nera, ovvero Beatrice Venezi, a Pino Insegno, con il suo cachet (pare) di 2 milioni di euro in due anni con il megaflop dell'Eredità: ma di quei denari la destra non si lamenta, salvo poi far scattare la censura RAI con la scusa dei 1800 euro (lordi) ad Antonio Scurati per il suo minuto di monologo sul fascismo (con il sottinteso che con la cultura non si mangia e non si deve mangiare, con l'intrattenimento invece sono soldi ben spesi...).
E poi (senza nominare Luca Barbareschi, su cui Mattioli pudicamente tace), c'è l'eterna promessa della destra colta. Destra maldestra dedica un saporito capitolo al “sindaco di Arpino, prosindaco di Urbino, assessore alla Bellezza a Viterbo, presidente della Fondazione Ferrara Arte e del Museo Alto Garda di Riva, commissario per le Arti di Codogno e, in precedenza, fra le altre cose, assessore alla Cultura della Regione Sicilia, sindaco di Sutri, di San Severino Marche e di Salemi, due volte deputato, europarlamentare”, per due volte sottosegretario alla cultura e per due volte “dimissionato” (anche da questo governo, con raffica di insulti al suo ministro). Attualmente l'ex enfant prodige ma ormai anziano Vittorio Sgarbi è candidato alle elezioni europee e sta facendo campagna elettorale a bordo di una “Capramobile” che sembra usciva da una gag sia futurista sia strapaesana.

Vittorio Sgarbi
Se Sgarbi deve accumulare tutte quelle poltrone, evidentemente il centrodestra non dispone di una sufficiente riserva di chiappe qualificate per incarichi di prestigio (e con adeguate prebende). Emerge un problema che si poteva prevedere anche prima della vittoria alle elezioni del 2022. Proprio Sgarbi, in combutta con Francesco Giubilei (presidente della Fondazione Tatarella e di Nazione Futura, nonché autore della biografia politica Giorgia Meloni. La rivoluzione dei conservatori, Giubilei Regnani, 2020), aveva lanciato l'appello Rinascimento per la Nazione Futura, in un video su Facebook rilanciato sul “Corriere della Sera” con una lettera aperta. Per Sgarbi e Giubilei, il centrodestra, che “si deve accingere a governare, anche grazie alle contraddizioni e al caos del centrosinistra, non può in alcun modo lasciare l’agenda culturale alla propaganda del PD. (…) Non dedicare la giusta attenzione al mondo dell’editoria, dei teatri, dei festival e delle manifestazioni culturali significa non tenere in considerazione settori che interessano milioni di italiani. La sinistra, applicando il concetto gramsciano di egemonia culturale, si è impossessata del tema della cultura attraverso una capillare occupazione degli spazi a tutti i livelli nominando persone vicine al mondo progressista. Regalare un tema centrale per il futuro del Paese come la cultura alla sinistra sarebbe un errore” (Vittorio Sgarbi e Francesco Giubilei, “La cultura non è del Pd. Il centrodestra ci punti partendo dai candidati”, in “Corriere della Sera”, 13 agosto 2022). Nel campo della cultura, quella lettera è stato l'unico evento significativo della campagna elettorale.
Gramsci è di destra?
Come racconta Mattioli, gli ex missini, da settant'anni esclusi dalle stanze dei bottoni, da qualche tempo sono divenuti fan dell'“egemonia culturale” (vedi il volume di Alessandro Giuli, ex militante di Meridiano Zero da poco alla direzione del MAXXI di Roma, Gramsci è vivo. Sillabario per un'egemonia contemporanea, appena pubblicato da Rizzoli). A partire dal falso sillogismo “egemonia culturale = presidenze, direzioni e consigli d'amministrazione” (non funziona così, ma serve in ogni caso a sistemare amici e clienti), hanno cominciato a razziare poltrone, a cominciare (ovviamente) dalla RAI. Lo spoils system, esasperato dal maggioritario, ha visto blitz, colpi di mano (come la grottesca vicenda Fuortes-Lissner, p. 24), trasformismi e compravendite, perché gli intellettuali italiani, “si sa, vengono via con poco”, come sibilava Livio Garzanti. Non è una novità, è il metodo adottato da sempre da tutte le forze politiche in Italia, dove la fedeltà vale più della competenza e del merito. Ora l'amichettismo, insaporito con cognati e affini, tracima da sinistra a destra (pp. 41-42).
Poltronissime
In casi estremi, quando diventa impossibile mettersi d'accordo sul candidato tra destra e sinistra, si ricorre alla moltiplicazione delle poltrone: una può andare alla destra e l'altra alla sinistra, con due stipendi dirigenziali a spese del contribuente, secondo il vecchio schema consociativo. È la soluzione al recente caos al Teatro di Roma, ma era stata goffamente tentata anche al Salone del Libro di Torino.
A ben guardare, però, come nota Mattioli, “non mancano i soldi, mancano gli uomini, e le idee. Manca il coraggio di inventare, scommettere, cercare il nuovo senza rinnegare il vecchio.”
La priorità di molte politiche culturali (a destra, al centro e spesso anche a sinistra) non è certo la progettualità culturale, il successo di pubblico, la qualità della proposta e nemmeno l'attenzione ai bilanci, nonostante i bandi direttoriali sempre più spesso insistano su questo aspetto. L'importante è da sempre che non esplodano gli scandali che portano la cultura in prima pagina. Dunque, più che manager, alla politica servono commissari politici in grado insabbiare e smussare le provocazioni, ovvero ciò che dovrebbe nutrire la cultura. Senza una visione, questa carica alle alte cariche può portare solo alla censura.
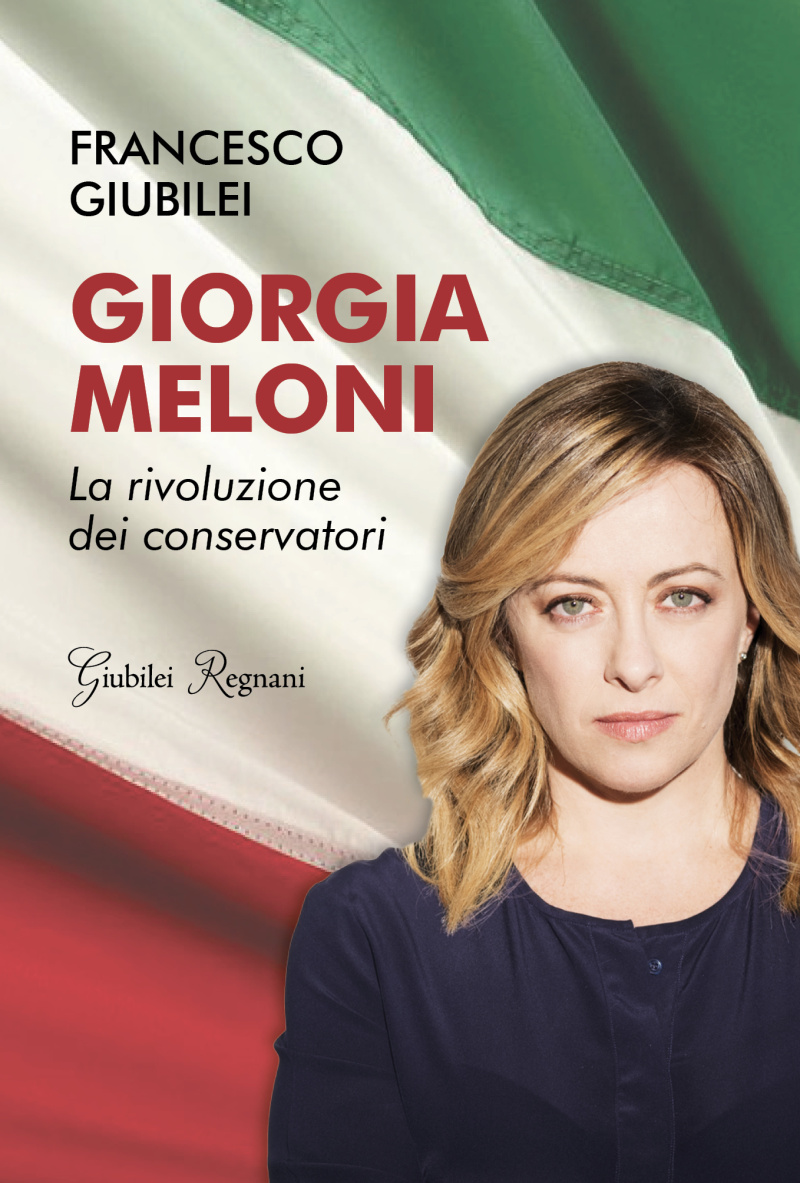
Alla cieca
Perché l'egemonia culturale non è questione di poltrone, servirebbe anche una visione. Prima delle idee, però, bisognerebbe avere un minimo di competenza, e magari essere vagamente aggiornati. A far imbestialire le anime belle della cultura conservatrice, quelle che la scorsa estate invocavano “il figurativo” conto l'astratto, l'installativo, il performativo di fronte alla Biennale Arte 2024 (peraltro una delle più figurative degli ultimi decenni, se avessero guardato), sono per cominciare le messinscene di classici in abiti moderni, come dimostra l'imbarazzante direzione d'orchestra a occhi bendati di Alberto Veronesi a Torre del Lago la scorsa estate (con il supporto di Sgarbi). Voleva essere una provocazione nei confronti del regista Christophe Gayral, colpevole di aver oltraggiato la Bohème ambientandola nel Sessantotto, è risultata ridicola e offensiva per gli orchestrali e per il pubblico (p. 62).
Dopo l'ossessione storicistica di fine Ottocento, con le sue ricostruzioni peudo-filologiche di antichità e medioevi di gesso e cartapesta, i primi classici in abiti moderni erano già arrivati negli anni Venti del Novecento, con il Macbeth del Birmingham Repertory Theatre ambientato tra le trincee della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo alle spalle un secolo di attualizzazioni più o meno sconsiderate, ma questo non basta a placare chi ha un rapporto irrisolto con la storia e non riesce nemmeno a fare i conti con il fascismo.
Lo strabismo culturale
Perché la destra soffre di “una specie di strabismo culturale, che fa guardare solo indietro” (p. 83). “Che bello quando le donne restavano chiuse in casa” (o nei bordelli), e naturalmente non potevano abortire. “I bei tempi della leva obbligatoria”, quando noi italiani eravamo “brava gente”, nonostante le nefandezze in Libia, Etiopia, Balcani... “Che buona la cucina di una volta”, rimuovendo che il nostro era Il paese della fame, come ha mostrato Piero Camporesi in uno dei suoi capolavori (Garzanti, 2018) e che La cucina italiana non esiste, come spiega il saggio di Alberto Grandi e Daniele Soffiati (sottotitolo Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici, Mondadori, 2024). “La felicità di quando eravamo solo noi”, i tutti visi pallidi, rimuovendo il razzismo contro gli “italiani cincali”, costretti a emigrare all'estero, raccontati da Mario Perrotta nei suoi monologhi. “Quando c'era lui”, ovvero l'eterno “Mussolini ha fatto anche cose buone”, perché, chiosa Mattioli, “nessun regime che dura vent’anni può, nemmeno impegnandosi al massimo, fare soltanto cose cattive, e perfino Hitler costruì le autostrade e inventò il Maggiolino” (p. 80).
La regressione culturale
I vaneggiamenti regressivi del generale Vannacci sono solo la caricatura involontaria dell'ignoranza che fa di un'immaginaria identità culturale un feticcio per azzerare i diritti conquistati da decenni di lotte della società civile. Legittimano una visione per cui i classici devono restare nei musei, sotto teca, senza venirci a disturbare e inquietare. Non devono rendere visibili le contraddizioni della società in cui viviamo, a partire da quelle del passato. Al massimo, la storia dev'essere utilizzata per riti identitari patacca, come la sacra ampolla offerta alle sorgenti del Po al dio Eridano, l'invenzione di Umberto Bossi, o per copiare l'emblema della Lega dal marchio di una fabbrica di biciclette. Non fa differenza se è fantasia storica o invenzione romanzesca, come dimostrano la festa di Atreju, che prende il nome dal protagonista della Storia infinita di Michael Ende (Salani, 2017), in lotta “contro il nulla che avanza”, o l'appropriazione del mondo di Tolkien, al centro della mostra sponsorizzata da Sangiuliano. Questa negazione della storia a favore del fantasy, ovvero l'invenzione della tradizione (vedi Eric Hobsbawm e Terence Ranger (a cura di), The Invention of Tradition, Cambridge University Press, 1983), impedisce alla destra di fare i conti con la modernità e con le sue complessità, indirizzando il mix di rabbia e rancore, di insicurezze, semplificazioni e frustrazioni da cui nascono i populismi, nella nostalgia per un passato che non ritornerà mai anche perché non è mai esistito.
Quanto è grande la tua identità?
A rendere impossibile la sintesi tra le diverse anime della destra è anche l'orizzonte geografico della radice identitaria di riferimento. I post-fascisti s'appellano ovviamente alla Patria o alla Nazione (con le maiuscole d'obbligo). Per i Leghisti, a seconda delle opportunità indipendentiste o autonomiste del momento, il raggio è di volta in volta la Padania (di cui nessuno ha mai definito i confini), la Regione (soprattutto se c'è un Governatore acchiappavoti) o forse il Comune (e perché non la frazione, il quartiere, la social street?). Evitando in ogni modo di confrontarsi con i diversi modelli di sviluppo che offre l'Europa. A unire gli uni agli altri in un provincialismo regressivo è solo l'allergia agli arroganti “stranieri”, che sulla base delle norme europee osano partecipare ai bandi per la direzione delle istituzioni culturali, ed essendo competenti e preparati li vincono: e spesso operano più che bene, come nel caso di diversi importanti musei e teatri lirici (per vedere un esempio di bando pessimamente scritto per escludere giovani, donne e stranieri, vedi Quante donne si possono candidare alla direzione di Marche Teatro?).
Localismo e centralismo
Nella pratica, qualunque politica culturale è impossibile se non si trova un equilibrio tra centralismo ministeriale e localismo, tra la visione sovranista di Fratelli d'Italia e quella della Lega, che si nutre di sagre paesane, di rievocazioni storiche e di antichi mestieri. Mentre quel che resta del berlusconismo può solo pensare di subordinare la cultura al mercato e all'intrattenimento (perché con la cultura non si mangia) o di usarla come “il nostro petrolio” per la promozione turistica (anche se l’Open to Meraviglia caro alla ministra del turismo Daniela Santanchè si è rivelato l'ennesimo flop sprecone delle nostre istituzioni, dopo i milioni già buttati per VeryBello o ItsArt).
Non sorprende che in questo quadro emergano proposte improvvisate, sgangherate ed elettoralistiche, come la legge sui “teatri comunali monumento nazionale” (naturalmente a costo zero), capace solo di titillare l'orgoglio strapaesano di politici e giornalisti.
Cultura e democrazia
Per Mattioli, “mancano l’abilità diplomatica, la souplesse, il gusto del paradosso e della provocazione intelligente, l’uso di mondo, la leggerezza calviniana come antidoto alla grevità di una cultura autoreferenziale e moralistica” (p. 105). Suggerisce che queste spezie sarebbero utili anche per demolire alcuni riflessi condizionati di una sinistra intrappolata nel politicamente corretto.
Ma forse nella visione della destra c'è un altro anello mancante: la cultura non è solo e tanto un collante identitario (e men che meno un acchiappaturisti), ma anche e soprattutto uno strumento di trasformazione delle persone e della società. Perché, come indica la Costituzione (e come dimostra la recente indagine della Comunità Europea Culture & Democracy. The evidence), il dibattito culturale è da sempre un ingrediente indispensabile della democrazia.