Dizionario Manganelli 2. Arte
Nel «dizionario impazzito» di Giorgio Manganelli, «arte» è un lemma da maneggiare con estrema cautela. In primo luogo, perché la sua stessa accezione rischia di rifrangersi in cinquanta sfumature contraddittorie e inservibili e, secondariamente, perché non è facile stabilire che cosa rappresenti davvero l’arte per Manganelli. La carrellata descrittiva su quadri e chincaglierie d’antiquariato impone al narratore un momento di stasi durante il quale l’invenzione verbale deve scendere a patti con un referente. Decorato, istoriatissimo, coloratamente a disposizione per qualsiasi digressione o amplificazione retorica, eppure collocato ‘in tela e ossa’ di fronte all’osservatore, come un dato panciuto e tridimensionale. Se la realtà è un concetto relativo, giacché, per Manganelli, non esiste esperienza verificabile fuori dalla comunicazione linguistica, i dipinti e le sculture rimangono delle cose imbarazzantemente reali.
Gli esseri umani sono fantasmi, e «fantasmi risibili, da poemetto eroicomico» si rivelano le loro passioni e peripezie quotidiane. Le opere d’arte, invece, dando consistenza materiale a queste apparizioni, si trasformano nelle raffinatissime case di marmo e acquerello in cui passeggiano spettri, archetipi e rimozioni diurne. In una conversazione con Lea Vergine ospitata su «alfabeta» nel maggio del 1982, Manganelli definirà il museo un «luogo di raccolta dei fantasmi», nonché una «gigantesca figura retorica che cerca di proteggere dei momenti di una dinamicità furibonda». Nel glossario formulare di Manganelli, fantasmi e retorica sono due parole portanti e ingombrantemente attorcigliate. Se la letteratura è una «superstizione elementare», un esorcismo per nominare le ombre, l’arte intrattiene un rapporto più ambiguo con il lato «dinamico» e pragmatico dell’esistenza.
Nel dare una forma più duratura del bronzo alle visioni, in un certo senso l’arte crea la (propria) realtà, rendendo i quadri dei cocci reali di esistenze fantasmatiche. Questo status contraddittorio ha spesso portato lo scrittore a schivare la materia artistica come se la superficie dell’immagine scottasse. Rispetto, ad esempio, allo straripante protagonismo della musica, Manganelli rende la pittura un contenuto amorevolmente barrato, evocato e subito diluito con il solvente delle acrobazie linguistiche o del panopticon disciplinare.
Per evitare di cadere nella trappola (molto manganelliana) della dispersione, dividerò la riflessione sulle arti in tre punti:
1) Il critico d’arte come mentitore: i Salons. Al lettore sospettoso, che diffidi dell’esistenza di un temperamento figurativo del Manga, bisogna mostrare ostentatamente la copertina dei Salons. Si tratta di un genere narrativo, ben codificato da Filostrato a Diderot, che prevede lunghe passeggiate a spasso per le pinacoteche (reali e immaginarie, private e museali). L’occasione, per Manganelli, coincide con una committenza editoriale: nel 1986, infatti, Franco Maria Ricci aveva affidato allo scrittore l’incarico di ‘reporter visivo’ per la rivista «FMR». Il risultato di questa cronaca museale consisterà in trentacinque prose brevi, raccolte organicamente l’anno successivo.
In questo curioso volumetto illustrato, ogni articolo è impreziosito da una tavola a colori, come una piccola guida turistica che mescola, in un eclettismo soffusamente postmoderno, la descrizione della Ballerina di Edgar Degas a quella di un’anonima tabacchiera d’oro. Manganelli non fa soltanto cozzare i capolavori dei maestri con le anonime suppellettili dei palazzi nobiliari, ma conduce il lettore in un continuo jet lag tra le stesse classificazioni entro cui è abituato a schedare gli ‘oggetti d’arte’.
Sfogliando le pagine dei Salons, troviamo la Madonna cinquecentesca di Andrea Sabatini intenta a spettegolare con la Testa di Bodhisattva della dinastia Song, mentre un inquietante Ex voto raffigurante una mano sinistra di fine Ottocento conta quante Didramme greche ha trovato in un portafoglio smarrito a Napoli nel 395 a. C. Museo e Wunderkammer hanno firmato un patto segreto per scambiarsi i pezzi migliori delle rispettive sale, mentre lo scrittore amministra l’inventario dei beni mescolando le competenze di una guida museale all’entusiasmo miracolistico di un rigattiere.
Nel campo internazionale dei Visual Studies, le scritture ecfrastiche vengono ormai ripartite in due tipologie formalizzate dal critico statunitense John Hollander nel 1995: la categoria classica di «notional ékphrasis», impiegata per descrivere referenti immaginari (quadri, sculture o semplici oggetti d’uso inventati dalla fantasia dell’artefice) e la categoria moderna di «actual ékphrasis», che si concentra su opere esistenti, rintracciabili e documentabili. Nei Salons di Manganelli assistiamo a una curiosa fusione tra le due varietà: lo scrittore non inventa propriamente i manufatti a cui si ispira, ma li inserisce in una cornice d’invenzione così maliosa e artificiale da reinventarne, di fatto, contorni, finalità e contenuti.
Come nell’ecfrasi omerica, nelle pagine manganelliane conta di più il tema mitologico o allegorico imprigionato nell’opera piuttosto che l’immagine in sé, che diventa il pretesto per un eterno differimento dei significati. Del resto, dalla prospettiva di Manganelli i pittori non ritraggono il reale costringendolo all’immobilità in un teatro di posa, ma fabbricano attivamente nuovi spazi d’esistenza. Ad esempio, Édouard Benedictus «non lavora su immagini che appartengono al mondo, ma è un progettatore di pelami, di ali, di petali da applicare al mondo». Rispetto alla presenza empirica, «ogni immagine è cicatrice e amuleto», ferita e scongiuro iconografico per addomesticare un mondo che continua vividamente a non esistere.
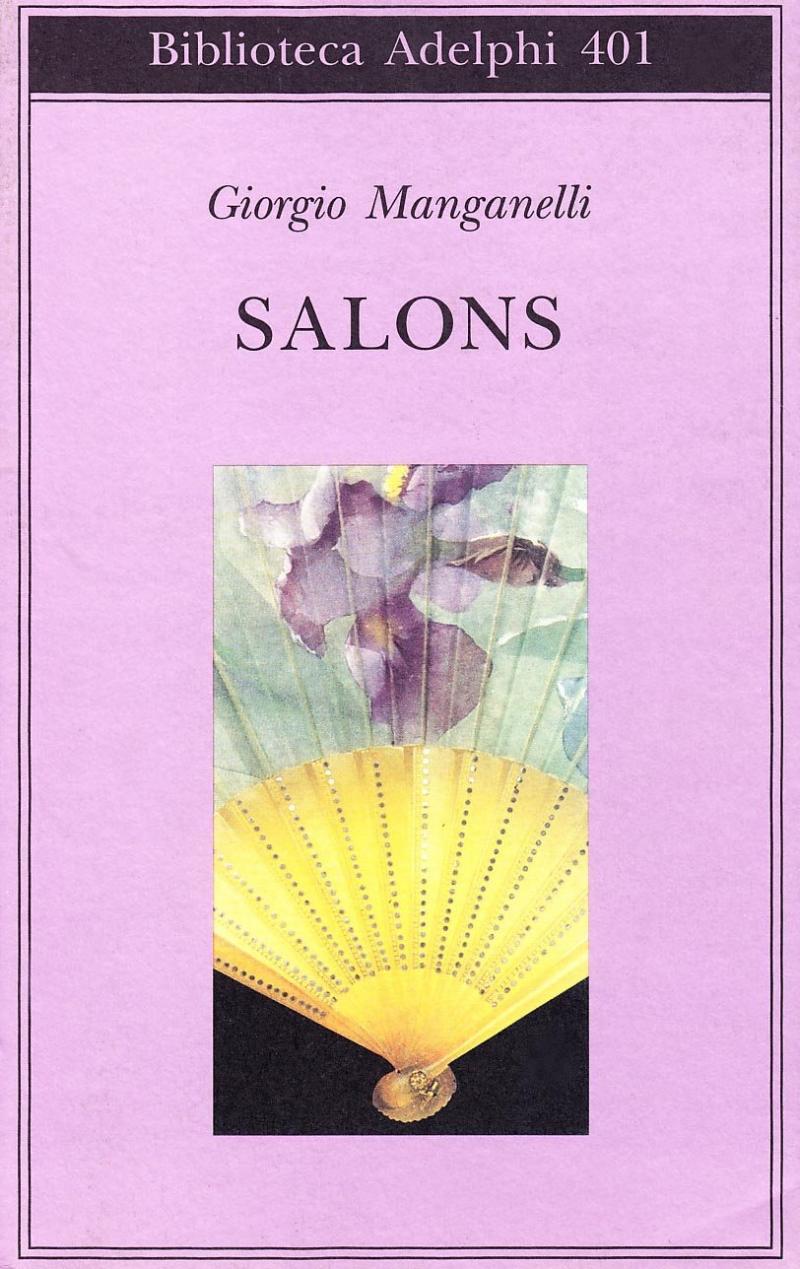
Lo sguardo indiretto sulle opere d’arte viene compensato da un interesse maniacale (e direttissimo) per tutto quello che contorna il quadro, dal cognome del pittore (che spesso viene interrogato etimologicamente creando un’anticamera ‘aperitiva’ alla descrizione) ai dettagli collaterali del contesto socio-economico di partenza. Il lettore dei Salons avrà la percezione, una volta chiuso il libro, di essere il proverbiale stolto che, quando il saggio indica il cielo-quadro, si trova a contemplare il dito, ossia, fuor di metafora, la stanza in cui il quadro è stato appeso, il bookshop all’ingresso del Museo, la cartolina sconcia distribuita ai turisti dopo l’escursione a Pompei.
Grazie a una recente edizione francese (La mort comme lumière. Écrits sur les arts du visible), radunata e commentata da Andrea Cortellessa, il lettore degli anni Zero ha finalmente a disposizione un generoso campionario di scritti d’arte che potrà essere utilizzato, avverte il curatore, come vademecum comparativo per i romanzi e le prose di Manganelli. Dalla «letteratura come menzogna» alla «pittura come menzogna», ogni figurazione viene fagocitata dalla bulimia linguistica di Manganelli e cucinata con il consueto corredo di tic, ripetizioni e ossessioni semantiche.
Se l’arte aveva rappresentato inizialmente un argine dissuasivo, agendo come lo scomodo segnaposto di un reale mancante, nel congedare questo pacchetto di elzeviri torna ad affacciarsi il sospetto che l’unicum «lessicoesistenziale» della Sconclusione (1976) divori qualsiasi resistenza empirica, risputando anche gli oggetti d’arte in forma di bolo linguistico e alfabetizzato. Anche il museo, insomma, si converte in dizionario, in una riqualificazione edilizia che confonde mattoni, spettri, allucinazioni e puri nomi.
2) L’arte nei romanzi e nei saggi: ecfrasi di fantasmi. Dall’autore enciclopedico e formalista par excellence saremmo portati ad aspettarci un abuso di divagazioni ecfrastiche: quadri, poster, immagini votive da appiccicare sulle pareti della pagina per riempire tutti i potenziali vuoti narrativi – come avviene, per certi versi, nella prosa di Alberto Arbasino, spesso evocato sbrigativamente come suo fratellastro di manierismi. Eppure, l’«ammaliziata sintassi» di Manganelli funziona di rado come tappabuchi del Nulla, intrattenendo un rapporto piuttosto civile con il Niente e con il bianco-blank su cui poggiano, per statuto, le parole di ogni libro.
La penuria di quadri, tuttavia, non deve essere liquidata come un’innocente svista o trasandatezza categoriale: il batterio del figurativo agisce in profondità, disertando i pori e la pelle del testo per avviticchiarsi ai suoi organi interni. Se manca dai luoghi in cui dovrebbe manifestarsi (le descrizioni, le digressioni, le similitudini, le metafore), dove si nasconderà l’infezione dell’arte? In primo luogo, nei procedimenti stessi che informano la catena genetica del testo. Come ha notato Cortellessa, Manganelli si serve a più riprese di similitudini ottiche o di tecniche (come l’anamorfosi) prese a prestito dal guardaroba iconografico. L’arte agisce, dunque, come un erogatore di nuove figure retoriche da aggiungere a quelle convenzionalmente letterarie, rendendo la prosa di Manganelli una scrittura testualmente visiva.
Se nei saggi di letteratura o di cultura generale i nomi dei pittori vengono elencati come paragoni tutto sommato accessori e amplificativi, a livello ipotestuale il lessico della pittura fornirà allo scrittore alcuni strumenti narrativi alternativi a quelli abusati del ‘letterariese’. Piuttosto che un secondo mestiere o un doppio talento, l’arte assomiglia, per Manganelli, a un centro di fisioterapia in cui recuperare un corpo testuale slogato dagli agonismi del linguaggio.
Nondimeno, meritano di essere citati anche quei luoghi romanzeschi che ospitano, a tutti gli effetti, un quadro o, meglio, la sua simulazione. Farò un unico esempio tratto, appunto, da Simulazione, uno dei cinque testi narrativi che formano Agli dèi ulteriori (1976). Leggiamo l’incipit:
Abito una allucinazione elaboratamente arredata. [...] Sto seduto nel centro della stanza, e tra me e il muro ho collocato una elaborata finzione culturale: un dipinto. Lo ammiro, sebbene mi sia impossibile intendere che mai esso raffiguri. La sua simulazione è disponibile: i colori imitano animali, una scena d’amore, un trionfo egizio. Ascolto trombe di rame, forse dalla strada, forse dalle viscere di quell’immagine [...]. Certamente il quadro mi osserva. Io debbo supporre di far parte di una macchinazione invisibile; mi interrogo, se non si esiga da me una collaborazione radicale alla invenzione del mondo.
Appendendo un quadro in questa abitazione visionaria, Manganelli canalizza la trama verso un’ulteriore mise en abîme depistante: il quadro, che dovrebbe rappresentare qualcosa, si rivela un geroglifico indecifrabile, un oracolo da parete erogato chissà quando e in quale lingua da una Sfinge-artista senza nome. L’ecfrasi viene subito destituita (non è assolutamente possibile «intendere che mai esso raffiguri») e, al contempo, dilatata fino a incorporare tutte le sensazioni e gli enti limitrofi. L’immagine, oscurata dal punto di vista dei contenuti, diventa un tutto sinestetico: è un corpo-icona che emette dalle proprie «viscere» un suono. Da oggetto d’osservazione la tela si trasforma in soggetto di visione («il quadro mi osserva») che pretende dal narratore una «collaborazione radicale alla invenzione del mondo». I ruoli diegetici si capovolgono: nel prosieguo lo scrittore diventerà addirittura l’unico «capolavoro tra tutte le simulazioni», in un’inversione delle parti in cui manufatto e individuo, finzione e autenticità si scambiano pendolarmente i ruoli.
3) Lo sguardo degli artisti su Manganelli: illustrazioni e citazioni. Per concludere con un paradosso e con un rovesciamento della visuale argomentativa, Manganelli vive l’ossimoro di essere uno degli autori meno illustrabili e più illustrati (almeno in alcune cerchie di pittori) del secondo Novecento. Come se gli artisti si incaponissero nel provare a completare i suoi universi linguistici, i suoi paesaggi alfabetici abitati da favolosi pronomi, dove alle figurazioni del Mito si sostituiscono le figure retoriche del Linguaggio, alla sensualità delle ninfe la lascivia di una sintassi più maliziosa e ammiccante delle gambe accavallate da Sharon Stone in Basic Instinct.
I libri di Manganelli sono inillustrabili soprattutto perché sembrano bastare a se stessi: il lettore li guarda ammirato chiedendosi quale sia l’equilibrio che consente a ogni affollatissima pagina di non cadere nella botola spalancata dell’eccesso, in un’addizione impazzita di significati così numerosi da annerire tutto il foglio. Un illustratore, per quanto abile, riuscirà a isolare soltanto alcune delle figurazioni verbali di Manganelli? Come farà materialmente a scegliere, a separare, a non lasciarsi adescare dalle Sirene di un testo in cui ogni frase è, letteralmente, un’immagine (e, per giunta, un’immagine che crea la successiva nonché l’intera sequenza narrativa entro cui è inserita)?
Paradosso dei paradossi, il libro che ha ricevuto maggiore attenzione illustrativa è stato l’Hilarotragoedia, quasi duecento pagine di ipotesi, chiose e postille a un discorso sulla «natura discenditiva» dell’essere umano, costitutivamente predisposto alla caduta e al precipizio finale-iniziale della morte. Eppure, questo strano e bisbetico manuale dell’oltretomba ispirerà ben ventitré disegni del pittore romano Gastone Novelli, che, nel 1964, si concentrerà soprattutto sugli aspetti «fatalmente orrorosi» della trama, dalla teratologia ai paesaggi infernali, come ha notato lo stesso Manganelli nel catalogo di una mostra allestita vent’anni dopo alla Galleria Il Segno di Roma, nel gennaio-marzo del 1985.
Non soltanto Novelli ma anche Franco Nonnis, scenografo e pittore attivo nell'ecosistema interdisciplinare di «Nuova Consonanza» (in cui gravitava, peraltro, lo stesso Manganelli), si misurerà con l’Hilarotragoedia, realizzando, tra il 1964 e il 1965, due collage che assemblano e traducono in immagini la Postilla sul cervo suicida e altri passaggi del «libercolo tanatocentrico». Persino un artista astratto come Achille Perilli sceglierà di comporre le titolature dei propri quadri sforbiciando alcune frasi dai romanzi manganelliani. Titoli come Allucinazione retorica, La civetteria dell’astrazione, La carnale albedo e Il calamaio della notte, ad esempio, sono stati ritagliati da Nuovo commento e Agli dèi ulteriori per presentare al pubblico alcune delle coloratissime geometrie dipinte da Perilli, in un avvicinamento alla prosa di Manganelli che non avviene nello spazio convenzionale dell’illustrazione ma in quello, più defilato ma parlantissimo, della soglia paratestuale.
Le riscritture figurative degli artisti, mesmerizzati dal magnetismo ipnotico della sua prosa, ci ricordano che la scrittura di Manganelli è interminabile, nel senso che richiede di essere perennemente completata da un lettore-complice in un «gioco» che, come scrive lo stesso Manganelli a proposito dell’Hilarotragoedia illustrata da Novelli, rivendica tanto «il suo rigore» quanto «la sua avventurosa libertà».
Quest’ultimo spostamento dei riflettori dal Manganelli sugli artisti al Manganelli degli artisti ci consente di avanzare una timida ipotesi finale: che l’imbarazzo iniziale nel parlare di arte risponda al paradosso speculare di un doppio eccesso, di vuoto e di pieno. In Manganelli si fa fatica a vedere l’arte perché si trova, letteralmente, dappertutto. Per recuperare i Salons, il ritratto che Manganelli tratteggia di Paul Delvaux potrebbe essere trasferito linearmente sulla carta d’identità dello stesso scrittore-salonnier.
Ai segni particolari accertabili dall’anagrafe si sostituiscono gli interrogativi e le domande spalancate sul significato stesso del mestiere di questo acchiappafantasmi (e acchiappaimmagini) professionista: invertendo arte e letteratura, dunque, Manganelli è «uno scrittore, o il suo scrivere è un genere artistico periferico, straniato, impervio e insieme astuto? È, forse, costui un illustratore, un catalogatore di immagini che si riferiscono a un testo possibile, un libro eventuale, o forse un racconto orale narrato da bocche già taciute, o una filastrocca, un nonsense elaborato, metafisico, astratto?». Peccato che il «testo possibile», e le sue impossibili illustrazioni, sia qualcosa che il reale «ha secreto, forse il suo sudore, la saliva, il fastoso escremento»: il mondo come volontà e deiezione, insomma.
Leggi anche:









