Il saggio come specchio di sé stessi / Jonathan Franzen e Martin Amis
Per un narratore, diversamente che per un critico, scrivere un saggio vuol dire esporsi direttamente, senza i filtri che la scrittura di un romanzo impone. Tutto, in un saggio, può essere rilevante, tutto può interessare l’io, che una volta tanto non deve preoccuparsi troppo di dare senso e coerenza alla vita di un personaggio immaginario. Ciò vale soprattutto per gli scrittori capaci di rappresentare caratteri diversi e ulteriori rispetto alla proiezione del sé, dominante e a volta ingombrante nella letteratura contemporanea.
Naturalmente, bisogna intendersi sul significato da dare alla parola ‘saggio’ o essay: è un genere che non corrisponde a un’interpretazione critica oggettivamente documentata (ci sono scrittori e poeti che sono anche ottimi critici in questo senso per così dire tecnico, ma è un’altra cosa). Il saggio è una forma di espressione libera, senza rigidi vincoli tematici o codici stilistici. Esempi efficaci di questo tipo di scrittura sono offerti dai due volumi recenti di Jonathan Franzen, La fine della fine della terra (‘The End of the End of the Earth’, 2018) e di Martin Amis, L’attrito del tempo. Bellow, Nabokov, Hitchens, Travolta, Trump. Saggi e reportage, 1986-2016 (‘The Rub of Time. Bellow, Nabokov, Hitchens, Travolta, Trump. Essays and Reportage, 1986-2016’, 2017), usciti entrambi da Einaudi nei primi mesi di quest’anno nelle traduzioni rispettivamente di Silvia Pareschi e di Federica Aceto.

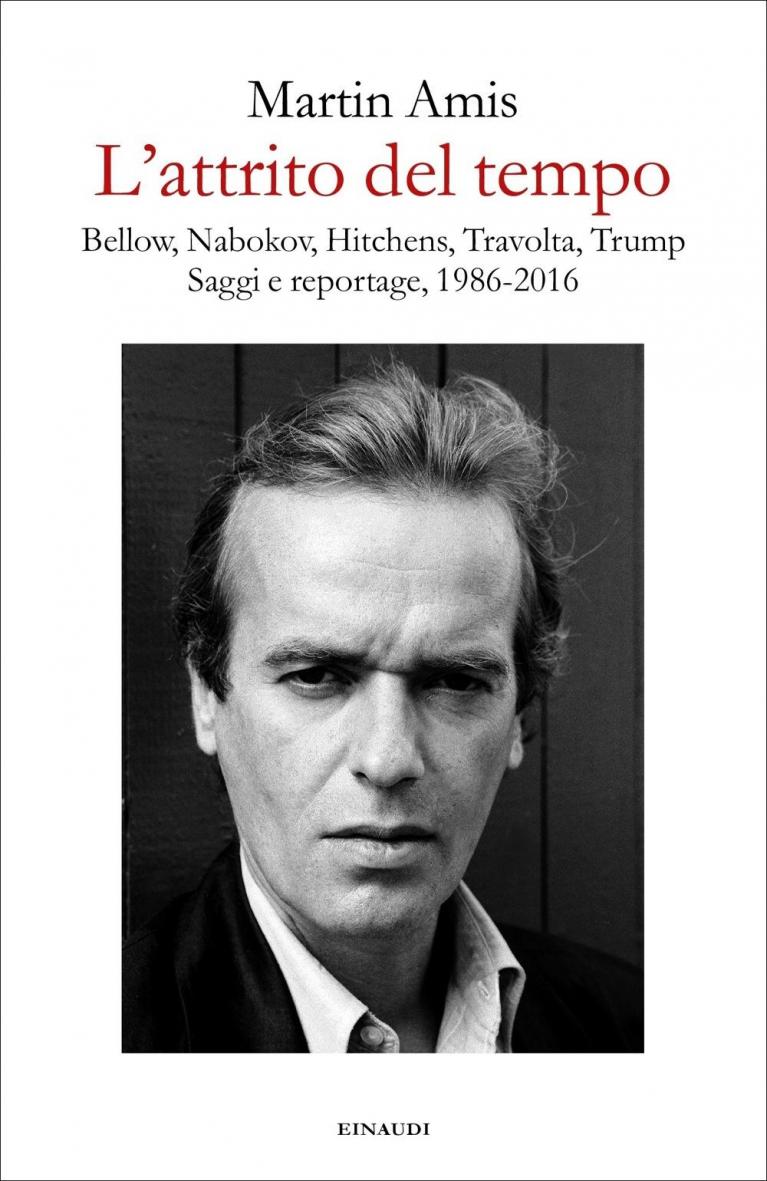
Sono due opere molto diverse: tematicamente più coesa quella di Franzen, che è un libro nel senso pieno del termine; più composita quella di Amis, che ha piuttosto la forma di una raccolta di pezzi scritti lungo un arco di tempo molto esteso (trent’anni), anche se attraversati da temi e figure ricorrenti. In entrambi i casi però, com’è richiesto dal genere, l’io – o diciamo pure l’autore – si porta anche fisicamente nel cuore delle situazioni e delle idee di cui discute, assume biograficamente l’impegno di confrontarsi con la porzione di realtà di cui vuole dar conto. La prospettiva perciò non è quella del critico né del cronista, ma di un soggetto che saggia innanzitutto sé stesso, le proprie esperienze e convinzioni, attraverso l’incontro e l’attrito con il mondo esterno. L’essay è un impegno che gli scrittori contraggono verso loro stessi e che è rivolto tanto verso il self quanto verso il mondo degli altri con cui si entra in relazione. È emblematico, in questo senso, il titolo di un’altra raccolta recente di saggi d’autore: The Source of Self-Regard (‘La fonte dell’autostima’, 2019) di Toni Morrison.
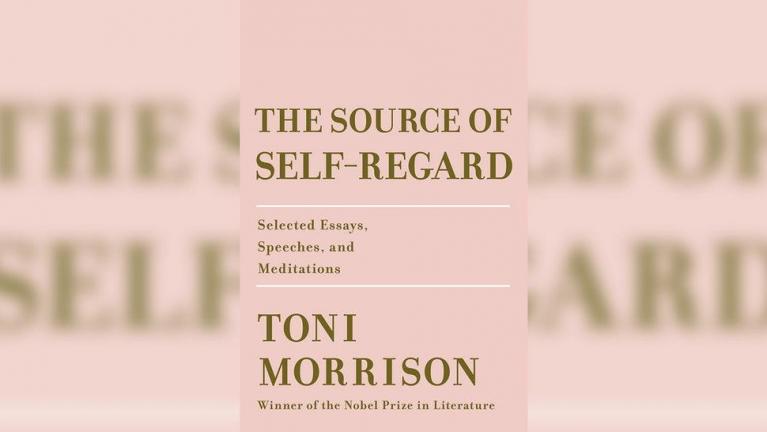
A prima vista, La fine della fine della terra è un libro sull’ecologia: già il titolo porta su questa strada, anche se il doppio genitivo lascia subito sospettare che qualcosa non andrà come ci aspetteremmo. Non si parla infatti di ‘fine della terra’, cioè di quell’apocalisse che occupa oggi molta parte del nostro immaginario, ma di ‘fine della fine’. Cosa vuol dire quel titolo? Che non dobbiamo temere nulla, che l’emergenza climatica è finita o promette di farlo grazie a illuminati provvedimenti adottabili nel prossimo futuro, come prevede lo studioso indiano Prem Shankar Jha nel suo libro L’alba dell’era solare. La fine del riscaldamento globale e della paura (appena uscito in Italia per Neri Pozza)? Oppure dobbiamo pensare che Franzen è diventato ecoscettico, forse addirittura econegazionista? Non è così ovviamente: il libro prende il titolo dal saggio conclusivo, in cui lo scrittore racconta di un viaggio in Antartide (la fine del mondo in senso geografico) e degli effetti del riscaldamento globale sui ghiacci e gli ecosistemi di quel continente. Ma la formula ‘fine della fine’, promossa a insegna dell’intero volume, esibisce un connotato straniante, da cui occorre partire per comprendere la vocazione di questi scritti; l’ambiguità del titolo, infatti, corrisponde all’atteggiamento dello stesso narratore, che adotta la forma-saggio per dare voce a idiosincrasie, conflitti (anche con sé stesso), ripensamenti, denunce dei propri errori e ammissioni dei propri limiti.
Il rapporto di Franzen con l’ecologia, del resto, non è mai stato irenico. Nei suoi romanzi (come Libertà e Purity) e nei suoi libri non-fiction (Più lontano ancora), il tema della natura è presente non solo come valore ma soprattutto come tensione. Franzen è un osservatore e un narratore dell’Umwelt, umana e animale, che rappresenta come scenario di crisi e contrasti; ma il suo sguardo non è solo quello dell’ecologista allarmato: nelle sue opere emerge anche il senso del collasso inevitabile, vissuto in prima persona e non solo deprecato dalla posizione di spettatore esterno. Anche l’influenza di Thoreau, evidente soprattutto in Libertà, non viene passivamente recepita, ma inserita in una dialettica che ne contempla lo scacco e il travisamento. Libertà è un romanzo ecologico, infatti, non solo e non tanto perché parla di natura, ma soprattutto perché mette in scena la difficoltà di far interagire ecosistemi sociali diversi e lo sforzo di sopravvivere evolvendosi all’interno di un’Umwelt più ideale che vitale, tanto più artefatta quanto più aspira alla purezza originaria.

Nei saggi di La fine della fine del mondo, quella difficoltà e quella tensione sono incarnate dallo stesso narratore, che mette in scena il conflitto innanzitutto facendo reagire e cozzare tra loro due scritti inclusi nel libro, l’uno palinodia dell’altro. Il primo (ma quarto nell’indice del volume) s’intitola Salva quello che ami e si basa su questo ragionamento: visto che non possiamo fare nulla contro il riscaldamento globale, tanto vale concentrare gli sforzi sul salvataggio di ecosistemi e specie animali, come le numerose varietà di uccelli minacciati dai felini, dalle auto, o dalla caccia indiscriminata molto più che dal cambiamento climatico:
se da un lato autorevoli ricerche scientifiche stimano che ogni anno, solo negli Stati Uniti, le collisioni e i gatti uccidono più di tre miliardi di uccelli, dall’altro nessuna singola morte di uccello può venire attribuita con certezza ai cambiamenti climatici.
Il problema, insiste Franzen, è che «per il clima non fa alcuna differenza se un individuo, me compreso, va al lavoro in macchina o in bicicletta». Ora, contro questo genere di argomenti, peraltro diffusi anche in certi ambiti del pensiero ecologico, possono essere mosse varie obiezioni. La prima, direi, è questa: se anche i comportamenti dei singoli fossero irrilevanti, le loro scelte non lo sono; per esempio, il voto a favore dei candidati politici più attenti all’ambiente può incidere, eccome, a livello globale. Il punto è che Franzen sa che il punto di vista che ha espresso nel suo saggio è parziale ed elitario, oltre che condizionato dalla sua ben nota passione per il bird watching. Così, nello scritto di apertura (Scrivere saggi in tempi bui) replica a sé stesso: «Per lo scrittore, un saggio è uno specchio, e ciò che vedevo riflesso in quello specchio non mi piaceva. Perché me la prendevo con i progressisti come me, quando i negazionisti erano peggiori?». «Il saggio che venne pubblicato allora» conclude Franzen
rispecchiava un furibondo disadattato amante degli uccelli che si considerava più furbo degli altri. […] Soprattutto avrei provato a ricordare tutti coloro per i quali avere speranza è più importante di quanto lo sia per un pessimista depresso, tutti coloro per i quali la prospettiva di un futuro torrido e funestato da calamità è intollerabilmente triste e spaventosa, e che possono essere perdonati se preferiscono non pensarci. Avrei continuato a riscrivere il mio saggio.
Proprio queste frasi finali aiutano a capire che, se l’ecologia è l’argomento preminente e unificatore, la sostanza tematica del libro risiede in un concetto non del tutto diverso e autonomo, ma sovraordinato rispetto al motivo ambientale. Questo tema è l’empatia, che ricorre come parola-chiave in diversi saggi. Empatia come difficile relazione con gli abitanti di un ecosistema da intendersi non solo in senso ecologico o biologico, ma anche ideologico, sociale e affettivo. Potremmo parlare anche di una sorta di ecologia esistenziale, che è il vero ponte che collega i saggi ambientali a quelli di contenuto politico, letterario e personale. In Manhattan 1981 (il secondo scritto del libro), ad esempio, l’ecosistema in questione è quello della società urbana newyorkese, in cui il narratore è calato. In The Regulars (sulle fotografie di Sarah Stolfa), l’empatia è quella di scrittori come Čechov, Trevor e Welty, dotati di «curiosità all’altezza dell’infinita specificità della vita delle persone ordinarie». Più avanti, nel finale di Un’amicizia, l’ambiente che Franzen rimpiange, l’eden perduto, non è quello della wilderness ma coincide con le relazioni umane e creative che lo legavano un tempo a due altri grandi scrittori americani della sua generazione, William (Bill) T. Vollmann e David Forster Wallace:
Avrei tanto voluto poter entrare, per qualche giorno, in un universo alternativo nel quale mi accampavo laggiù con i miei due amici di talento, un universo in cui entrambi erano ancora vivi e potevano diventare amici a loro volta, perché ormai, nell’universo in cui sto raccontando questa storia, David era morto e io e Bill ci eravamo persi completamente di vista.

Se per Franzen l’empatia è una condizione elegiaca e fondamentalmente autoriflessiva, per Martin Amis invece è una forma di curiosità più autentica perché più disinteressata. Per questo la sua scrittura è più ‘simpatica’ (sia nel senso etimologico del termine, sia in quello comune) in confronto a quella di Franzen, pur sembrando più snob. Nella nota iniziale del suo volume, anche Amis dà un’interpretazione del genere-saggio come ‘specchio’, cioè come espressione dell’io e dei suoi dubbi, come forma ideale della dialettica interiore che movimenta e sovverte le idee del soggetto: «la prosa discorsiva (lo stesso genere dei saggi e dei reportage presenti in questo volume) non può essere affrancata dall’ego, ed è illimitatamente perfettibile».
Rispetto al libro di Franzen, L’attrito del tempo ha un’architettura più elaborata e una maggiore varietà tematica; il volume è infatti scandito in sezioni dai titoli spesso paralleli, che si succedono sulla base di una serie di motivi o ambiti ricorrenti, ma inframmezzati da sezioni più libere o stravaganti: Twin Peaks – 1, Politica – 1, Letteratura – 1, La casa reale di Windsor – 1, Più personale – 1, Twin Peaks – 2, Americana (andando verso ovest), Letteratura – 2, Sport, Più personale – 2, Politica – 2, Letteratura – 3, Più personale – 3, Twin Peaks – 3. In realtà, a ben guardare, gli ‘ambienti’ principali in cui si situa la gran parte delle osservazioni di Amis (la politica, la letteratura, le esperienze personali e tra queste il dialogo privilegiato con altri scrittori amici, come Christopher Hitchens) sono più o meno gli stessi in cui si agitano le contraddizioni di Franzen. Manca solo l’ecologia in senso proprio, cioè ambientale (Amis vi fa solo qualche accenno, secondario ma originale: «adesso ci viene naturale identificarci con il pianeta, perché il pianeta sembra invecchiare di pari passi con noi»). Anche se non è rivolto verso la natura, lo sguardo è però costantemente puntato verso gli esemplari più curiosi di altre specie umane e sociali: tra gli articoli memorabili del libro ci sono ad esempio un’intervista a John Travolta (il cui nome, non a caso, figura nel sottotitolo del libro accanto a quello di Hitchens) e un reportage sul mondo dell’industria pornografica, che Amis riesce a scrivere con partecipazione priva sia di moralismo sia di adesione.

Il tono di questi saggi è sempre brillante, spesso ironico e, se non fosse uno stereotipo, sarebbe appropriato evocare il famoso sense of humour britannico, che lo scrittore mette alla prova con particolare acume nei confronti della politica americana («Mitt [Romney] è un mormone, ma non ne parla volentieri. E nemmeno io se fossi un mormone ne parlerei volentieri»). È vagamente umoristica anche la scelta di intitolare Twin Peaks, come la celeberrima serie di David Lynch, le sezioni in cui Amis interpreta e mette a confronto (molto seriamente) due vette della letteratura in lingua inglese: Vladimir Nabokov e Saul Bellow, autori-faro che dominano un canone personale di cui fanno parte anche DeLillo, Updike, Ballard e i due grandi Philip: Larkin e Roth.
La pratica di modificare il canone per motivi estetici o etici (oggi questi motivi sarebbero politici, e cioè improntati all’egalitarismo) è stata magistralmente ridicolizzata da Northrop Frye nel suo Anatomia della critica (1957). […] Propongo comunque di fare delle previsioni a ragion veduta sul futuro della letteratura: personalmente sono convinto che la figura di Bellow emergerà come quella del romanziere americano per eccellenza.


Il brano è tratto da uno scritto del 2003: Saul Bellow vs Henry James. Se per Amis le «voci della narrativa e della saggistica di Bellow si intrecciano e si fecondano a vicenda» (Le belle lettere di Bellow) si capisce perché l’autore delle Avventure di Augie March occupi nel pantheon letterario un posto centrale, contesogli solo da Nabokov. I due maestri sono i protagonisti di una sorta di libro nel libro, ricostruibile mettendo in fila i brani dei molti saggi in cui Amis parla dell’uno, dell’altro o di entrambi. Il tema di questo libro ideale è la parabola del Grande Scrittore, dal massimo grado della sua forza espressiva fino alla decadenza, che nel caso di Nabokov (e di Joyce, a cui Amis lo accosta) consiste in un «deciso disamoramento nei confronti del lettore», nella «perdita di ogni riguardo e cortesia» nei suoi confronti (Twin Peaks - 1). Se è vero che il genere-saggio dà a uno scrittore l’occasione di vedersi attraverso le immagini che i libri, i fatti, le persone gli rimandano, possiamo pensare che per Amis il ritratto dell’artista da vecchio assomigli sempre più a un autoritratto.
È anche questo a rendere decisivo e toccante il dialogo in assenza con Christopher Hitchens (1949-2011), che non ha fatto in tempo ad assumere i tratti dello ‘scrittore da vecchio’. Il saggio su Hitchens, pubblicato l’anno precedente alla sua morte, è il terzo e ultimo della serie Più personale. Amis vi rievoca un periodo preciso, l’estate del 1986 durante la quale stava «leggendo e rileggendo» uno studio famoso dello storico Robert Jay Lifton, I medici nazisti. In quei mesi, lo scrittore era assalito da un dubbio profondo: avrebbe avuto il coraggio di scrivere un libro sull’Olocausto?
Christopher lo sapeva ed era a conoscenza dei miei scrupoli. […] “In fondo ci restano così poche aree di trascendenza. Lo sport. Il sesso. L’arte…” “E non dimentichiamo le sofferenze altrui”, disse Christopher. “Non dimentichiamo la languida contemplazione delle sofferenze altrui”. Alla fine scrissi quel romanzo.
E «quel romanzo» si sarebbe intitolato, in omaggio a Primo Levi, La freccia del tempo: o La natura dell’offesa (‘Time’s Arrow: or The Nature of the Offence’, 1991). “The Hitch” è stato anche questo per Amis: un reagente più che un interlocutore. Potremmo quasi dire: un ‘saggio’ incarnato, uno specchio che restituisce l’immagine di un altro sé stesso. Per questo, essere in disaccordo con Hitchens vuol dire per Amis fare i conti con le proprie idiosincrasie, per arrivare a cogliere, se non una verità, almeno una forma di adempimento, e di gratitudine:
Negli ultimi dieci anni Christopher ha scritto tre recensioni aspramente ostili: una su Ravelstein (2000) di Saul Bellow, una su Terrorista (2006) di John Updike e una su Il fantasma esce di scena (2007) di Philip Roth. […] Se sei uno scrittore, tutti gli scrittori che sono stati per te fonte di gioia […] sono come dei parenti onorari; e gli attacchi di Christopher erano freddamente privi di spirito filiale. Qui la mancanza di rispetto diventa il vizio che tanto assillava Shakespeare, quello dell’ingratitudine. E come Re Lear (che pensava alle sue figlie), ogni scrittore sa che un lettore ingrato causa un dolore più acuto di un morso di serpente.









