Nuovi volumi sullo scrittore torinese / Il sorriso di Primo Levi
1. Tre giovani su una panchina sorridono all’obiettivo in una foto in bianco e nero. A sinistra, c’è una ragazza mora seduta accanto a un uomo in maniche corte, che tiene il mento sollevato, la testa inclinata e le spalle un po’ curve. In primo piano, a destra, le gambe accavallate di un’altra ragazza, abito leggero e capelli raccolti in un’acconciatura d’epoca. L’uomo al centro è Primo Levi, la figura sulla destra è la sorella Anna Maria, quella a sinistra è la futura moglie Lucia Morpurgo.

La fotografia ci guarda da una delle prime pagine dell’Album Primo Levi, da poco uscito per Einaudi, a cura di Roberta Mori e Domenico Scarpa. Pubblicato nella collana dei «Saggi», la stessa in cui nel ’58 fu accolto Se questo è un uomo, il volume ha però il formato di un atlante, e non a caso: oltre a raccogliere le immagini, il libro disegna infatti anche una mappa, una topografia di Levi e dei suoi mondi concreti e immaginari. Proprio «I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza» è il titolo della mostra dedicata allo scrittore, allestita al Palazzo Madama di Torino dal gennaio all’aprile del 2015 e in seguito portata in luoghi emblematici (come il campo di concentramento di Fossoli, da cui Levi e molti ebrei italiani furono deportati ad Auschwitz) e altre città italiane ed europee. I titoli e i contenuti dei capitoli nell’Album (Cucire molecole, Andare in montagna, Auschwitz, «Carbonio», Cucire parole, Pensare con le mani) coincidono in parte con le sezioni della mostra; il volume è completato da due appendici (I luoghi e La vita, vero e proprio ‘atlante storico’ leviano). Le immagini, molte delle quali inedite o rare, sono legate da un racconto critico che tiene in equilibrio la presentazione del percorso biografico-letterario da un lato, l’interpretazione dall’altro. Inframmezzati al testo si trovano brani dell’autore e le tavole ispirate al racconto Carbonio, disegnate da Yosuke Taki, artista e saggista giapponese che ha tradotto nella sua lingua le Conversazioni e interviste di Levi.

Tavole di Yosuke Taki nell’Album Primo Levi.
Che cosa impariamo da quest’Album? Molto, sia direttamente sul piano fattuale (dati, nomi, circostanze), sia indirettamente, cioè per via di quella comprensione empatica di contesti, animi e situazioni che spesso le immagini ispirano. È proprio la struttura visuale che distingue l’Album da una biografia, anche se corredata da immagini, come quella di Ian Thomson (Primo Levi. Una vita), uscita in Gran Bretagna nel 2002 e finalmente tradotta, da Eleonora Gallitelli, per l’editore Utet. Il lettore italiano ha così ora a disposizione una biografia su Levi documentatissima, sia per quanto riguarda la dimensione privata, sia in relazione alla storia culturale, sociale e politica del Novecento (nonostante qualche concessione allo sguardo ‘orientalista’ del britannico sull’Italia e qualche curiosa semplificazione: Gramsci è considerato un «agitatore comunista»; Croce è definito «prominente ideologo del regime»). La biografia di Thomson è da affiancare a quelle di Myriam Anissimov (Primo Levi o la tragedia di un ottimista, 1996, trad. ital. Baldini&Castoldi, 1999) e di Carole Angier (Il doppio legame. Vita di Primo Levi, 2002, trad. it. Mondadori, 2004), oltre che al volume di Philippe Mesnard, Primo Levi. Una vita per immagini (a cura di Frediano Sessi, Marsilio, 2008).
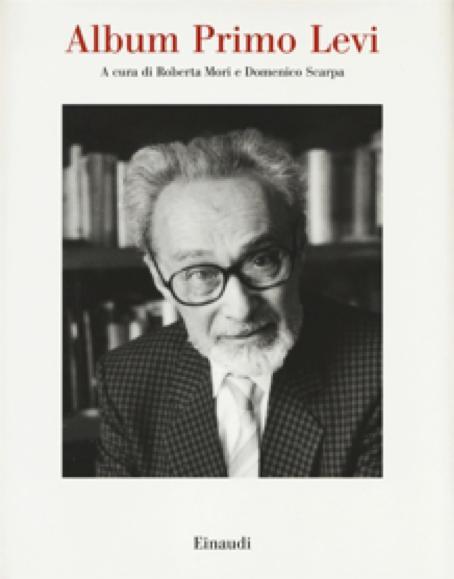

Anche se tra loro diversi, il volume curato da Mori e Scarpa e il libro di Thomson si corrispondono, o almeno questa è l’impressione che suscita la loro quasi contemporanea uscita. Letti e guardati insieme, producono un effetto straniante nei confronti dell’autore implicito, cioè dell’idea di Levi che ogni lettore tende a farsi, in particolar modo attraverso le narrazioni testimoniali e i saggi dei Sommersi e i salvati. Già i racconti, spesso d’ispirazione fantascientifica o ‘fantabiologica’ (per usare l’aggettivo con cui li definì Calvino), possono apparire e in effetti apparvero disorientanti per un pubblico assuefatto all’immagine di Levi come scrittore ‘a una dimensione’. Non a caso, è su quella produzione a lungo considerata minore che hanno di recente riportato l’attenzione il libro di Francesco Cassata (Fantascienza?/Science fiction?, Einaudi, 2016) e, da una diversa prospettiva, quello di Federico Pianzola (Le «trappole morali» di Primo Levi. Miti e fiction, Ledizioni, 2017).
Ma se gli studi recenti contribuiscono a rinnovare la percezione di Levi come narratore, l’Album e la biografia di Thomson restituiscono un profilo complesso sia di Levi come individuo, sia della sua esperienza esistenziale, dentro e soprattutto fuori dal Lager. Di quell’esperienza i due volumi colgono però sfumature diverse (e anche per questo è bene leggerli insieme): più ottimistico (di un ottimismo della volontà) è il ritratto composto nell’Album, dal quale ci viene incontro un Levi non pacificato o conciliato, ma capace, fabbrile; più cupo è quello che ricaviamo dalle pagine di Thomson (che a volte eccede nella ricerca di suggestivi moventi psicologici). Attraverso la biografia e l’Album conosciamo innanzitutto le storie e i volti degli antenati evocati nel Sistema periodico e quelli degli amici della piccola comunità di ebrei torinesi trapiantati a Milano, con cui Levi visse a stretto contatto prima dell’arresto. Uno di questi, Eugenio Gentili Tedeschi, ritrasse in caricatura Primo, sua cugina Ada Della Torre e Vanda Maestro, che sarà poi con Levi prima nel campo di Fossoli e poi nel viaggio fino ad Auschwitz, dove vennero separati. A Birkenau, come si legge nella Tregua, Vanda «era andata in gas, in piena coscienza».
A sollecitare altre domande è proprio l’attrito tra le immagini che precedono Auschwitz e le parole scritte dopo: che cosa restituiscono queste foto ai sommersi? Che cosa, forse, ai salvati? Quali ulteriori immagini, dell’autore e delle figure che abbiamo incontrato nei suoi libri, ne ricaviamo? Per provare a rispondere conviene tornare alla fotografia da cui siamo partiti. Dobbiamo mettere a fuoco, cioè, il sorriso di Levi. Un sorriso che va oltre Auschwitz senza cancellare quell’esperienza maggiore e insuperabile, ma allineandola a una serie di altri eventi e incontri che hanno fatto di Levi quel che effettivamente è stato: un autore complesso, insieme razionale e fantastico. Il sorriso del giovane Levi, diverso da quello accennato nei ritratti maturi e senili, nasce dal desiderio avventuroso di «dragare il ventre del mistero», dalla curiosità dell’adolescente che si appassiona alla chimica e alla sua scientifica ‘magia’; nasce perfino nelle vignette satiriche degli anni di liceo (riprodotte nell’Album), con cui gli studenti del «D’Azeglio» si preparavano a resistere, anche grazie alla beffa, alle deliranti mistificazioni propalate da «La difesa della razza». Non si dovrà esagerare il valore di quelle prime espressioni, ancora adolescenziali e goliardiche; ma non si può nemmeno sottovalutare l’importanza che ha sempre avuto per Levi la dimensione del rovesciamento, della parodia (di «sistema parodico» ha parlato di recente Alberto Cavaglion, in un saggio nel volume su Gli intellettuali/scrittori ebrei e il dovere della testimonianza, a cura di Anna Dolfi, Firenze University Press, 2017; la sezione dedicata a Levi comprende, tra gli altri, uno scritto di Anna Baldini intorno a Levi e la letteratura sul mondo ebreo-orientale, e di Andrea Cortellessa, Primo Levi. Il doppio legame).
Tracce di quel ‘sorriso’ leviano s’intravedono perfino nel Lager, o meglio nel racconto che Levi ne fa; l’ironia amara e allusiva che emerge a tratti in Se questo è un uomo diventa infatti vera comicità in alcuni episodi della Tregua. Ma Levi si dimostra già capace d’ironia in una lettera indirizzata a Bianca Guidetti Serra, la prima – per quel che è noto – spedita in Italia durante il viaggio di ritorno. La si può leggere nell’Album: «ho imparato il tedesco, un po’ di russo e di polacco, e inoltre a cavarmela in molte circostanze, a non perdere il coraggio e a resistere alle sofferenze morali e corporali». Difficile resistere alla tentazione di riconoscere, in questo bilancio, una reminiscenza e forse perfino una volontaria caricatura della morale che Renzo Tramaglino recita davanti a una dubbiosa Lucia, nel finale dei Promessi sposi.
2. Quale contributo porta e come si situa l’Album Primo Levi nel quadro della critica leviana di questi anni? Possiamo dire a grandi linee che dopo la morte dell’autore si sono avvicendate tre fasi critiche, con altrettanti obiettivi in parte sovrapposti. La prima fase ha coinciso con la necessità di mettere in luce le qualità e la posizione di Levi come scrittore, insieme al valore della sua testimonianza. La seconda ha promosso un’immagine più varia dell’opera di Levi, per esempio dando rilievo a temi che attraversano, collegandoli, i libri direttamente ispirati dalla memoria concentrazionaria e gli scritti fino a quel momento meno canonici (i racconti, le poesie, i saggi). La terza fase, quella attuale, ha il compito di mantenere attivo e straniante l’effetto-Levi, reagendo contro gli stereotipi. Stereotipi sull’opera, che la vorrebbero tutta e solo tragica, tutta e solo su Auschwitz; e stereotipi sulla figura e l’esperienza dell’autore, che rischiano di essere relegate «ossequiosamente nel nobile castello della Storia Patria» (così Levi stesso si esprimeva sul pericolo di “imbalsamazione” della Resistenza, in Il tempo delle svastiche, 1960, citato nell’Album). La testimonianza e la scrittura, la memoria e l’invenzione, sono le dimensioni parallele dell’opera leviana che occorre indagare insieme, contemplandole in un’unica prospettiva capace di guardare l’autore «di fronte e di profilo» (secondo la formula che dà il titolo al libro di Marco Belpoliti, Guanda, 2015, guida completa all’«universo-Primo Levi», ai suoi oggetti, immagini, figure).
La scrittura per Levi è stata anche felicità di raccontare, e stabilire rapporti e affetti attraverso il racconto, come è accaduto con Lucia Morpurgo: «ho raccontato le mie cose a lei come le raccontavo a tutti, ma ho trovato una udienza molto più vicina e affettuosa». Il brano si legge in un’intervista inedita registrata da Pier Mario Fasanotti e Massimo Dini nel 1982, pubblicata nell’ultimo numero di «Riga»: Primo Levi, a cura di Mario Barenghi, Marco Belpoliti e Anna Stefi, «Riga 38», Milano, Marcos y Marcos, 2017. Il periodico fondato da Belpoliti con Elio Grazioli aveva già dedicato a Primo Levi il volume n. 13 (1997), che aveva dato un contributo decisivo alla seconda fase degli studi leviani; vi si trovavano, oltre a testi e conversazioni d’autore, un’antologia della critica e ventiquattro voci per un ‘dizionario’ tematico leviano, da Animali a Visitatore. Rispetto a quella versione, il numero 38 è profondamente rinnovato: contiene scritti rari e pronunciamenti d’autore, ulteriori interviste e recensioni, il dizionario con alcune variazioni.
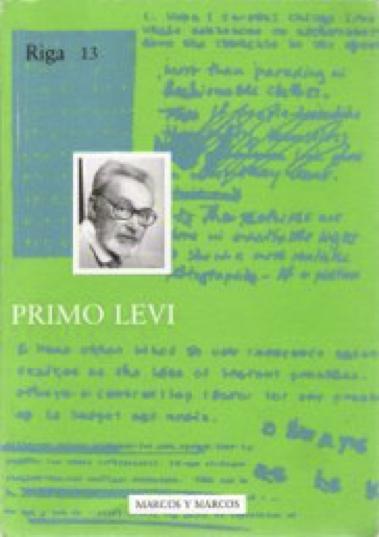

Il tema del racconto, dell’importanza e del piacere di narrare, tornano in più di un’occasione. Per esempio, nell’intervista a Lugi Silori per «L’approdo» (1966) Levi ammette che La tregua, come ripeterà anche in altre sedi, nasceva da quel desiderio o bisogno: «mi piace molto raccontare agli amici e a tutti quelli che mi capitavano a tiro». Più tardi, nel corso dell’intervista a Fasanotti e Dini, Levi dirà: «Diciamo che per due terzi ho scritto per questo mio bisogno, che è proprio di tutti coloro che hanno visto cose, grosse, come per Rigoni Stern credo, perché anche lui è un raccontatore. Come ha fatto Ulisse quando approda all’isola dei Feaci. La prima notte l’ha fatta raccontando; come il Ruzzante; direi che è un tratto tipico quello dei reduci di raccontare». «Questa è l’Odissea moderna»: così lo stesso Rigoni Stern parlerà della Tregua, in un articolo uscito nella «Stampa» del 10 aprile 1988; e proprio di «funzione-Ulisse» (che si affianca, in Levi, alla «funzione-Giobbe») scrive Domenico Scarpa nella voce «Chiaro/oscuro» del dizionario leviano.
3. Del tutto inedita è l’ultima sezione del volume, che accoglie i testi del convegno L’uomo e altri animali. Primo Levi antropologo ed etologo, svoltosi il 3-4 maggio 2016 alle Università di Bergamo e di Milano-Bicocca, a cura di Marco Belpoliti e Mario Barenghi. Gli atti includono scritti dei curatori e di Marco Aime, Daniela Santucci ed Enrico Alleva, Pietro Barbetta, Laura Beani, Damiano Benvegnù, Alessandro Cinquegrani, Ugo Fabietti, Robert S.C. Gordon, Gianfranco Marrone, Martina Mengoni, Federico Pianzola, Mario Porro, Telmo Pievani, Francesco Remotti, Elisabetta Ruffini, Domenico Scarpa.

Da questi contributi, sembra che i presupposti del convegno siano stati due. Il primo è l’interesse non comune di Levi per le due scienze, etologia e antropologia. Per Claude Lévi-Strauss, di cui tradusse in italiano La via delle maschere e Lo sguardo da lontano, l’autore della Chiave a stella sapeva anche osservare e ragionare come «un grand etnographe d’une pratique professionelle». Lo ribadiscono qui Martina Mengoni, che ha studiato la corrispondenza tra lo scrittore e l’antropologo, e Domenico Scarpa, che nota come Levi, da bravo etnografo, non vedesse «l’altro più diverso di quanto è nella realtà», anche quando questo ‘altro’ è un feroce nazista. L’articolo di Laura Beani illustra invece gli interessi dello scrittore per l’etologia e, più precisamente, la sua passione per l’entomologia. Perché a Primo Levi, come ha dichiarato egli stesso in più di una circostanza, interessano gli insetti? Si può rispondere con un’altra domanda, quella che pone qui il saggio di Federico Pianzola: «ciò che riteniamo essere proprio dell’uomo può accomunarci alle altre creature?».
Il secondo presupposto è il confronto tra il Lager (inteso come organizzazione e come principio traumatico) e le forme rituali interpretabili alla luce degli strumenti dell’antropologia e della psicologia: in queste direzioni vanno, per esempio, i contributi di Pietro Barbetta e Francesco Remotti. Del resto, uno sguardo antropologico, che consentisse di passare dallo choc «alla costruzione di un sapere da condividere», era stato necessario, come osserva qui Elisabetta Ruffini, per comprendere e raccontare la dimensione sconosciuta del Lager.
Ma si può considerare Levi un etologo e un antropologo, anche se in senso lato e da dilettante? E se lo è stato, la pratica di tali scienze fu per lui primaria (cioè mossa da un interesse spontaneo) o secondaria (cioè indotta dall’identificazione o riduzione uomo/animale conosciuta e subita ad Auschwitz, come ‘cavia’ di quel «gigantesco esperimento biologico e sociale»)? In altre parole, la sua è un’antropo-etologia appresa nel Lager e ricavata da quello specifico letale sistema? Sono queste alcune delle domande che questi saggi sollecitano e alle quali cercano di dare risposta. Certo, in Levi lo spirito di osservazione e la capacità di analisi sono doti che evidentemente precedono il Lager. Come scrive qui Belpoliti, «avere naso ha contato moltissimo nella sua attività di scrittore, e non solo di chimico. Senza quel naso non avremmo neppure il testimone». Lo ricorda anche Mario Porro: la formazione scientifica ha chiaramente «contribuito a predisporre lo sguardo con cui Levi ha vissuto e osservato il Lager». Ma dopo Auschwitz è difficile pensare che Levi, riflettendo su dinamiche e conflitti fra gli esseri umani, e tra questi e altre specie, non avesse in mente anche la Shoah, lo sterminio come esito estremo.
Le questioni di fondo che il tema del convegno solleva sono cruciali anche per altre ragioni, intrinsecamente legate all’esperienza di Levi e ai temi della sua scrittura e riflessione. Come osserva qui Marco Aime, «Levi è qualcosa di più di un semplice narratore o di un classico etnologo, è un testimone, un osservatore, suo malgrado, partecipante». Per questo rileggere l’opera leviana alla luce dell’etologia e dell’antropologia significa interrogarsi sulla possibilità di estendere osservazioni maturate in una specifica condizione storica al livello più generale dei rapporti tra individui, culture, specie. Con Santucci e Alleva, possiamo chiederci se i modelli darwiniani siano adeguati per far luce sulle ragioni che hanno spinto «un pacifico e religiosissimo contadino bavarese» a trasformarsi in pochi mesi «in una belva omicida».
Levi stesso si è posto domande simili, dandosi risposte diverse nel corso degli anni, ma sempre evitando – lo osserva Gianfranco Marrone – sia il «riduzionismo delle differenze culturali» su base biologica, sia il relativismo culturale che «tende a giustificare ogni azione e valore». C’è un residuo «che sfugge all’etologo comparativo – scrive Telmo Pievani – un inedito umano pur sempre naturale ma non spiegabile solo biologicamente». Certo, nei racconti di Storie naturali umano e animale tentano di ibridarsi, lasciando intravedere nel rapporto tra uomini e creature fantabiologiche dinamiche simili a quelle storicamente attuate in nome della cosiddetta razza. (È in questa prospettiva, ad esempio, che Alessandro Cinquegrani legge qui le Storie naturali). Ma, come ricorda Robert Gordon, proprio nei racconti fantastici riemergono anche «altri strati, stili e pensieri» elaborati nel primissimo Dopoguerra e messi in secondo piano dalle esigenze della testimonianza. (Proprio la conoscenza degli ‘altri stili’ di Levi, degli «aspetti della sua coscienza o del suo sentire che più resistevano alla ragione analitica», come scrive Barenghi, è tra gli obiettivi di questo volume).
Levi ha respinto l’assimilazione del Lager ad altri pur tragici avvenimenti della storia e dolorose condizioni dell’esistenza, ma ha spesso riflettuto sulla violenza e sulla sottomissione del più debole come tratti costanti sia del comportamento umano, sia di ogni animale sociale: lo ricorda anche Ugo Fabietti nel suo scritto sul «razzismo secondo Primo Levi». Esiste «notoriamente un razzismo zoologico, proprio degli animali sociali», ha scritto Levi in un articolo del 1979 sulla ricezione del film Holocaust, significativamente intitolato Perché non tornino gli olocausti di ieri (le stragi naziste, le folle e la TV). Lo scrittore, cioè, non ammette l’equiparazione letterale del Lager ad altre situazioni di costrizione o disagio, ma accetta l’uso della parola sul piano metaforico, come termine di confronto e orizzonte estremo contro cui osservare e valutare anche dinamiche di relazione che niente hanno a che fare con lo sterminio. È in questa chiave, direi, che occorre per esempio interpretare il parziale accostamento tra la condizione del deportato e quella di Buck, il cane protagonista del Richiamo della foresta, che Levi azzarda recensendo per «La Stampa» (11 gennaio 1987) il romanzo di London, uscito da Einaudi nella traduzione di Gianni Celati: «Buck, grazie al suo vigore fisico e morale, supera la prima prova, quella della deportazione, un viaggio interminabile in ferrovia e poi su un battello, e giunge in un paese ostile e nuovo». Sembra invece avere poco a che fare non dico con il tema, ma nemmeno con la metafora concentrazionaria il breve scritto Contro il dolore (1977), che qui Damiano Benvegnù sottrae giustamente alla comparazione con la Shoah e riconduce al dibattito intorno alla sperimentazione sugli animali, protrattosi a lungo nelle pagine de «La Stampa».
Il nuovo numero di «Riga», come i migliori studi della terza fase critica leviana, consegna immagini inedite dell’autore e lascia aperte domande e prospettive. Un ‘buon uso’ di Levi consiste anche nel darne un ritratto non cristallizzato in icona e nel far reagire le sue opere con le questioni, i metodi e i saperi a cui si è interessato e che hanno alimentato la sua scrittura.
Una prima e più breve versione di questo scritto è stata pubblicata in «Alias Domenica», 24 dicembre 2017.









