Speciale
Una conversazione / Antoine Volodine: post-esotismo in dieci domande
Se come profetizzava William Burroughs la parola è un virus, dobbiamo figurarci sul tavolo autoptico il corpo ormai freddo del Novecento. Dilaniato dalle infezioni trasmesse dalla storia, dalle ideologie, dalle rivoluzioni, dalle restaurazioni più o meno violente. Ventre molle di questa salma inerte, il linguaggio sopravvive alla fine della civiltà occidentale e trova nella poetica del fallimento e della catastrofe un nuovo corpus creativo, dentro al quale rigenerarsi in spore e proliferare come tanti piccoli aracnidi pronti a esplodere verso il mondo esterno.
Precisamente dentro questo ventre risiede la letteratura di Antoine Volodine, tra i più inclassificabili autori contemporanei, mimetizzato in un mare di eteronimi che firmano i testi cardine della letteratura post-esotica, manifesto letterario dell’altrove e della catastrofe finale. Lontano da ogni possibilità di classificazione editoriale, il post-esotismo è un superamento della finzione letteraria, del trattato politico e delle forme poetiche brevi; invenzione di un sottosuolo nel quale il significante si riproduce e si moltiplica senza controllo generando canti di disperazione e di fuga dalle sbarre del mondo odierno. Secondo la lezione undicesima di Volodine, il post-esotismo sarebbe infatti composto da oltre settanta autori, la maggior parte deceduti, e una lista di 343 opere post-esotiche, unico vero retaggio del movimento.
“Antoine Volodine è nato nel 1949 o nel 1950 o a Lione o a Chalon-sur-Saône” recita la sua biografia in apertura del volume Scrittori (Edizioni Clichy, 2013), rivendicando sin dal principio una radicale messa in discussione del concetto di identità che l’autore franco-russo pone al centro della sua poetica. Negli anni, la letteratura post-esotica e il suo autore si sono imposti all’attenzione della critica internazionale attraverso una manciata di testi clamorosi che hanno fatto scrivere al Times che Volodine “sta diventando il più importante scrittore europeo”; da Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima, Gli animali che amiamo e Angeli minori, fino al successo di Terminus radioso (66thand2nd) vincitore del Prix Médicis 2014, Volodine è presto diventato un autore di culto tradotto in tutto il mondo.
Sterilizzato l’io, non rimane che un noi. Apocalissi e fallimenti diventano la materia viva della letteratura post-esotica, della quale Volodine è soltanto una piccola voce accanto a quelle di Lutz Bassmann, Manuela Draeger, Elli Kronauer e altre multiformi identità testimoni della fine della civiltà occidentale, che sembrano parlare attraverso un opprimente corpo-prigione. Una voce che è tornata a incarnarsi in Volodine con la recente pubblicazione di Sogni di Mevlidò (66thand2nd, 2019), investigazione notturna sospesa tra realtà e onirismo degna del Max Ernst di Una semaine de bonté, e che presto parlerà attraverso Lutz Bassmann con Black Village, nelle librerie dal 24 ottobre sempre per 66thand2nd, riconfermando i post-esotici come i grandi virtuosi della catastrofe, con i loro canti intrisi di oscuro romanticismo esalato dal fondo del loro penitenziario metafisico.
Lo abbiamo incontrato a Pavia, dove è stato ospite del festival “La Milanesiana”, per un’intervista sui temi post-esotici con la traduzione di Anna D’Elia.
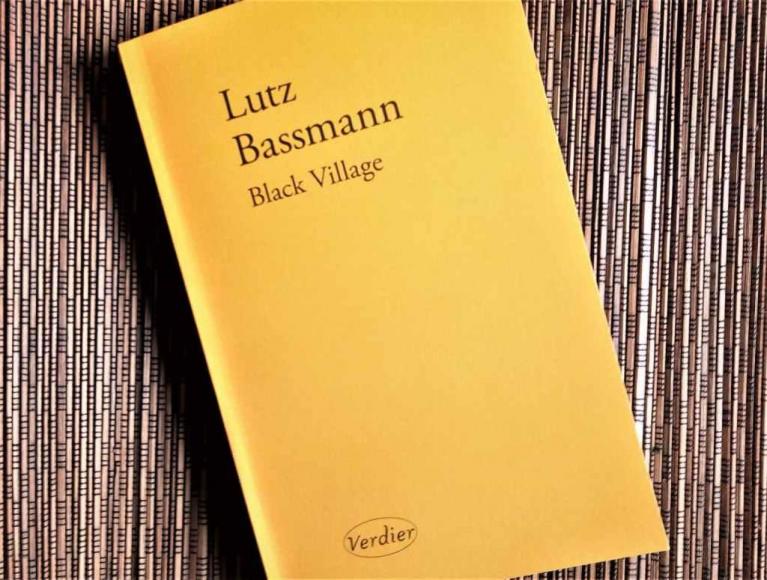
Le è stato chiesto per il festival di parlare di speranza. Di che speranza si nutre la scrittura di Antoine Volodine?
Quando sono stato invitato a parlare di speranza mi sono detto che non avrei potuto accettare, perché nei miei libri ha uno spazio molto ristretto. La speranza per me, per i miei personaggi, è quasi nulla. Perché l’umanità ha distrutto la sua esistenza e sta andando verso la sua fine, e l’unica speranza possibile è che dopo l’umanità il pianeta, che è stato violentato e martirizzato dall’umanità, riprenda un po’ della sua normale vita naturale. Ciò non ha niente a che fare con la scrittura, ma piuttosto con una visione del mondo piuttosto pessimista.
Spesso si scomoda la distopia per spiegare il suo magma narrativo. Eppure, più che a un ipotetico futuro immaginifico, le sue storie sembrano attingere al passato possibile, ai fantasmi del Novecento e delle sue ideologie.
Credo sia esattamente così. Il motore di quasi tutti i nostri libri, e dico nostri perché siamo un collettivo composto da Antoine Volodine ma anche da Lutz Bassmann, Manuela Draeger, Elli Kronauer di cui Volodine è il portavoce, il motore alla fine è la constatazione del proprio fallimento politico e militare, che coincide con il fallimento del progresso che ci ha condotto a questo disastro, e il fallimento delle utopie del Novecento. Il motore è quello di rivivere i miti della propria generazione dopo il loro decesso, così come si ricorda la propria vita durante il periodo caro alla metafisica buddista che è il bardo, quel periodo di 49 giorni che segue il decesso e in cui prima di ricominciare la serie di reincarnazioni si fluttua rivivendo gli eventi della propria vita come in un sogno. L’ispirazione bardica dei libri post-esotici parte da lì. I nostri libri seguono un cammino, il cammino dopo il decesso. Così come nel Bardo, i personaggi all’inizio del libro proseguono un cammino che li porta verso la fine, l’estinzione. Spesso nei libri post-esotici questo cammino è raccontato in 49 sequenze, o 49 capitoli, riprendendo quella filosofia. È un mondo fluttuante, ma non si tratta di futuro: è un presente all’insegna del rimuginamento sul passato, un presente sul quale irrompe il passato. Rimuginio su ciò che sarebbe potuto accadere, letto attraverso un prisma onirico, che passa da una prospettiva singolare che diventa collettiva e anche oltre, verso il terzo stadio della disfatta della storia dell’ultimo secolo. Un prisma onirico che consente la finzione narrativa e la poesia, ma che si basa sul reale e sulla realtà del passato. Questo prisma ci consente di emanciparci dal reportage, non sono delle testimoniante, ma piuttosto una rifrazione onirica di ciò che è stato. Fino a diventare finzione narrativa e scrittura.
L’immaginario di Terminus radioso, ad esempio, sembra risiedere nel punto di incontro tra memoria collettiva, memoria privata, memoria cinematografica e una sorta di memoria onirica che sembra avvolgere tutto come una patina opaca.
Ci sono due piani. Esiste la cultura dei personaggi che vengono messi in scena nei romanzi post-esotici, che è la cultura dei prigionieri e delle prigioniere. Poi c’è la cultura in senso più vasto, degli scrittori post-esotici. Ad esempio, la cultura di Volodine si nutre non solo di letteratura ma anche di cinema. Una cultura in cui il peso della letteratura precedente e quello dell’immagine sono equivalenti. L’immagine ha un influsso molto forte.

Il post-esotismo può essere forse considerato un modo per oltrepassare le strutture e le categorie letterarie del Novecento, verso una nuova idea di letteratura?
Non abbiamo la pretesa di cambiare le regole. Sta piuttosto alla critica stabilire l’apporto che la letteratura post-esotica può costituire rispetto allo sfondo generale. Nei miei primi libri mi consideravo un dissidente. Nei nostri libri ci sono gli elenchi di centinaia di dissidenti deceduti. Si tratta di una dissidenza di tipo politico, nei confronti di tutte le opzioni politiche disponibili, un rifiuto anche di tipo metafisico, molto più vasto, nei confronti del mondo reale, con degli accenti di schizofrenia. C’è insomma un noi, e un resto. Il noi è formato da prigionieri chiusi in un carcere, e quindi l’idea che la letteratura post-esotica ci costituisce intra-muros, e che extra-muros c’è l’altra letteratura, che può essere molto bella o molto brutta, ma è anzitutto altro. La letteratura post-esotica non pretende di superare ciò che sta all’esterno, ma unicamente di far vivere e sopravvivere ciò che si produce all’interno, intra-muros. Questo spiega l’esistenza di particolari strutture e forme letterarie che non sono affatto state concepite per dare lezioni agli altri, non sono un canone da imporre a qualcuno. Vogliono solo condividere le storie all’interno di un universo chiuso, che è un universo carcerario.
Al centro dei suoi romanzi sono spesso le classi sociali più basse. Incarcerati, folli, depressi, incompresi. Esseri ai quali tutto è stato tolto. Non rimane loro, dal profondo delle loro celle, che la parola, i libri. Un’arma, o piuttosto un’allucinazione?
La parola non serve a nulla rispetto alla situazione contingente in cui gli scrittori si ritrovano incarcerati, e non serve a nulla rispetto a ciò che avviene fuori. Non è certamente un’arma, è un mezzo per continuare a mantenere viva un’esistenza di creatività. Letteraria, ma anche orale. È piuttosto un sistema per mettere in moto una macchina creativa che fa circolare dei testi o delle storie, li riprende, li corregge, li ripete, li cambia leggermente, un sistema per continuare a far fluire il percorso narrativo. È molto importante che la parola si rifaccia a una fonte orale, sia a un’oralità inventiva, oppure che riprende delle forme orali realmente esistenti come le byline russe, che sono delle strutture poetiche realmente esistite, oppure con gli haiku. Lutz Bassmann, ad esempio, ha scritto un intero romanzo carcerario, Haiku di prigione, tutto composto seguendo questo modello che proviene dall’oralità. Alla base c’è una forte attrazione per forme di oralità come gli slogan, come il racconto fiabesco ripreso da Manuela Draeger, oppure la narrazione orale di tipo ritmico che fa pensare ai primigeni racconti del neolitico, e poi il rapporto tra la parola e la respirazione sciamanica.
L’arte, in particolare la scrittura, possono ancora essere un motore di cambiamento della società?
Io non credo che oggi la letteratura, la poesia o il cinema possano avere un impatto sulla società come si pensava fino al dopoguerra. Abbiamo avuto il periodo della letteratura impegnata, delle prese di posizione da parte dei grandi scrittori, oppure il peso degli scritti o ad esempio dei dissidenti sovietici nei confronti del regime sovietico. Io non credo affatto che oggi gli scritti dei dissidenti cinesi abbiamo qualche forma di impatto sul regime cinese. E non parlo solo della Russia o della Cina, ma parlo in generale dei regimi politici occidentali. Certo l’arte può marcare, segnare, alcuni individui e alcune sensibilità. Ma come intervento collettivo non credo oggi sia possibile.
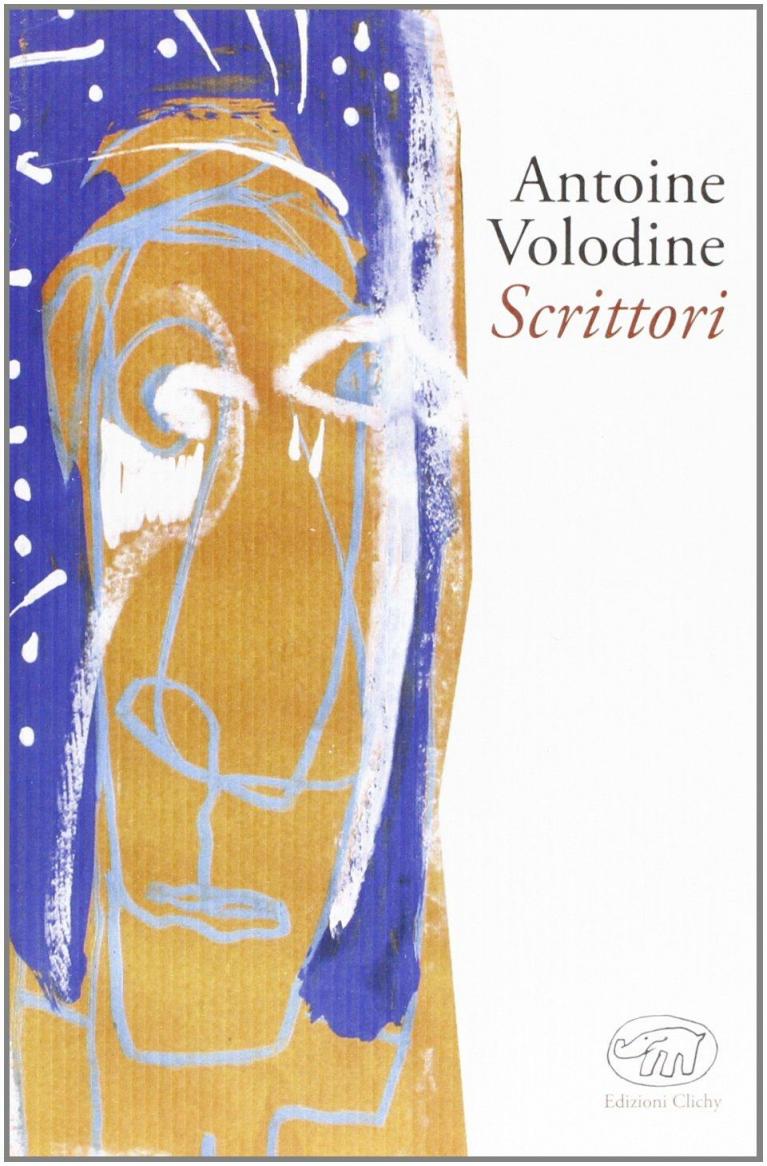
Lutz Bassmann, Manuela Draeger, Elli Kronauer, Infernus Iohannes, Antoine Volodine. I suoi romanzi parlano attraverso tante voci che sembrano altrettanti frammenti della sua figura, proliferanti come i ragni del brano che ha letto di fronte al pubblico italiano. Cos’è per lei l’identità?
Non saprei rispondere esattamente, se non sottolineando che la proliferazione delle identità si pone lo scopo di minare alla base l’autorità e la potenza taumaturgica dell’Autore con la “a” maiuscola, del singolo autore. È una disseminazione che tende a far sparire la potenza della singola firma in favore di un collettivo di voci. Un collettivo in cui i vari membri sono nominati con il loro nome, ma in favore di un’operazione comune, collettanea. Negli ultimi libri che rimangono da scrivere, l’idea è quella di eliminare qualsiasi firma personale in favore di una singola firma collettiva, che somma tutte le voci e va sotto il nome di “Infernus Iohannes”. Non sarà più possibile distinguere una singola voce dall’altra, ma si affermerà come un’entità collettiva. Non ci sarà più una vera identità.
La sua narrazione marginale, con un corpo annullato e decentrato, è un modo per contestare l’autorità centrale, maggioritaria, padronale. Forse il modo migliore di uccidere il padre è nascondersi dietro un’ombra, non farsi più trovare?
Non sono molto preoccupato dalla morte dei padri. Ci interessa parlare di un sistema politico ben preciso, questi autori vivono all’interno di un totalitarismo del pensiero che li ha distrutti e che distrugge il contesto, e loro si battono contro questo totalitarismo del pensiero. Dire che si battono è improprio, perché in realtà non si battono, vivono dentro questo sistema soverchiante, che li distrugge e che ha distrutto la loro opzione di rivolta. La lotta ormai è individuale, sono voci che ricordano una collettività perduta, e che ormai sono state sconfitte. Oggi si trovano a vivere un’individualità, sono sole, solitarie, e hanno un pensiero nostalgico di una collettività perduta. Ma, allo stesso tempo, il sistema post-esotico è a sua volta totalitario, e azzera l’esterno. Gli scrittori post-esotici ricreano un sistema totalitario, di tipo positivo, ma tutto intra-muros. Un totalitarismo poetico letterario, ovviamente.
Nella sua narrazione rientra spesso il tema della catastrofe finale, del fine corsa. Crede sia un processo irreversibile verso il quale è destinata la nostra società o c’è ancora un modo per invertire la rotta?
Credo che ormai il danno sia fatto. Come nel pezzo che ho letto, arriveranno forse i ragni.
Dunque la frase “Je me tais” pronunciata da Infernus Iohannes sarà l’atto finale della letteratura post-esotica?
Se noi riusciremo, e parlo della pluralità di voci, a concludere questo edificio letterario post-esotico composto da 49 testi, l’oggetto poetico si concluderà con la frase “qui mi taccio”. E credo sia un bene che finisca in questo modo. Quello che intendo dire è che avrà luogo la fine dell’esperienza professionale e esistenziale dell’autore. Non ci sarà uno sviluppo, è una costruzione cogente maturata in 49 testi e che deve finire. Bisogna saper finire, saper mettere un punto. Non si potrà continuare ad andare in giro e mostrarsi al mondo: sarà una conclusione perfetta. Un finale dentro le mura.
Leggi anche
Livio Santoro, Il nostro immane fallimento collettivo









