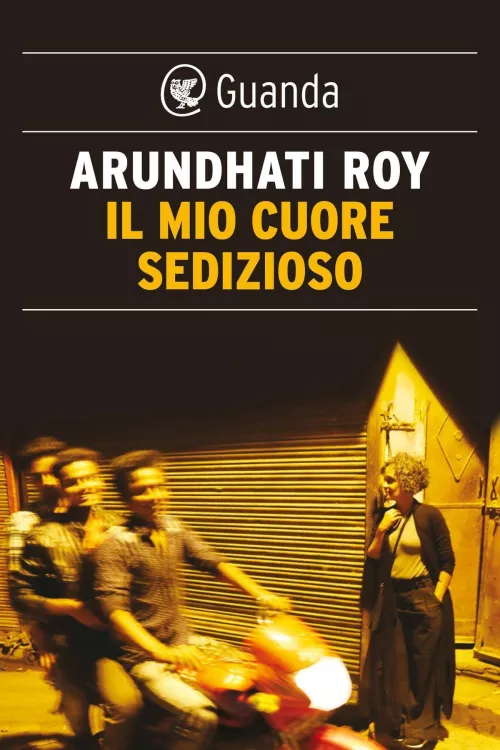Inchieste, saggi, testimonianze / Arundhati Roy, o della sedizione appassionata
La prendo larga. Cosa altro fare davanti alle oltre 900 pagine di Il mio cuore sedizioso (Guanda) che raccolgono le inchieste, i saggi e le testimonianze scritte da Arundhati Roy nei vent’anni intercorsi tra i due romanzi della scrittrice indiana – (Il dio delle piccole cose, nel 1997, e Il ministero della suprema felicità, nel 2017). La prendo larga, dicevo, perché in queste pagine, impossibili da sintetizzare, si ragiona di molte cose, spesso tra loro correlate, e che negli anni transitano in misure diverse da un testo all’altro – e in questo senso le date in cui sono stati scritti sono importanti – come tracce tanto di un impegno civile quanto di una storia che pare ripetersi senza riuscire a cambiare verso.
Si parla innanzitutto di India, e dall’India, ossia da un paese che vive “in secoli diversi allo stesso tempo” e anche per questo è percorso da numerose e profonde linee di faglia – le caste, la povertà, il nazionalismo, il fanatismo religioso, etc. – che periodicamente scatenano la loro energia in episodi di inaudita violenza e ferocia (a Delhi nel 1984, a Mumbay nel 1992, in Gujarat, nel 2002, solo per citarne alcuni). Si parla poi, dall’inizio alla fine, di “sviluppo”, e di come in suo nome si imponga ai cittadini, soprattutto a quelli delle classi più povere (e fuori casta, come gli adivasi, o “abitanti originari”, e i dalit, gli intoccabili, circa il 25% della popolazione), “qualcosa di simile a una guerra civile non dichiarata”, rafforzando ogni volta di più le già enormi diseguaglianze sociali e economiche esistenti (un solo dato: in un paese con oltre un miliardo e trecento milioni di abitanti “le cento persone più ricche del Paese possiedono beni equivalenti a un quarto del suo tanto decantato PIL”). Si parla, molto, di dissenso, quello argomentato e non-violento – “il migliore prodotto d’esportazione dell’India” – ma anche quello che, in un contesto esacerbato, imbraccia le armi (come, da oltre 50 anni, il movimento maoista dei Naxaliti), e di cosa accade quando la repressione di questo diventa la scusa per criminalizzare sempre più spesso anche il primo. Si parla, ancora, di cosa vuol dire essere una scrittrice “presumibilmente famosa”, “onere piuttosto dubbio” in un paese dove ci sono ancora milioni di analfabeti, e “della difficoltà a rassegnarsi, dal punto di vista sia personale sia politico”, alla natura schizofrenica e predatoria di quello che Andrea Zanzotto definiva lucidamente “progresso scorsoio”. E poi anche di come siano proprio le donne al centro di molte delle battaglie contro di esso oggi in corso in India, del suo considerarsi soltanto una tra queste, e del ricorrente fastidio provato di fronte a ogni semplificazione del loro ruolo, anche di quelle di stampo femminista, e al costante bisogno di ridurle alla condizione di “vittime”. Si parla, a più riprese, di guerra, di quella che sulla scia delle lacerazioni create con la Partizione del 1947 infiamma da anni il Kashmir e le relazioni con l’altra potenza nucleare della regione, il Pakistan, di quelle provocate dall’intervento americano in Iraq prima, e in Afghanistan dopo l’11 settembre sotto la capiente bandiera della lotta “al terrorismo”. Si parla, ancora e a più riprese, di immaginazione, come qualcosa che può essere messa in scacco e manipolata dal potere – anche da quello di matrice gandhiana – e che però allo stesso tempo è necessario provare a riattivare per poter opporvisi, difendere le proprie ragioni e mantenere la libertà, “perché in fin dei conti la libertà non è altro che questo: scelta”. Anche confrontandosi con i limiti, i paradossi e gli errori intrecciati delle utopie rivali incarnate dalle due figure iconiche di Gandhi e di Bhimrao Ramji Ambedkar, “padre” della costituzione indiana, e autore nel 1936 di un duro attacco al sistema castale – Annihilation of caste – in cui analizza le relazioni esistenti tra questo, il capitalismo e le tensioni religiose.
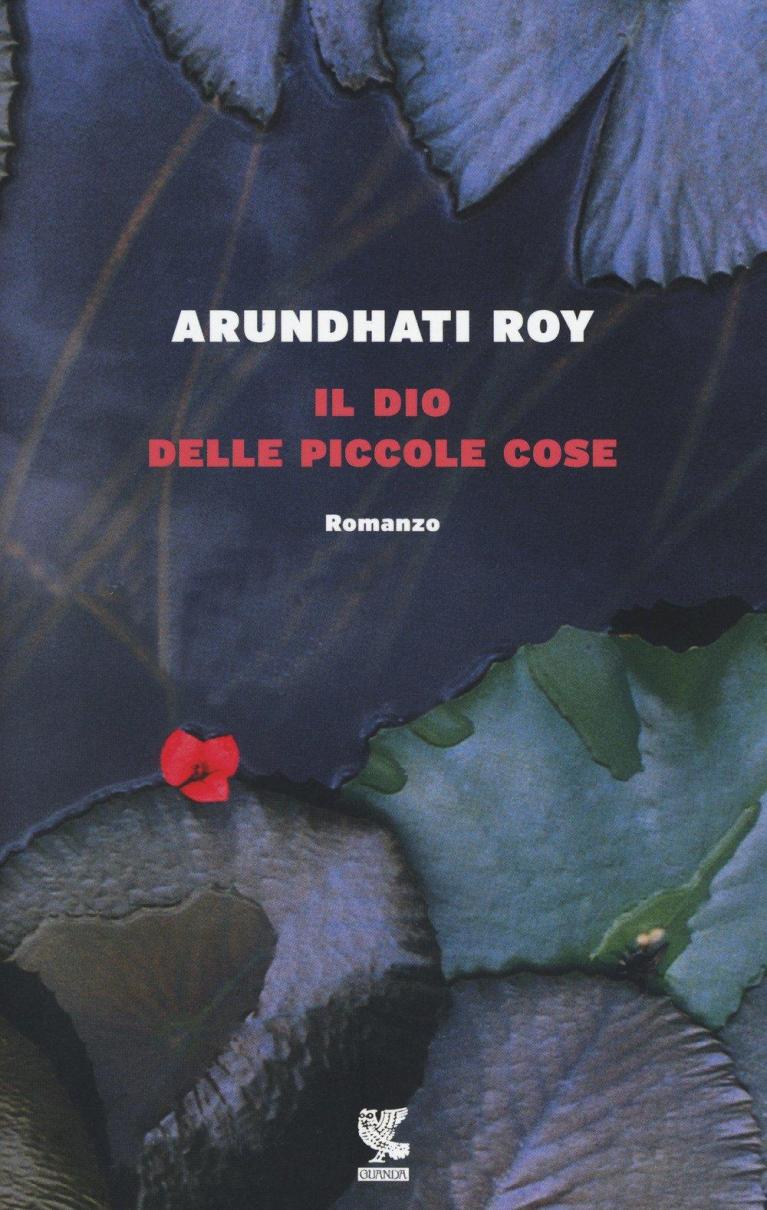
Presi singolarmente, ognuno dei temi appena accennati, meriterebbe un ragionamento in sé, che ci porterebbe lontano, e conoscenze che non ho. Presi invece come un tutto, possono essere interpretati, riprendendo il titolo di una sua precedente raccolta di saggi, in gran parte confluita in questa edizione, come Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers (Note di campo sulla democrazia: ascoltando le cavallette). Nel suo insieme, Il mio cuore sedizioso è questo: una estesa e appassionata indagine dalla prospettiva della cosiddetta “più grande democrazia del mondo”, su quello che oggi la “democrazia” fa. Concretamente. Nella vita della gente, in particolare di quella che non ha voce e che il potere giudica sacrificabile, e delle questioni politiche e di giustizia che solleva. Perché “una volta che il linguaggio è stato squartato e dissanguato fino a rimanere privo di qualsiasi significato... quando libertà vuol dire occupazione, democrazia significa capitalismo neoliberalista, riforma equivale a repressione”, possiamo legittimamente chiederci con lei se e fino a che punto quella cosa che chiamiamo “democrazia”, intesa non come un ideale ma come una prassi quotidiana, “possa ancora dirsi democratica?” (E chiederselo non significa, come qualcuno suggerisce di tanto in tanto, rimettere in discussione l’idea di suffragio universale – via il voto a chi non vota come (“Noi” sappiamo) dovrebbe votare – ma piuttosto non accettare né rassegnarsi alla fusione, e confusione, storica tra democrazia e libero mercato).
Il “metodo” Roy, se ce n’è uno, prende forma fin dal saggio che apre la raccolta, Un mondo senza immaginazione, che non è solo il primo cronologicamente parlando, ma anche quello che in un certo senso dà il tono alla raccolta. Pubblicato nel 1998 su Outlook e Frontline, due dei principali periodici indiani in lingua inglese, il testo è una risposta a una duplice esplosione: quella fisica connessa ai test nucleari lanciati quell’anno dal governo guidato dal BJP (Bharativa Janata Party, il Partito del Popolo Indiano, fautore di un nazionalismo induista spinto), e quella emotiva – Un’esplosione di autostima, titolava un giornale il giorno dopo lo scoppio – legata alla celebrazione e all’orgoglio, anche di molti intellettuali, che li ha accompagnati. L’inizio del testo è lapidario:
Il governo indiano ha comunicato a noi, il suo popolo: “Il deserto ha tremato”.
“La montagna è diventata tutta bianca” ha risposto il governo del Pakistan.
L’orrore di fronte alla possibilità concreta di una guerra atomica con il potente vicino, il nemico necessario per una classe politica che ha tradito e ingannato il suo popolo – e l’accusa vale anche per l’Indian National Congress, il Partito del Congresso, fautore dell’Indipendenza, e responsabile di aver preparato il terreno per l’ascesa al potere del BJP (ci ricorda niente?) – era pari “agli effetti che quello squallido linguaggio appena coniato avrebbe avuto sulla nostra immaginazione, sulla nostra idea di noi stessi”. Ripensandoci, scrive Roy nella prefazione (2017), “mi rendo conto che quei test nucleari hanno ingigantito ogni crepa e ogni frattura di una società già divisa e spaccata.” Come dire allora ai milioni di persone che abitano il paese cosa veramente vuol dire la bomba nucleare? Come colmare lo scarto “tra conoscenza e informazione, tra ciò che sappiamo e ciò che viene detto, tra ciò che viene ignorato e ciò che viene asserito...”. La tragedia è che “anche volendo nessuno poteva farlo. Veramente, letteralmente, non esiste lingua in cui farlo. Questo è il vero orrore dell’India. L’orbita dei potenti e quella dei senza potere si allontanano sempre di più l’una dall’altra, senza mai intersecarsi, senza niente in comune. Neanche una lingua. Neanche un paese”. E comunque, dichiarava nel 2002 l’allora ministro degli Interni indiano, “l’istruzione non è una priorità”. Cosa fare allora per non restare imprigionati in questo “esperimento di nazionalismo” – in cui “la Bomba è l’India, l’India è la bomba”? Non tutta però, solo quella “indù” – in cui l’arma nucleare come apoteosi della modernità non minaccia solo il nemico, ma viene usata anche “per dichiarare guerra al suo stesso popolo” (secondo la sperimentata e diffusa logica del “o con noi, o contro di noi”)? Cosa ci resta? “Se rifiutarsi di farsi impiantare una bomba nucleare nel cervello è anti-indù e antinazionale”, scrive Roy “allora dichiaro la secessione”. Dall’India come Hindu Rashtra (Nazione indù) e dalla “schiavitù nucleare” che la struttura, certo, ma in un certo senso anche da quel “cono di luce fatata” che l’ha avvolta dopo il successo mondiale del primo romanzo e che, nella sua irripetibilità poteva avere, come l’avvertiva un’amica, un unico finale degno: la morte (il successo come esplosione nucleare?). Perché la vera secessione, quella innescata dalla liberalizzazione del mercato indiano dei primi anni ’90, voluta dall’Indian National Congress, è quella interna, quella delle classi medio-alte “trasferitesi in un paese tutto loro, in alto nella stratosfera”, l’India “splendente”, completamente separato dal resto dell’India. Nel tentativo, apparentemente non riuscito, di spiegare a quell’amica che esistono anche mondi – “vivi da troppo tempo a New York” – in cui il riconoscimento non è l’unico parametro per sentirsi realizzati e il fallimento è qualcosa di concepibile, Roy appunta su un tovagliolino di carta una serie di punti della sua concezione della vita. Gli ultimi, su cui pone l’accento, dicono: “E, soprattutto, guardare. Cercare di capire. Non distogliere mai lo sguardo. E mai, mai, dimenticare.”
Guardare, soprattutto. E da vicino. Poi, provare a capire. E mai dimenticare. Questo è il terreno su cui poggia la scrittura della Roy nel suo tentativo di “cattura l’immaginazione della gente”, nel paese e all’internazionale, e di capire come sia possibile ricomporre il tessuto sociale di un mondo “squarciato e dilaniato in questo modo”; come sia possibile render conto con la scrittura “sia della violenza sia dell’opposizione consapevole e civile alla violenza” (così Amitav Ghosh, in I fantasmi della signora Gandhi, raccontando il massacro dei sikh a Delhi dopo l’attentato ad Indira Gandhi dell’ottobre 1984). Esemplari in questo senso due dei testi più interessanti del libro. Il primo, ripercorre la lunga vicenda dello sfruttamento idroelettrico del fiume Narmada (Per il bene comune, 1999) e delle lotte condotte dagli abitanti della valle e dal movimento del Narmada Bachao Andolan contro un’operazione di ingegneria sociale e ambientale a grande scala fedele a quell’ideologia ultra-modernista analizzata da James Scott in Lo sguardo dello stato. Nella retorica nazionalista indiana, da Nehru in poi, le grandi dighe sono state e sono ancora le icone di un’idea di modernità nella quale lo sradicamento di decine di milioni di adivasi e dalit, e lo stravolgimento degli equilibri ecologici che generano è funzionale al mantenimento dello stile di vita solo di una parte della popolazione del paese: “e qualcuno ha ancora il coraggio di parlare della più grande democrazia del mondo?” Il secondo, è il resoconto (In marcia coi ribelli, 2009) della sua breve esperienza tra la guerriglia maoista, a forte componente tribale, nelle foreste del Bastar, un distretto dello stato di Chhattisgarh sede di importanti giacimenti di bauxite e altri minerali, e di altrettanto importanti operazioni militari di contro-insorgenza da parte del governo indiano (leggere per avere una prospettiva più ampia e complessa di questo fenomeno Marcia notturna. Nel cuore della guerriglia rivoluzionaria indiana, preziosa analisi dell’antropologa Alpa Shah appena tradotta da Meltemi).
Ecco, la sedizione, quella del cuore e delle ragioni – talvolta paradossali – che l’alimentano, sta nella caparbietà del voler rendersi visibili “anche se abbiamo perso”, anche di fronte all’intensificarsi della repressione da parte di quanti sono al potere. Sta nell’ostinazione sovversiva di voler dare e riconoscere un senso a questa parte “a parte” che non ha luogo nelle configurazioni politiche attuali, quelle che ancora chiamiamo “democrazie liberali occidentali”, pur costituendone una parte fondamentale. Rinunciare a pensarla, sarebbe la vera e irrimediabile sconfitta.