Il sentimento panico di Giancarlo Pontiggia
Nella poesia italiana degli ultimi decenni, Giancarlo Pontiggia ha assunto un ruolo centrale, riconosciuto da tutti e per certi aspetti peculiare, che il suo ultimo libro, La materia del contendere, ribadisce con forza.
La poesia di Pontiggia, infatti, (come ha indicato egli stesso in scritti di riflessione, quali gli Undici dialoghi sulla poesia, 2014) non si focalizza su un ipotetico primato della parola, né sulla ricerca “interiore” di un io lirico. Piuttosto, riportandosi a una genealogia antica di poeti che furono anche filosofi e scienziati, l’autore – che è studioso e traduttore di classici – fa della sua scrittura un’esperienza conoscitiva che si interroga sulle origini delle cose (“semi”: i lucreziani semina rerum), sull’universo, sul tempo e – immersa nell’universo e nel tempo – sul significato dell’esistenza umana.
Dopo gli esordi sperimentali della Parola innamorata (1978, che l’autore ha storicizzato, affermando che si trattava di poesie di un’epoca più che sue) un certo tipo di domande ha costituito il punto di partenza della poesia di Pontiggia fin dalla prima raccolta (Con parole remote, 1988), dove era messa a fuoco anche la posizione che l’autore assumeva nella ricerca delle risposte, ovvero essere un “ascoltatore del mondo” (Sono solo un modesto / ascoltatore del mondo, porgo orecchi al vento / delle cose che battono // che ritornano con la semplice / domanda: chi sei? Da dove/ vieni?; “Penso”, in Con parole remote, 1988, ora in Origini, Interlinea edizioni, Novara, 2015).
Tale dimensione di indagine è resa manifesta, anche nel nuovo libro, da diversi incipit-domanda (diretta o indiretta):
«Mi figuravo di sapere cos’è bene e cos’è male» (p. 17 Cos’è bene e cos’è male)
Com’è che la vorresti questa vita, / tua, ora, in questa sera (p. 26, Questa vita)
Che cos’è bene? […] C’è un bivio, a ogni svolta del pensiero (p. 27, Come la fiamma)
Che cos’è cammino, e cosa aria, fuoco, acqua, / pugno di terra, cosa io che scrivo (p. 35 Che cos’è cammino)
Cos’è fuoco, quando divampa e fa paura (p. 37, Cos’è fuoco)
Il concreto manifestarsi dell’“ascolto” ovvero osservazione del mondo porta l’autore a sviluppare situazioni che, nella loro variegata e quasi inesauribile fioritura di immagini, sono riconducibili a un nucleo concettuale ricorrente, che è il tempo; un tempo che, leopardianamente, si fa spazio, manifestando o rivelando la sua presenza nei grandi fondali naturali (il cielo, il mare), ma anche negli oggetti. Alla dimensione dello spazio-tempo che trascorre, colto nell’alternanza dei secoli, degli anni, delle stagioni o nell’avvicendarsi delle ore del giorno, si legano le parole-emblema del vento e del fuoco (con variazioni semantiche: soffio, fiamma), della luce e del buio, del cielo e del mare, dell’acqua.
Il nucleo concettuale dominante propone una dialettica spesso drammatica: quella tra la temporalità illimitata della natura o dell’universo e la temporalità limitata delle creature.
La voce poetica talvolta ne assume il punto di vista, attraverso la prima persona; in altre occasioni si sdoppia in un io-tu dialogico; spesso, infine, parla tramite le figure di una atemporale classicità. In ogni caso, il soggetto si “[si imbatte] nella natura del vero” (p. 62, “Come in un lungo sonno”), si interroga su di esso, lo pone in dubbio, o ad esso si ribella, o talvolta lo accetta, dando vita a una gamma di sentimenti che spaziano dall’angoscia, all’incertezza, all’indifferenza, all’ironia, alla gioia. Un diagramma che aderisce a quanto pertiene all’umano sentire e, a ben vedere, anche alle sue filosofie e fedi e alla sua letteratura: elementi di cui la colta poesia di Pontiggia si nutre.
Consideriamo tre testi diversi per esplorare altrettanti aspetti di questa fenomenologia.
Soffi, fuochi (Un salto) (p. 86)
Quante erbacce, quest’anno, quanto cielo / fisso che ci sovrasta, e questo mare / che pare infinito. È un tramonto come tanti, / che acceca: e anche il vento / è oro./ C’era molta confusione, tra di noi, / e volti che venivano meno, anno / dopo anno, e un fuoco che ardeva, / sentivamo / il soffio dello scuro, e l’anima / che si perde per niente. Non è tardi / se ancora guardi, se credi, / se puoi credere / ancora un po’: c’è qualcosa / oltre qualcosa, che non mente, / e un salto / che nessuno ha mai fatto, / e tutti fanno. Ombre, acque che stagnano, fiamme / e questo vento che sale, / e si porta via tutto (p. 86, Soffi, fuochi)
Da uno spunto in apparenza occasionale, banalmente quotidiano (Quante erbacce, quest’anno) lo sguardo va a cogliere dimensioni spaziali sempre più vaste e soverchianti (il cielo / fisso che ci sovrasta; questo mare / che pare infinito; un tramonto […] che acceca]) che quasi inavvertitamente passano ad evocare la percezione del travolgente scorrere del tempo e dei suoi effetti distruttivi (volti che venivano meno, anno / dopo anno, e un fuoco che ardeva). Non è chiaro se e come possa esistere una forma di salvezza, se cioè c’è qualcosa / oltre qualcosa; certe spie stilistiche dell’esitazione – ripetizioni con variazione (se ancora guardi, se credi / se puoi credere / ancora); gli enjambements che scandiscono un procedere faticoso – lasciano intuire che la stessa voce che esorta (Non è tardi se…) non ne è certa.
Tutto è pieno di dèi, di vita che pullula (p. 88)
Tutto è pieno di dèi, di vita che pullula. / Oppure: non c’è un bel niente, / ma un niente che pullula di sogni, / di storie. Oppure: non c’è un bel niente, / e va bene così./ Cogli il frutto che matura, dicono in tanti, / dopo che lo disse un poeta sublime./ Oppure no, lascia che marcisca sul ramo, / con la sua buccia avida di sole./ È molta, troppa, la materia del contendere,/e neanche se fossi Aristotele, potresti venirne a capo./ Il tempo, questo sovrano senza regno,/che getta la sua moneta a ogni bivio,/ ne sa meno di me e di te, che ci guardiamo./ Non credere a chi crede troppo,/ e neanche a chi non crede, sii/ come la luce di questa baia, dove fa notte, / e basta
All’inquietudine del testo precedente fa riscontro in questo, intriso di echi letterari, una sorta di condiscendente, scettico invito, a non escludere alcuna possibilità sulla natura delle cose (e del tempo, qui degradato a “sovrano senza regno”). Tanto scettico da dubitare dello scetticismo stesso, il punto di fuga è una sorta di (nietzschiana? oraziana, orientale?) accettazione dell’attimo, il suggerimento a conformare la propria natura alla natura stessa delle cose.
E ti invade una gioia che non c’era (p. 91)
E ti invade una gioia che non c’era, / pensosa e umbratile. La vita che ci assale,/e non è tua né mia, s’intrude / tra le forme, bagnate, del pomeriggio. E la pioggia / è pioggia, il cielo / cielo, un sogno / lungo di sposa. Torniamo / allo scuro delle stanze, e ai lumi che ardono / e nessuno che lo sappia, oltre a noi / che ci guardiamo
Se è vero – come è stato osservato dalla critica – che le raccolte di Pontiggia sono pensate secondo strutture rigorose e non come cronologica seriazione di testi, la collocazione quasi conclusiva di questa poesia suggerisce di interpretarla come un vitale punto di arrivo. La vita che ci assale e si intrude in ogni forma (si noti: di un tempo breve e familiare: non gli anni o i secoli, ma il pomeriggio) impone stavolta gioia al “noi”, che potrebbe essere inteso come un tu e un io innamorati (induce a pensarlo anche il riferimento al sogno / lungo di sposa). Così, anche gli elementi naturali del mondo, che in altri testi si trasformavano in correlativi o allegorie di una condizione incombente o estranea all’umano, in questo vengono – tramite la tautologia E la pioggia / è pioggia, il cielo / cielo – riconciliati.
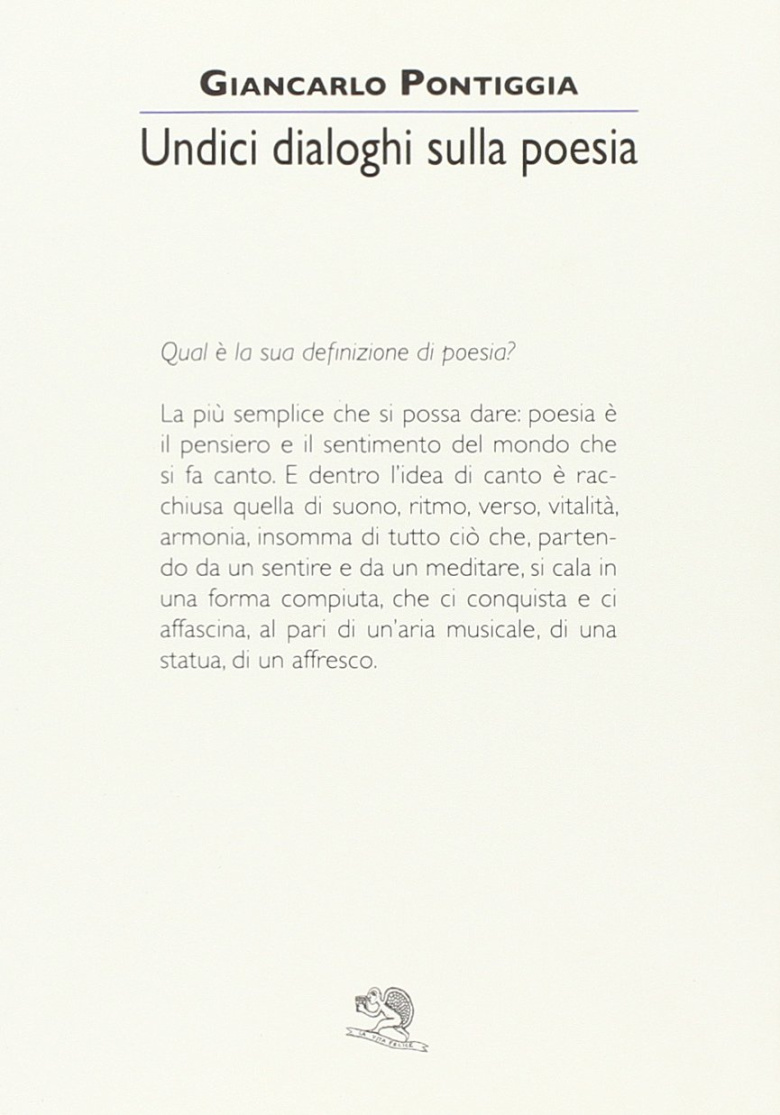
La conclusione della poesia, tuttavia (Torniamo / allo scuro delle stanze…) insinua il sospetto che anche questa gioia “panica”, afferrata e subito nascosta come un segreto, non sia definitiva, ma piuttosto solo un salto verso l’alto dell’ago del sismografo, lungo il diagramma alterno della condizione umana.
In questo genere di poesia, che si è tentati di definire “trascendentale” – nel senso che coglie situazioni universali e riferibili a tutti gli esseri umani – lo spazio della soggettività individuale, autobiografica, appare marginale; quando – e sembra una novità rispetto alle raccolte precedenti – si fa strada, Pontiggia raggiunge risultati molto alti, come in “Racconto d’autunno” (p. 14), di cui vale la pena riportare almeno la prima parte:
Ce ne stavamo, due o tre poeti ed io, il più taciturno di tutti,
intorno a un tavolino di un caffè della mia città, a struggerci
in pensieri che non avevano niente a che fare con la poesia,
eppure c’era qualcosa di allegro in quello stare insieme,
di allegro e di sfrontato,
forse perché eravamo giovani, e il cielo
era un cielo purissimo, quasi greco, e io
me ne stavo tutto rintanato nella mia gioia di quel momento,
a pensare
alla vita senza troppo badarci, e intanto
la vita scorreva intorno a noi, sovrana e indifferente,
come tutto quello che sfiora l’aria di questo mondo,
quando mi viene in mente una stoffa
che mia madre ha appena tirato fuori da un cassetto,
come da un buio di anni
e lei, la stoffa, sgargiante di ori e di azzurri a buon mercato
ritrova il fuoco, il legno
e l’urto del vento
che la fa andare da una parte e dall’altra delle cose
del mondo,
e il ferro di una seggiola
doveva essere all’inizio di novembre
ma mite come mai ce n’era stato, e forse era proprio il due
di un anno che è scomparso come tutti gli altri
Per concludere, alcune osservazioni sulla lingua della poesia di Pontiggia. Nella sua prima raccolta, come ha osservato Daniele Piccini in un breve e perspicuo saggio posto in appendice a Origini, Pontiggia incorporava nella scrittura anche riflessioni sulla costruzione della sua lingua, affidate a testi meta-poetici in cui si rifletteva, per esempio, sulla nominazione («Cerco nomi felici: / oro, ripeto, / cieli, meriggi, sole alto. Varco i tuoi, tempo, fiammanti cancelli; m’inoltro in un’aria tiepida, fra / anse e canneti, in una / verde corrente, / per rive docili, ombrose, / con voi, numi-custodi, fratelli // di un argine più remoto, / in una rada di frondoso sonno, / in un salvo fuoco»; Origini, p. 24)
Si direbbe che questa fase elaborativa sia ormai alle spalle e che l’autore sia approdato ai suoi risultati senza più sentire la necessità di giustificarli. Il risultato è una lingua poetica riconoscibile come consapevolmente non sperimentale, quasi del tutto priva di forzature espressioniste, viceversa “classica” nella sua immediata aderenza ai concetti e memore della grande tradizione del secondo ‘900 (in particolare Sereni, Luzi e Bertolucci).









