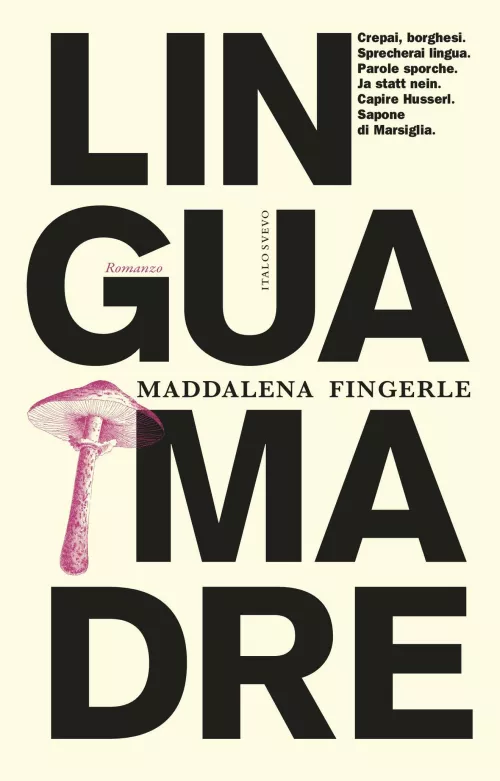Un esordio narrativo / Maddalena Fingerle. Lingua madre
Paolo Prescher, il protagonista di Lingua madre, romanzo vincitore del premio Calvino 2020 ora stampato dall’editore Italo Svevo, vive a Bolzano, ha un padre che non parla, una madre e una sorella che parlano troppo e male e nel nome un anagramma (“parole sporche”) che è condanna e profezia.
Fin da bambino Paolo è ossessionato dalle parole, “parola”, non “mamma”, è la sua prima parola; per lui le parole hanno colori, odori, sapori, sensazioni: “alcune parole tolgono la fame perché riempiono lo stomaco, anche al di là della cadenza e della dizione. Globo, per esempio, è un pasto completo, aiuola è un capriccio come lo zucchero filato e riempie la bocca, e poi ci sono le parole liquide che ti rinfrescano e ti dissetano, come glicine, e quelle che sono come le merende o uno spuntino, e tra queste c’è intonaco che ti impasta la bocca ma è bello come lo fa. Ci sono anche le parole che vanno di traverso, come biglia, che fa fatica a scendere ma quando scende la senti nella pancia. E dipende tanto anche da chi le pronuncia”.
Ma soprattutto le parole possono essere pulite o sporche e quando si sporcano le parole si sporca tutto, anche i pensieri che per esistere devono appoggiarvisi. Le parole sono sporche quando non dicono quello che devono dire e ci girano intorno, quando fanno "la doppia faccia", le parole sporche sono ipocrite come chi le pronuncia e sporcano i concetti, le persone e l'esistenza.
L’esperienza sinestetica del linguaggio sprofonda nella dicotomia tra sporco e pulito, e a mano a mano che Paolo cresce le parole si sporcano sempre di più, vi si sedimentano associazioni mentali, intonazioni, intenzioni, voci sporche che le hanno pronunciate, e si deposita una patina opaca anche sullo sguardo che vede il mondo e che per vedere deve dare un nome alle cose e quel nome è usurato, sgualcito, sporco.
A sporcargli le parole è soprattutto la madre, la fonte originale della lingua, anche perché ha come controcanto il silenzio paterno. La lingua del padre si è spenta e lui è sprofondato in uno spazio senza nome, tra il mutismo e l’afasia, parla con gli occhi e le parole, per non perderle, le appiccica sugli oggetti, fissando i significanti al loro significato nei post-it sparsi per casa. Ma se il padre parlasse, sicuramente avrebbe parole pulite, Paolo ne è sicuro, e si sforza di cercare parole abbastanza limpide e incorrotte da tirarlo fuori da quel silenzio profondo.
Le parole in casa Prescher sono quelle della madre e della sorella, così simili agli occhi di Paolo e irrimediabilmente false; la lingua della madre è una lingua sporca perché Paolo la sente ipocrita, superficiale, opprimente. E falsa, ipocrita e opprimente sente anche Bolzano e il suo bilinguismo (o trilinguismo) che è una bugia e una trappola e confonde il concetto di lingua madre insieme a quello di identità. “A Bolzano tutto ha due nomi, a volte anche tre: uno in tedesco, uno in italiano e a volte, quando si deve, se proprio si deve, anche in ladino. Questo è un problema perché le parole hanno un potere metamorfico sulle cose”, così, se una qualsiasi strada in un qualsiasi altro posto è solo una strada, a Bolzano è anche Straße, e una delle montagne che soffocano la città, il Catinaccio, che è brutta e scura di giorno, quando risponde a quel nome pesante e gelato come il metallo, a una certa ora si trasforma, si accende della luce rosa del tramonto, diventa femmina e calda e prende il nome di Rosengarten, ma soltanto finché il sole non è sprofondato dietro le cime.
Il plurilinguismo altoatesino crea confusione nelle parole e, anche se a Paolo sembra una farsa, a Bolzano la lingua madre non si subisce come un destino, bisogna sceglierla.
Da piccolo Paolo chiede al suo unico amico, Jan, “sudtirolese di madrelingua tedesca”, come dice la madre sporcando ogni parola, di insegnargli il dialetto tedesco ma lui si rifiuta perché “il dialetto non si può imparare: è la lingua della famiglia, della tua gente”, e Paolo si ingelosisce, desiderando anche lui una Heimat, una lingua di famiglia, preferibilmente paterna.
Quando a diciott’anni decide di non fare la dichiarazione di identità linguistica si dice che lo fa per Jan, che da piccolo, quando gli si chiedeva se si sentisse italiano o tedesco, rispondeva sudtirolese, anzi europeo. Ma forse si rifiuta anche perché a insistere perché si dichiari è la madre, con le sue parole che insudiciano l’unica lingua che conosce e che potrebbe scegliere davvero, se non sentisse di potersi definire solo per negazioni, non italiano, non tedesco, non ladino...
Sua madre, sua sorella, Bolzano, il bilinguismo, la necessità di dichiarare un’appartenenza linguistica, tutto appare fasullo e l’ipocrisia che sente nelle parole si allarga e sconfina, diventa una cosa sola con luoghi, persone, voci, pensieri, ne restano fuori solo Jan e il padre Biagio, non intaccati dal sudiciume che sembra colare su ogni cosa.
Quando il padre muore, Paolo pensa che la ragione siano le parole sporche, la promessa mancata di trovarne di abbastanza pulite per salvarlo. Le voci della madre e della sorella suonano ancora più false, le parole sono irrimediabilmente lordate, l’unica parola vera, quella che dice la morte, il tradimento, l’abbandono, è troppo dura da pronunciare.
Paolo si strofina sotto la doccia per lavar via lo sporco delle parole, l’acqua è una parola pulita ma non riesce a lavare, le parole si affollano nella testa, dicono che è colpa sua, che è colpa loro, e che l’italiano è una lingua ormai viziata, troppo insozzata, ormai inutilizzabile e decide di non parlarla mai più.
Le uniche parole pulite sono ormai le parole nuove, come quelle greche o latine finché non si macchiano sulle labbra dei professori a scuola, o quelle tedesche, ancora intonse, libere da associazioni, scevre di passato, di intonazioni e di voci, parole di una lingua vergine, senza colpa, senza dolore.

Così decide di parlare tedesco e di trasferirsi a Berlino, dove trova lavoro in una biblioteca, una stanza in un appartamento condiviso e una città sterminata, senza le pareti soffocanti delle montagne e della lingua madre, e trova nuove parole, immacolate ed esatte, almeno per un po’. La sua parola preferita, Sollbruchstelle, “indica un punto di rottura prestabilito che può essere quello delle tavolette di cioccolata” e per lui significa confine, e poi c’è Unflat, che rende possibile il nominare, con una parola pulita, tutta la sporcizia che si sente addosso.
L’unica cosa brutta di Berlino è la solitudine: “anche a Bolzano non avevo amici e non parlavo praticamente con nessuno, ma finché c’era papà io non mi sentivo così. Forse era quella la mia Heimat, non sentirmi solo. Ora non ce l’ho più, la Heimat, e continuo a camminare a lungo per le grandi strade di Berlino che sanno di zucchero e pane caldo.”.
La solitudine si scioglie quando in biblioteca incontra Mira di Pienaglossa, che è italiana, ha lentiggini pulite e soprattutto ha pulite le parole.
Mira non lo giudica, sembra comprenderlo, lo ascolta e con naturalezza gli restituisce le parole di una lingua madre che si era perduta e ripulendosi le parole si ripuliscono i ricordi, i pensieri, i sentimenti e anche tutte le cose. Mira con la sua cadenza milanese, con lo slang giovanile, con i suoi amici artisti che vivono negli scantinati, sa di pulito; grazie a Mira di Pienaglossa, che ha nel nome l’anagramma e la vocazione del sapone di Marsiglia, tutto è filtrato da uno sguardo diverso, tutto torna immacolato e Paolo sente un vuoto nella pancia e la voglia di essere felice e lo chiama amore.
Mira ripulisce l’italiano e ne fa una lingua nuova e feconda e generatrice e dalla lingua pulita può nascere una nuova vita, in un mondo finalmente privo di macchie, Paolo riesce a immaginarsi padre.
La struttura del romanzo ricalca la geografia degli spostamenti di Paolo, da Bolzano a Berlino e poi di nuovo a Bolzano e ha a che fare con due movimenti, l’andare via e il ritornare, che hanno al centro il luogo d’origine, la lingua madre.
Con Mira e con la speranza di ritrovare tutto ripulito dal suo sguardo, Paolo può pensare di tornare a Bolzano. La città era sporcata dalla lingua madre, che come le etichette paterne ricopriva strade, monumenti, edifici e persone, Mira l’ha ripulita con la sua voce e le sue parole limpide e con una nuova idea di famiglia. E al ritorno tutto pare davvero diverso: è un nostos che ha la dolcezza del ritrovarsi nel luogo d’infanzia con una consapevolezza nuova: “mi guardo intorno e penso che quando sei piccolo vedi tutto più grande e poi quando da grande rivedi le stesse cose, non sono più così grandi, si sono come rimpicciolite. La stessa cosa succede con la città, che mi sembrava tanto brutta, allora, e invece adesso non è brutta per nulla, non è così sporca, anzi, non lo è affatto. Anche le parole di mia madre, ora, non sono più come erano allora. Anche loro si sono rimpicciolite, come mia madre. Forse è stato un problema solo mio, forse sono stato io il problema, mi sento in colpa e non voglio pensarci, così guardo Mira che mi sorride, come a dire: no, non è colpa tua, non è colpa di nessuno”.
Ripulita la lingua, sembra ripulirsi anche il concetto di madre, una madre che lo riaccoglie, lo abbraccia e adesso “sa di colori a olio e acquaragia e non è per niente male questo odore, ora sa di mamma ed è pure abbastanza pulita la parola, è abbastanza pulito l’odore, è pulita l’idea”.
Quello che succede dopo è una serie di inciampi, di piccole lacerazioni e delusioni, l’insinuarsi del dubbio, verso sé stessi e verso gli altri, è il sentirsi di nuovo solo, la paura insopportabile di sporcare con le proprie parole una vita innocente, è lo sgretolarsi dell’illusione di un’impossibile purezza delle parole, del pensiero e della vita, lo scontrarsi con un trauma irrisolto e con una colpa da scontare.
Lingua madre è un romanzo costruito intorno e sul linguaggio, è la lingua di Paolo che modula la trama ed evolve dalla voce del bambino a quella di adolescente, fino a quella di giovane uomo, una voce dal “piglio holdeniano”, come gli riconosce il verdetto del Premio Calvino e una scrittura in cui dalla sensibilità e dalla familiarità con le parole nascono giochi, riflessioni, manie, e che dimostra soprattutto una considerevole capacità di ascolto dei luoghi e delle loro voci.
Quella di Paolo per le parole è un’ossessione profonda, le raccoglie, le isola, ne accarezza la superficie, se le rigira in bocca, le scompone, ci si ripiega sopra, ci si incaglia, e la scrittura di Fingerle ne restituisce ogni conquista e ogni ferita e dà conto del corpo a corpo con una lingua che si rigenera continuamente ma sa essere anche veicolo di autodistruzione.
Paolo rinuncia alle parole della lingua madre, le recupera, le salva e poi, alla fine ne perde il controllo, si accatastano tutte una dopo l'altra, una sopra l'altra, insensate, una pioggia di parole sporche, e a nulla serve tentare di lavarle, strofinarsi fino a farsi male, le parole continuano a sporcarsi e a sporcare occhi, bocca, pelle, cuore.
Il finale del libro è nell’acqua, l’acqua che scorre nella doccia, quella che sale in una vasca, quella che piove senza sosta su una Bolzano silenziosa e vuota, dove si sente forte il rumore del fiume, un’acqua che non lava ma toglie la voce e diluisce le parole in un sacrificio che purifica senza salvare.