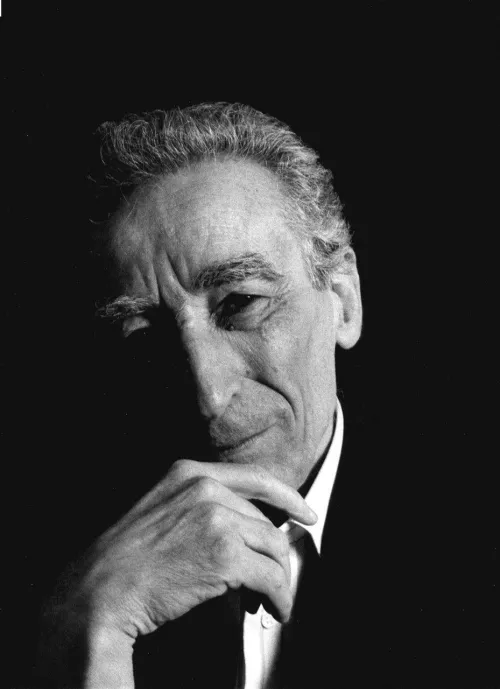Novant'anni / Franco Loi: Incontrare l’angelo
Ho conosciuto di persona Franco Loi all’inizio degli anni ‘80. La mia memoria è sempre molto vaga e imprecisa, e tende a ricostruire il passato in modo soggettivo, arbitrario; per un lungo periodo mi è piaciuto retrodatare l’incontro al decennio precedente, ma a un certo punto mi sono dovuto arrendere ai dati storici: quando Tommaso Leddi e io siamo andati a trovarlo nella sua casa di Via Sambuco, a Milano, lui aveva tra le mani la prima versione di L’angel, appena uscita da S. Marco dei Giustiniani. Dunque, era il 1981.
La mia retrodatazione, per quanto tendenziosa, non era però immotivata: in effetti, già negli anni ’70 avevo letto e ammirato i libri di Loi, da Stròlegh (1975) a Teater (1978). A indicarmeli era stato il padre di Tommaso, il pittore Piero Leddi, grande amico del poeta. Tommaso, mio compagno di avventure musicali (Stormy Six), aveva frequentato Franco fin da ragazzino, e lo considerava quasi un parente; quando gli parlai della mia ammirazione per la sua poesia, decise di farmelo conoscere.
Quell’incontro mi rimane in testa come una svolta nella mia vita e nella mia idea di poesia. I libri di Loi li conoscevo già, l’ho detto, ed ero in grado di leggerli anche nell’originale: non sono nato a Milano, ma quando ci sono arrivato (1954, avevo cinque anni) il dialetto si parlava ancora dappertutto. Passare dalle pagine al poeta in carne e ossa fu davvero emozionante, e per certi versi anche spiazzante. Già la scrittura di Loi aveva – rispetto alla produzione corrente – una notevole carica di alterità, ma quella dell’autore era, se possibile, ancora più dirompente.
I poeti che avevo incontrato di persona – Vittorio Sereni, Franco Fortini, altri ancora – conservavano, pur nel fermento delle loro personalità, un contegno che potremmo chiamare “borghese”; Loi sembrava uscito da un altro mondo; un mondo arcaico, in cui il poeta è una sorta di sciamano, ignaro delle convenzioni e dei rituali letterari. Nella mia testa, in quegli anni, la poesia era un esercizio estetico-letterario governato dall’intelligenza, dal gusto, dalla cultura, dall’ironia; l’intensità che la animava doveva restare entro i limiti di una certa sobrietà, di un certo distacco. In Loi, invece, l’entusiasmo non conosceva limiti. Loi era quietamente spiritato. Mi faceva pensare a certi personaggi di Dostoevskij. Il racconto che ci fece dell’ispirazione incontenibile da cui erano nati di colpo, tutti insieme, i suoi versi in milanese in un’estate di fine anni ‘60, della “mano calda” che sentiva sulla testa mentre componeva, dell’estasi che lo guidava, mi affascinava e mi imbarazzava al tempo stesso.
Quella sera, oltre a raccontarci la sua “iniziazione” mistica alla poesia, ci lesse di tutto, da brani dei saggi di Giacomo Noventa a De là del mur di Delio Tessa, da passi di L’angel a versi della Commedia, che scandiva e accompagnava con ammiccamenti arcani, come per farci intendere tutto il mistero che celavano (“Qui si convien lasciare ogni sospetto…”).
Qualcosa, in me, cercava di resistere all’incanto, ma qualcos’altro mi spingeva ad arrendermi, a guardare in faccia la Poesia che mi si rivolgeva maiuscola, senza pudore, senza freni, come non era mai avvenuto. Tommaso e io uscimmo dalla casa del poeta a tarda notte, affascinati e storditi.

È stato forse in quell’occasione che ho cominciato a riflettere sulla nozione di “canto”. Per me, fino allora, nemmeno la poesia – con tutto il suo prestigio e i suoi privilegi – poteva sottrarsi a un confronto dialettico, a un’obiezione critica, a una discussione. In Loi, invece, non c’era spazio per dubbi, ragionamenti, opinioni: lui cantava; e chi canta – come mi è capitato di scrivere più tardi – “è sordo, e sa tutto”.
In un primo momento sentivo in questo un arbitrio, quasi un’arroganza; ma in seguito mi è parso che questa “esposizione” impudica contenesse un dono, un’offerta, una bruciante inermità che la poesia moderna si sforzava (invano) di rimuovere.
L’incontro con Loi mi indicò la strada che portava dai rituali di quello che si chiama letteratura (sia pure in versi) ai rischi della poesia, mi incoraggiò ad abbandonare i vezzi, le ambizioni e le inibizioni estetiche e culturali per cercare quella che poi avrei chiamato voce. Sui libri di Loi – letti e riletti – ho a lungo meditato e ne ho anche scritto (ricordo in particolare una introduzione a Stròlegh per la rivista “Poesia”).
Intanto avevamo preso a frequentarci, insieme ad altri poeti in dialetto come Raffaello Baldini e Giancarlo Consonni: con la poesia in dialetto sentivo una istintiva affinità. Loi leggeva le cose che andavo scrivendo nei primi anni ’80; mi incoraggiava, mi criticava, mi trattava come un discepolo e come un amico.
Più tardi, negli anni ‘90, Tommaso Leddi (ancora lui!) mi chiese di ascoltare un paio di canzoni che stava scrivendo sui testi di Franco. La sua idea era di proporle a Moni Ovadia, ma prima voleva sentire come funzionavano: dovevo provare a cantarle. L’esperimento andò talmente bene che alla fine, da quello di “collaudatore”, mi ritrovai nel ruolo di interprete. Tommaso conosce benissimo le mie caratteristiche vocali, e forse non era consapevole, scrivendo quei pezzi, che la voce che aveva in mente era in realtà la mia. Fatto sta che a quelle prime canzoni (bellissime: posso dirlo, dato che non sono l’autore) ne seguirono altre, tutte pensate per chitarra e voce, tutte basate su testi di Loi che Tommaso e io scegliemmo tra quelli che ci sembravano più adatti a essere messi in musica. Il risultato è Vòltess (mai pubblicato in disco, purtroppo). Ricordo con che timore andammo a casa di Franco, in viale Misurata, per fargli ascoltare il nostro lavoro: è raro, lo sapevamo bene, che un autore gradisca versioni musicali di quello che ha scritto. Invece, Loi ne fu entusiasta. Da allora, e per molti anni, cominciammo a cantare in pubblico le canzoni di Vòltess, in molte occasioni alternandole a letture del poeta stesso. Nel milanese di Loi abbiamo cantato persino a New York, a Palermo, a Comiso.
Questa esperienza è stata per me un modo straordinario per penetrare in quei versi che ammiravo: dar loro voce e fiato, averli in bocca, me li faceva comprendere per così dire “da dentro”, mi costringeva a riviverli, quasi a ricrearli. Credo che pochi lettori abbiano avuto un’occasione tanto preziosa per accedere direttamente agli angoli più segreti dell’opera di un grande poeta.
Questo testo è comparso su "A Franco Loi, per i suoi novant'anni", numero monografico della rivista "Cenobio", IV/2019, a cura di Paolo Senna e Massimiliano Mandorlo.