
L'ultima conversazione / Giacometti. Preferisco le sculture dei pittori
Lunedì 22 marzo 1965
– Il futuro è piuttosto chiuso... Mi chiedo per quanto tempo potrò ancora fare della scultura... Uno, due anni, sei mesi?... Sono in un vicolo cieco. Non so veramente come ne uscirò... Dall’ultima volta che ci siamo visti, sono stato operato. Mi hanno tagliuzzato per quattro ore e mezza. Mi hanno tolto tutto lo stomaco... Me ne resta solo un pezzetto... Pare che basti...
Trovo un Alberto Giacometti dimagrito, curvo, fluttuante nei suoi vecchi vestiti, il volto sempre più scolpito, rilavorato dalla sofferenza. Tuttavia la luce che brilla nei suoi occhi arrossati dall’insonnia è intatta e la sua voce è rimasta altrettanto seducente, sicura, calda.
Giacometti parla con vivacità. Dimagrito, la sua somiglianza con Cocteau diventa ancora più flagrante. Questa somiglianza l’ha prima divertito molto, poi infastidito. Ma le lunghe mani di Alberto sono più solide, la sua testa più robusta e come tagliata con l’accetta, le sue spalle più forti e i suoi capelli, ribelli come quelli di Cocteau, non si rizzano a spatola, ma brulicano come i mille serpenti di Medusa. È un Cocteau incrociato con un paesano del cantone dei Grigioni che mi parla rapidamente, ma si regge appena in piedi, si aggrappa con le braccia a un cavalletto come un naufrago.
– Brassaï, fotografami così... Questa posa corrisponde esattamente al mio stato fisico... Sono stanco, sfinito. Sono uno straccio, un relitto. E malgrado tutto, vedi, lavoro, continuo il mio lavoro... Ieri sera sono rimasto fino a mezzanotte ad accanirmi su questo busto che ancora devo a Maeght, poi ho fatto un giro alla Coupole. Rientrando, alle tre del mattino, invece di andare a letto ho continuato a modellare fino alle sette... Ho dormito appena... Ed ero così impaziente di riprendere questo busto che non ho neanche bevuto un caffè...
È stato nel 1932 che sono venuto per la prima volta da Giacometti, in questa stessa catapecchia buia, sporca e umida, dove si annida il suo atelier, al 46 di Rue Hippolyte-Maindron, nel quattordicesimo, tra la Rue du Moulin-Vert e la Rue d’Alésia; un angolo di Parigi dove case, viuzze, recinti di vigne vergini conservano ancora il fascino vecchiotto alla Utrillo. Ma, come una minaccia di morte, si erge già un fabbricato bianco, nuovo fiammante, proprio accanto a questo tugurio di ateliers di Alberto. A destra del piccolo e lugubre cortile c’è il regno dello scultore, a sinistra quello di suo fratello, il suo migliore amico, il suo factotum, il suo modello da sempre. È di Diego che Giacometti fece il suo primissimo busto all’età di quattordici anni. Bisogna risalire a Theo e Vincent Van Gogh per ritrovare un’amicizia tra due fratelli come quella che lega Alberto e Diego. In quel periodo, volente o nolente, Giacometti divenne lo scultore accreditato del gruppo surrealista.
Nel 1929, quando espose alla galleria Pierre i suoi oggetti-sculture in legno, pietra e gesso – entità plastiche nate dal sogno e dall’automatismo – i surrealisti lo salutarono con entusiasmo e lo incorporarono nel movimento. Ricordo un articolo ditirambico di Salvator Dalì su «La Révolution surréaliste»; quanto a André Breton, considera quelle sculture «a funzionamento simbolico» come i primi «oggetti surrealisti». Mentre fotografavo la famosa Boule suspendue o il Palais à quatre heures de l’amprès-midi, ora al Museo d’Arte Moderna di New York, Alberto mi spiegava che tutti quegli oggetti gli si erano presentati alla mente pressoché definiti, che li aveva eseguiti senza neppure cercarne il significato e che il loro senso gli si rivelò solo dopo. Così, mi confidava, questo palazzo fragile che nasconde una spina dorsale di legno, uno scheletro d’uccello, una bambola e una palla fissata su un piatto ovale, era la reminiscenza di un amore recente... E poi bruscamente, verso il 1935, dopo aver portato non poca acqua al mulino surrealista, Giacometti si staccò dal gruppo.
– Tra i surrealisti e me, mi disse, c’è stato un malinteso. Hanno considerato le mie sculture come un punto di arrivo; ora, per me, esse erano solo un momento di passaggio... Mi trovavo in un vicolo cieco. La nostra collaborazione è durata circa sei anni. Ma non ho più partecipato alle loro ultime esposizioni di prima della guerra...
Cos’era successo? Giacometti scoprì all’improvviso questa verità banale che la grande questione della scultura è sempre stata la rappresentazione della figura umana, immobile o in movimento, la vita del corpo nello spazio. Scoprì anche il principio più convenzionale delle belle arti, quello dell’imitazione. Non voleva più creare deliberatamente, spontaneamente, ma ricreare, riprodurre la vita. In verità, ci provava già quando lavorava con Germaine Richier alla Grande-Chaumière, nell’atelier di Bourdelle, ma senza successo. Più si applicava, meno la sua opera lo soddisfaceva. Stanco di distruggere le sue sculture, si chiese: «Ma dove sta dunque la somiglianza? Dov’è la verità, visto che la copia più fedele ce ne allontana?». Ed è per disperazione nell’impotenza di rappresentare la figura umana in modo adeguato, che arrivò a concepire opere plastiche a memoria. In ogni nostro incontro, come una monomania, poneva le stesse domande:
– Come riprodurre una cosa, creare un’immagine, un’apparenza dell’oggetto rappresentato? Come rendergli giustizia? Come cogliere la somiglianza? Non trovi che sia un compito impossibile in un universo dove tutto è unico, inimitabile?
Così riprendeva sempre lo stesso modello, Diego, o sua moglie, Annette, che ha sposato nel 1949, o il fotografo e cineasta Elie Lotar, che posa per lui da un anno a questa parte. Venne alle mani con la realtà, riprese tutto il problema plastico da zero. Si gettò nella rissa con accanimento, in uno stato di intensa eccitazione: «Si può passare tutta la vita senza arrivare a un risultato soddisfacente», amava ripetere. E impiegò sette o otto anni prima di esporre una scultura di cui non era troppo scontento. Ogni opera che usciva dalle sue mani era solo una semplice tappa della sua incertezza e insoddisfazione.
Ricordo il suo atelier intorno al 1940, quando i busti, come in seguito a una rivoluzione climatica o geologica, cominciavano a rimpicciolirsi fino a ridursi a teste di spillo. Poi, all’improvviso, divennero piccole figurine che si slanciavano come piante intristite che cercano la luce tastoni. In quel periodo si camminava su una montagnetta di resti di gesso, un’ecatombe di figure condannate e distrutte in una specie di rabbia.
«Dovrei forse fermarmi...», diceva Alberto dopo una notte di sterile battaglia, capelli cosparsi di gesso, bianco dalla testa ai piedi, mani pietrificate, o meglio: «Forse la prossima ci riuscirò...», quando era di umore meno massacrante. La gloria, la consacrazione dei maggiori musei, l’ammirazione degli amici non bastavano ad accontentare questo eterno insoddisfatto nella «sua corsa alla somiglianza». Ed è da testimone sorpreso e meravigliato più che da autore delle sue metamorfosi degne di Alice nel paese delle meraviglie che parlava del brutto colpo che gli giocava senza sosta il demone della somiglianza.

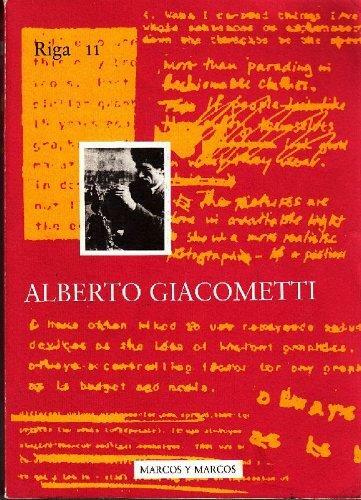
«Riga», a cura di Marco Belpoliti e Elio Grazioli
– Si pensa che io riduca le teste o che allunghi le mie figure di proposito. Le riduco o le allungo per rimanere fedele al modello, per cogliere la somiglianza. La testa è solo una piccola palla; il corpo non è che un lungo bastone. È sotto questa forma che mi appare la figura umana nello spazio. Ho capito veramente la grandezza dell’arte primitiva soltanto proseguendo le mie ricerche... Trovo che certi feticci dell’Oceania o dell’Africa abbiano molta più verità, siano molto più vicini a quanto cerchiamo di una scultura di Michelangelo o di Donatello o di un altro scultore dell’arte tradizionale dell’Occidente. Cosa curiosa del resto, io nella scultura moderna preferisco non le sculture degli scultori ma quelle dei pittori, di Picasso, di Matisse...
E io penso ad Alberto stesso. Così amabile, così semplice. Potrebbe viaggiare in Rolls, ricevere gli amici in un palazzo o un castello. No, è rimasto fedele alle sue abitudini, al suo vecchio quartiere, al suo sordido tugurio, indifferente perfino alla comodità. Il successo non ha cambiato di uno iota la semplicità quasi monacale del suo genere di vita. Una zolla di argilla a portata di mano, un po’ di gesso, qualche tela e fogli di carta bastano alla sua felicità. Nessuna traccia, nessun odore di denaro qui; un divano usato, dei tavoli, sgabelli e, al soffitto, la stessa lampadina nuda e cruda da quarant’anni, unica luce, forse, in questo isolato che di solito si spegne solo all’alba...
Pubblicato in «Le Figaro Littéraire», 20 janvier 1966. Poi in «Riga» 11, a cura di Marco Belpoliti e Elio Grazioli, Marcos y Marcos. Traduzione di Elio Grazioli.









