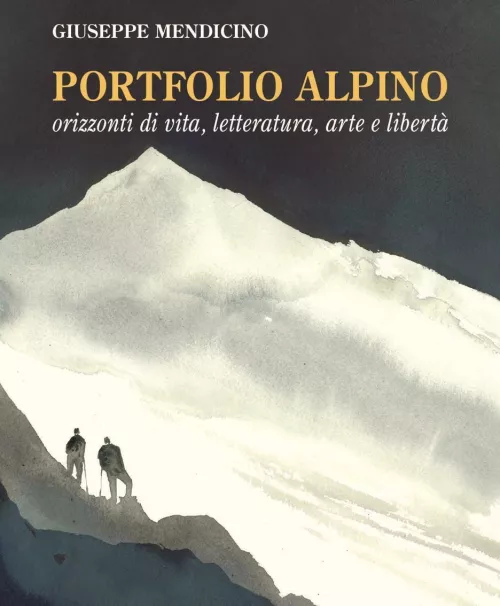Orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà / Giuseppe Mendicino, Portfolio alpino
La superficie dell’Italia è per più di un terzo montuosa, eppure di romanzi e racconti che parlano della montagna non ce ne sono molti: città, campagna, mare sì, ma, a mia conoscenza, sulla montagna i libri che non siano di settore o guide, a parte quelli di guerra, soprattutto partigiana, sono davvero pochi, nonostante un certo risveglio recente anche in seguito al grande successo di Le otto montagne di Paolo Cognetti (Einaudi, 2016). È un altro modo di disertarla, mi sembra, come avviene da molti decenni per i pascoli, le malghe e i borghi, solo in parte compensato, spesso sommando danno a danno, dalle seconde case e dal turismo. E se talvolta nella narrativa si parla di montagne sono perlopiù incantate, mitiche, generiche, o viste come metafore e altra paccottiglia retorica; raramente sono presenti come concreto mondo specifico e rappresentate nel loro dettaglio paesistico, culturale e, per chi ci vive, esistenziale. Eppure uno dei testi fondativi della nostra letteratura in cui il mondo geografico e paesistico, fatte salve le inevitabili implicazioni simboliche del tempo, irrompe con tutta la sua forza è la narrazione di un’ascesa, quella del Monte Ventoso da parte del Petrarca. Può darsi però che a farmi parlare così sia solo la mia ignoranza sull’argomento, sterminata. Per fortuna ora, a suo parziale rimedio, è arrivata la lettura del più recente libro di Giuseppe Mendicino, Portfolio alpino. Orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà (Priuli & Verlucca, 2018, p. 224, E. 16,90), che ringrazio non solo per ciò che ha scritto ma anche per tutti le suggestioni che fornisce per continuare l’opera di riduzione delle mie lacune.
Mendicino ha riunito in questo bel volume una ventina di ritratti di uomini e donne, soprattutto scrittori, filtrati dal loro rapporto con la montagna, e proprio questo ha innescato la mia curiosità: il desiderio di conoscere qualcosa di più su autori già noti, sotto un aspetto come la montagna che non sempre viene trattato in modo approfondito quando si parla di loro. Questo mi ha poi portato a conoscere tutta una serie di “scrittori di montagna” che costituiscono quasi un piccolo universo a parte dove, accanto a quelli consacrati dal canone ufficiale, brillano figure note quasi solo agli specialisti, ma memorabili; vite spezzate, eppure anche così compiute e piene, perfette; imprese grandi e piccole; eroismi silenziosi e circoscritti, e nondimeno sempre grandiosi, come anche il minore degli eroismi, il più solitario e inosservato, sempre è; episodi di struggente commozione, indimenticabili, come quello che vide protagonista Amilcare Crétier e altri alpinisti che vegliarono per tutta una notte due compagni agonizzanti nel fondo di un crepaccio senza poterli soccorrere (p. 44).

A libro chiuso si scopre però che non sono tanto le persone ritratte a essere i veri protagonisti del libro, bensì la montagna. Non è la montagna, cioè, a costituire l’occasione per un ritratto degli scrittori e artisti, ma sono questi a illuminare ciascuno un aspetto diverso di essa, a edificarle un altare che provi a stare alla pari con la sua grandezza. Non a usarla cioè come sfondo o occasione di una storia, ma a rispondere alla sua sfida, a scalarla e conoscerla anche con le parole, pur sapendo che, come accade anche quando si raggiunge la sua vetta fisica, essa resterà sempre inattingibile. Sotto di noi, massiccia, solida, eppure trascendente.
Gli autori di cui Mendicino scrive appartengono per la maggior parte alla generazione nata nel primo quarto del secolo scorso, gente che era ancora giovane durante il II conflitto mondiale, alcuni che sarebbero rimasti tali per sempre. E altri che, sopravvissuti, per sempre ne sarebbero stati segnati. Reduci, prigionieri, partigiani; pochi scampati, tutti gli altri morti, se non in guerra, poco dopo. Impressionante per esempio è l’elenco di morti, in Russia o in seguito alle bastonate dei nazisti o durante la Resistenza (p. 153), del gruppo di guide alpine, maestri di sci già selezionati nel 1936 per le Olimpiadi di Garmisch e giovani allievi, che parteciparono a un campo di addestramento in Val Fornazza, tra il dicembre del 1938 e il gennaio del 1939, assieme a Mario Rigoni Stern, che ne ha raccontato le vicende nello splendido L’ultima partita a carte (Einaudi, 2002).
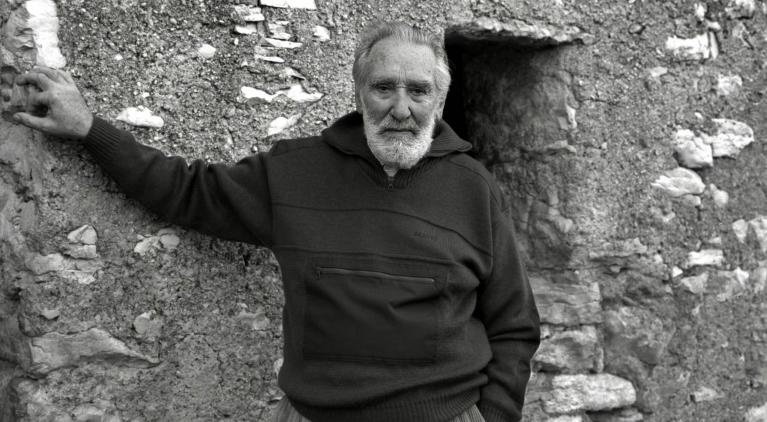
Accanto quindi ai vari Hemingway, Buzzati, e ai prediletti Rigoni Stern (a cui Mendicino ha dedicato molti lavori e curatele, come quella degli scritti inediti Dentro la memoria, Domus 2007, nella collana Meridiani montagne, dove ha curato anche Montagnes valdôtanes di Massimo Mila), e Nuto Revelli e Primo Levi, il lettore non specialista impara a conoscere figure come Dante Livio Bianco, Renato Chabod, Enrico Castiglioni, Giovanna Zangrandi e Tina Merlin, tra gli altri. Gli unici appartenenti alle ultime generazioni sono Giovanni Cenacchi e Paolo Cognetti, a cui Mendicino, come con altri, è stato ed è legato da affinità e amicizia. Direi anzi che proprio questo, assieme a quello etico su cui tornerò dopo, è il filo conduttore di questi testi.
Molti sono i tratti che accomunano queste figure, tanto che, a parte le peculiarità individuali che potevano andare dall’occasionale spavalderia alla malinconia, si potrebbe provare a delineare una figura tipo che risponde più a una tensione utopica che a una forma archetipa, che Mendicino intende trasmettere come modello di comportamento anche civile e politico al lettore, in controtendenza rispetto alle immagini pubbliche odierne, perché in questi “tempi oscuri, minati dall’intolleranza, dalla paura per il presente e per il futuro, (…) abbiamo bisogno di eroi salvifici, e anche di essere, ognuno di noi, salvifico per qualcuno” (p. 196).
“Occorre coraggio, ma è necessaria anche la paura (…) Volontà, coraggio, prudenza, paura. Quattro fattori primi dell’alpinismo”, scrive uno dei tanti morti giovani, Amilcare Crétier, che “non aveva ancora compiuto 24 anni, e aveva già aperto più di cinquanta nuove vie sulle Alpi Occidentali” (p. 43 e 45). A questi tratti potrebbero aggiungersi quelli con cui Massimo Mila descrive il suo amico Dante Livio Bianco: “Anzitutto la modestia … Inoltre la serietà, la quadratezza, la solidità” (p. 50). Tutti elementi che confluiscono in quello spirito fondamentale di indipendenza e di amore per la libertà che condurrà molti di loro, in seguito all’8 settembre o già prima, a scegliere la via della Resistenza, come appunto Bianco che sarà capo partigiano, per poi tornare alla sua professione dopo la sconfitta del Partito d’azione alle elezioni del ’46. O come Ettore Castiglioni, uno dei grandi alpinisti italiani, che “aprì oltre duecento vie sulle Alpi” (p. 31), morto nel 1944, a 36 anni, mentre cercava di fuggire da un albergo svizzero dove era sorvegliato prima di essere portato in prigione, e che già nel 1935 aveva scritto nei suoi diari: “… il vero alpinista non può essere fascista, perché le due manifestazioni sono antitetiche nella loro più profonda essenza. L’alpinismo è libertà, è orgoglio ed esaltazione del proprio essere, del proprio io come individuo sovrano (…): il fascismo è ubbidienza, è disciplina, è annullamento della propria individualità (…) sottomissione”.

Si tratta in genere di gente solitaria, ma che sa stringere forti amicizie, che siano quelle del compagno di scalata o altre, per affinità di sentire, che durano una vita al di là delle rare occasioni di frequentazione. Gente sola, e che, pur essendone talvolta oppressa, ama la propria solitudine; che la ama sia quando è davvero sola, sia quando è condivisa, perché anche i compagni partecipano del medesimo sentire. Come Primo Levi, che era “un uomo allo stesso tempo solitario e socievole, [e] solo nelle sue montagne riusciva a essere del tutto sereno” (p. 134-5). La montagna non ama la folla. Se qualche piccola comunità favorisce, o tollera, è quella di individui che tendono a separarsi anche nel momento in cui avvertono la più intensa fusione. Si sale sempre da soli. La fatica uno la porta su di sé, in solitaria o in cordata che sia. È, col silenzio, la compagnia più fedele.
Nonostante questa propensione alla solitudine, o forse proprio in sua ragione, sono tutte persone che sentono la responsabilità nei confronti di chiunque le accompagni o le scelga come guide; che vivono la responsabilità momento dopo momento, perché è da loro che le vite di altri uomini possono dipendere, in pace come in guerra, in una cura costante che è anche cura e rispetto della montagna, a rischio a volte di perdere la propria, di vita, come è accaduto a molti di loro.
Quasi tutti manifestano, in ogni caso, un più o meno spiccato “pudore delle emozioni” (64). L’immenso esige riserbo.
Lo stesso riserbo con cui scrive Mendicino, con la sua lingua nitida, diretta (di Ettore Castiglioni, a p. 32, scrive, con parole che valgono per lui stesso: “elegante nelle descrizioni, preciso nei temi e nelle valutazioni tecniche, sobrio nel riportare le emozioni”), che trapassa in modo impercettibile a tonalità delicatamente liriche dove proprio non è possibile farne a meno, pena la chiarezza e la coerenza del discorso, e che viceversa non si lascia sfuggire nessuno spunto morale e civile che la materia, le figure raccontate, e la montagna stessa, non mancano di suggerire, e quasi di imporre. Come se non fosse possibile disgiungerli, perché montagna e libertà e responsabilità non possono che andare insieme. Vite di uomini “famosi” più nel senso di James Agee che in quello della pubblica esibizione. Monumenti di un territorio poco frequentato, ma che, appena vi penetri, abbagliano proprio per la loro discrezione.
“Sognatori, libertari, uomini ansiosi di dare un senso alle loro esistenze, di non lasciar scorrere il tempo senza inciderlo con atti di umanità e di generosità”, come scrive Mendicino di Amedeo di Savoia e Gary Hemming, qui trattati solo con brevissimi ritratti all’interno di quello di Mirella Tenderlini, l’ultima delle tre donne a cui è dedicato un capitolo a sé. La prima è Giovanna Zangrandi, pseudonimo di Alma Bevilacqua, staffetta partigiana e poi scrittrice, e la seconda, su cui vorrei chiudere, è Tina Merlin, che per prima parlò dei disastri ambientali causati dalla costruzione delle dighe specialmente nel secondo dopoguerra, negli anni in cui opporsi era marchiato come un rifiuto del progresso, con discorsi che non sembrano cambiati di una virgola sessant’anni dopo, e che non si stancò di denunciare i pericoli di quella del Vajont, non solo inascoltata ma anche denunciata e condannata per calunnia, che viene spontaneo ricordare a maggior ragione in questi giorni dopo i disastri recenti anch’essi dovuti a speculazione e incuria, e in particolare oggi che termino di scrivere questo articolo, che per puro caso è il 55° anniversario di quel 9 ottobre 1963 in cui l’Italia si trovò di fronte al disastro da lei annunciato del Vajont e che io invece ricordo, perché così vanno le cose, come un giorno in cui, dodicenne, tra tutte le facce tristissime che mi trovavo attorno ero l’unico ad averla felice, perché in quegli stessi momenti nasceva mio fratello Giovanni.
Giuseppe Mendicino, Portfolio alpino. Orizzonti di vita, letteratura, arte e libertà, Priuli & Verlucca, 2018, p. 224, E. 16,90.