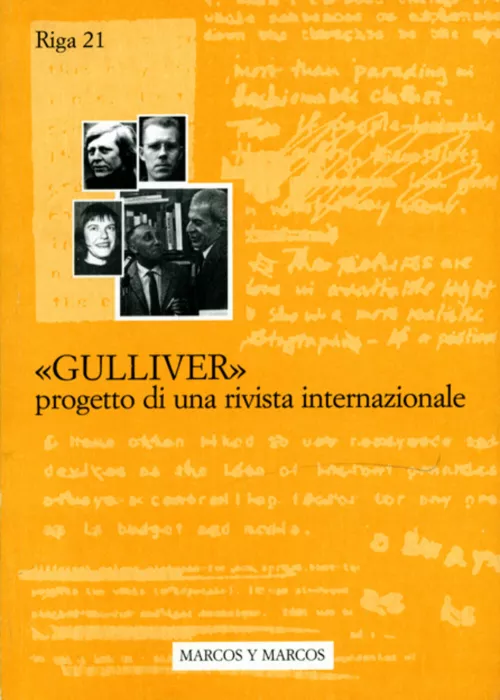Gulliver
Riga, una collana che avvicina ai grandi innovatori del Novecento
Riga è nata nel luglio del 1991 senza nessun particolare programma. Volevamo piuttosto fare la rivista «che ci sarebbe piaciuto leggere». Una rivista dedicata al contemporaneo, ad autori e temi che ci sembravano rilevanti nel corso dell’ultimo secolo, ma non solo. Una rivista che conservasse la memoria del passato, e insieme che si protendesse sul futuro.
Marco Belpoliti, Elio Grazioli
È probabile che «Gulliver», la rivista internazionale immaginata alla fine degli anni Cinquanta da tre gruppi di scrittori appartenenti a tre diverse nazioni, sia l’unica rivista europea del secondo dopoguerra. Certo, di riviste europee ce ne sono state più di una, ma sempre realizzate da una redazione ben radicata in uno dei paesi del vecchio continente e sempre con collaboratori stranieri; tutte riviste che si proponevano, e spesso avevano, un respiro sopranazionale. Ma una rivista interamente progettata, scritta e redatta da una redazione francese, una italiana e una tedesca, non c’è mai stata. Per questo «Gulliver» va visto come un punto decisivo, persino di svolta, della cultura europea del XX secolo. Questo anche se la rivista progettata nel corso di cinque anni non è mai nata; o forse proprio per questo.
Alla fine degli anni Cinquanta va in crisi l’idea dell’engagement. Esaurita la spinta innovativa del dopoguerra, prima in Francia, con gli avvenimenti legati all’Algeria, poi in Italia, con l’invasione sovietica dell’Ungheria e l’uscita dal Partito comunista di un numero nutrito di intellettuali e scrittori, inizia una sorta di ritorno alla letteratura che ha nei tre paesi – Francia, Germania, Italia – un significato molto diverso. La Francia non conosce il rapporto privilegiato che in Italia gli intellettuali hanno avuto, dall’epoca della Resistenza, con il Partito comunista; la situazione francese è molto più complessa e variegata, anche per l’esistenza di un’ampia e solida cultura di destra, per la presenza di figure intellettuali non allineate nell’ambito della sinistra, per un conflitto tra potere politico e intellettuali che dura almeno dall’epoca dell’illuminismo, tanto da fare degli intellettuali francesi una realtà rilevante nelle vicende politiche del paese. Da Voltaire a Sartre, l’intellettuale, lo scrittore, ha in Francia uno statuto particolare.
Diversa è la situazione italiana, dove invece, a partire dalla caduta del fascismo, gli scrittori e gli intellettuali hanno trovato nella sinistra di estrazione marxista e nello storicismo un punto di riferimento essenziale. Per quanto lo slancio vitale della Resistenza, l’ipotesi di un rapido e sostanziale cambiamento della realtà sociale e politica dell’Italia sia terminato già nel 1955, in Italia gli scrittori – o almeno molti di loro – si misurano con la politica e con la visione strategica del Partito comunista. Ancora diversa la realtà tedesca, dove una giovane generazione di scrittori tedeschi è emersa dalla tabula ras della fine del nazismo e della sconfitta militare, e si misura, in quel 1959 (data di uscita di due importanti romanzi del dopoguerra: Il tamburo di latta di Günter Grass e Congetture su Jacob di Uwe Johnson) con i problemi di un difficile dopoguerra su cui gravano i sensi di colpa, le promesse per il futuro, ma anche il bisogno di fare i conti con la propria storia passata.
È in questo quadro assai complesso che va letto il tentativo di realizzare «Gulliver», una realtà culturale che si situa tra la fine dell’impegno politico diretto degli intellettuali e degli scrittori, la necessità di elaborare una nuova letteratura al di là del realismo borghese o del neorealismo, e la nascita di una cultura critica – della “critica totale” come la chiama Maurice Blanchot nel suo testo preparatorio – che poterà poi, alla fine di quel decennio alla nascita dei nuovi movimenti, di un nuovo ciclo di lotte sociali e politiche che vanno sotto il nome di Sessantotto. In questo breve, ma non troppo, interstizio temporale, si situa uno dei tentativi più ambiziosi di riprendere il filo di un lavoro letterario e culturale che darà i suoi differenti frutti un decennio dopo.
La prima questione, su cui occorre soffermarsi, è l’idea di una rivista internazionale, che va al di là dei confini nazionali, ma in una certa misura anche della carta politica dell’Europa del periodo, dato che gli ideatori pensano al coinvolgimento di paesi e culture che si trovano in quel momento al di là della “cortina di ferro”, nella zona di influenza sovietica, ad esempio la Polonia. Ma c’è anche chi, tra i promotori della rivista, progetta l’esistenza di una redazione inglese e persino a un nucleo latinoamericano. Ma è ben presto sulla terna Francia-Italia-Germania che si fonda il tentativo di una rivista letteraria.
Dionys Mascolo, redattore di Gallimard, amico stretto di Vittorini, scrive a Iris Murdoch, scrittrice inglese, che loro, il gruppo francese, ma non solo, pensano a una rivista non fatta da giornalisti o da professori universitari, ma da scrittori, cioè da persone che hanno ben chiaro che la letteratura “costituisce un’esperienza fondamentale che mette in causa tutto, compresa essa stessa, irriducibile a qualsiasi altra cosa” (luglio 1961). Si tratta di idee che Maurice Blanchot, il membro francese più coinvolto nell’ipotesi di rivista internazionale, rende esplicite in un testo preparatorio. In questo scritto, in cui sono contenute in nuce le posizioni che egli svilupperà negli anni successivi in una serie di libir, Blanchot sottolinea con forza l’idea del collettivo e la necessità del tentativo in corso.
Nello scritto, che apre la sezione “Testi preliminari 1961-1962” è evidente il radicalismo del gruppo francese, composto da Roland Barthes, Louis-René des Forêts, Michel Butor, Michel Leiris, Maurice Nadeau. Blanchot mette subito in chiaro che “quando scriviamo non lo facciamo per arricchire la cultura generale”, ma per una tripla esigenza di verità, giustizia e linguaggio. In particolare questo del linguaggio è un aspetto su cui il critico e scrittore ritornerà più volte: “l’affermazione letteraria è essenziale, proprio in virtù della centralità del suo interesse per il linguaggio”. In questo stesso scritto Blanchot enuncia quelle che sono le ragioni del progetto di una rivista internazionale ed europea.
A suo parere una rivista nasce per tre ragioni: 1. come espressione di una dottrina già costituita ed emanazione di un gruppo (è il caso del surrealismo); 2. come volontà di dar forma a tendenze ancora vaghe ma già latenti (è il caso della maggior parte delle riviste di piccoli gruppi); 3. come “opera creatrice collettiva di superamento delle esigenze orientate”. La rivista non può essere che questo: un cammino dove chi accetta di entrare si troverà un po’ diverso da quello che era, un luogo dove ci si trova a “rispondere di un sapere che, da sé, all’inizio non sapeva”. Si tratta di un’idea di rivista che presuppone qualcosa di più che il puro incontro di individualità ben precise; anzi, la rivista a cui Blanchot pensa è il superamento dell’idea stessa di autore, è una “possibilità collettiva” che egli situa in un punto intermedio tra autore e lettore.
Il radicalismo letterario di Blanchot è evidente: facendo questa rivista ciascuno dovrebbe rinunciare “a un diritto esclusivo di proprietà e di valutazione dei propri problemi, il riconoscimento dell’appartenenza di questi anche ad altri e l’accettazione di configurarli in una prospettiva comune”. Blanchot – e si parla qui di lui, perché estensore di questo testo, ma si può immaginare che la posizione sia condivisa anche dagli altri redattori francesi – dichiara di essersi messo alla spalle il marxismo, di volgere l’attenzione verso una critica che per lui è prima di tutto “esperienza fondamentale, che tutto mette in causa, compreso se stessa e la dialettica”.
C’è in questa posizione una doppia eredità: quella di Sartre, ma anche quella di Bataille e del suo Collège de Sociologie, entrambi superati, nella visione di Blanchot, nella direzione di una idea di letteratura che riassume in sé quella doppia radicalità: verso la società e verso se stessi. Lo scrittore ha la facoltà e necessità di “dire il mondo”, “tutto ciò che accade nel mondo” ma con la responsabilità che gli deriva da essere uno scrittore: l’unica verità è quella della scrittura.
Ci si sofferma su questo documento, perché non solo esemplifica in modo efficace la posizione del gruppo francese, che è quello che ha più elaborato un proprio progetto di rivista e di scrittura, ma perché, per antitesi, diventano chiare le diverse posizioni del gruppo italiano e tedesco. Il punto su cui si concentra il dissidio, presto esploso tra francesi e tedeschi, è già compreso nel testo introduttivo redatto da Blanchot in vista dei primi incontri collettivi: l’idea di forma breve.
Per “forma breve” egli non intende l’aforisma, la poesia o la prosa breve, bensì il frammento che “non esaurisce necessariamente tutto il suo senso in se stesso, ma si apre su un senso più generale ancora a venire, o meglio, accoglie l’istanza di una discontinuità essenziale”. Blanchot sta elaborando le proprie idee sulla letteratura che rinviano a due filosofi tedeschi: Nietzsche e Heidegger; ma cita anche Aby Warburg, allora ancora poco conosciuto nel paesaggio intellettuale europeo, e la sua idea di “dettaglio”. La sua insistenza sul tema del linguaggio riguarda questa area culturale tedesca, certamente non condivisa dai giovani scrittori tedeschi, usciti dal disastro del nazismo e della guerra, e tutti intenti a fare invece i conti, in modo differente, con la Storia.
Nella cultura letteraria, poetica e filosofica del gruppo francese già agisce l’eredità delle letture hegeliane di Kojève, l’idea di vivere in una situazione di post-storia che circola con forza non solo nelle opere di Georges Bataille, ma anche nei romanzi di Raymond Queneau. Blanchot guarda alla musica di Boulez, allo strutturalismo di Lévi-Strauss, ma si interessa anche del romanzo poliziesco e vuole esplorare la destalinizzazione dal punto di vista del linguaggio, e il mito dell’eroe ignoto. Non dimentichiamoci che mentre Blanchot discute di «Gulliver» con il gruppo italiano, composta da Vittorini, Calvino, Leonetti, ma anche Moravia e Pasolini, in Italia sta per debuttare la neoavanguardia del Gruppo 63, composta quasi tutta da scrittori, saggisti, critici, poeti nati negli anni Trenta del Novecento, cioè più giovani del gruppo italiano di almeno dieci anni, se non di più. Così come ritroveremo alcuni dei membri del gruppo tedesco – composto da Hans Magnus Enzensberger, Uwe Johnson, Martin Walzer, Ingerbogr Bachmann, Günter Grass – nel ruolo di interlocutori del Gruppo 63. L’intreccio tra questi avvenimenti letterari e culturali è stretto e intricato, e a volte segnato dalle relazioni e interferenze tra singole personalità.
Al testo di Blanchot sembra rispondere quello di Enzensberger, in quel momento il più autorevole dei membri del gruppo tedesco, quello più impegnato, almeno nella prima fase, nella costruzione della rivista internazionale. Pur nella diversità degli intenti – il testo presentato da Enzensberger risente fortemente della situazione particolare della Germania, paese sconfitto e occupato – c’è una comune sottolineatura del linguaggio, o di quella che verrà presto chiamata “la scrittura”. Tuttavia il documento preparatorio non ha la medesima radicalità di quello di Blanchot, per cui l’impegno per il linguaggio è prioritario e decisivo, così come l’idea di costituire attraverso la rivista internazionale non un gruppo di scrittori, ma una vera e propria comunità di scriventi e leggenti.
Il terzo testo presentato è del filosofo polacco Kolakowski; sua la formula poi citata nei successivi scambi epistolari: “la comunità dei collaboratori è di ordine genetico piuttosto che teorico”. Egli ricorda nel suo scritto preparatorio una formula di Vittorini: “una rivista dell’espressione”. Ma come diventerà ben presto evidente nello scambio di lettere che segue, tra il 1962 e il 1966, le diverse formule, per quanto vicine o assonanti, indicano cose molto diverse.
Elio Vittorini, vero motore dell’impresa, si trova, se così possiamo dire, in una situazione intermedia rispetto a francesi e tedeschi, molto più amico di alcuni membri del gruppo francese che non di quello tedesco, per alcuni aspetti sembra invece più vicino alla realtà culturale e politica dei tedeschi. Lo si vede molto bene nel testo intitolato “Contributo a un progetto di prefazione per una rivista internazionale”, che di fatto si pone come un punto di mediazione tra le due diverse tendenze. Egli ha una visione decisamente internazionalista del lavoro letterario, e insieme coltiva un bisogno di unità che gli pare di poter leggere nelle vicende europee recenti. Parla di Letteratura, ma ha ben presente lo scacchiere politico dell’Europa all’inizio degli anni Sessanta. La base del progetto è la letteratura: stiamo lavorando a una rivista letteraria, insiste; per questo non saranno gl “specialisti” a scrivere, bensì gli scrittori stessi. E così il linguaggio sarà letterario. Scrivendo per ultimo, Vittorini ha letto i testi di Mascolo e Enzensberger; perciò precisa che la rivista on sarà marxista, ma neppure anticomunista. Qui gioca la sua comprensione dei fatti italiani: nel luglio 1960, c’è stata la rivolta contro il governo Tambroni sostenuto dai voti neofascisti, le rivolte di piazza ei giovani uccisi dalle pallottole della polizia. Per Vittorini la rivista che sta per nascere non sarà anticomunista, ma neppure preoccupata di dispiacere ai partiti comunisti, “o di offendere la psicologia comunista”.
Vittorini tuttavia non ha la medesima visione di Blanchot; la sua cultura letteraria e politica è radicalmente diversa. Per quanto possa condividere, almeno sul piano dello slancio personale, il vitalismo che c’è nella posizione dello scrittore francese, Vittorini ha una formazione e un ancoraggio intellettuale legato al razionalismo e allo storicismo d’impronta marxista; è legato a una forma di “attualità” che fa di lui uno scrittore contemporaneo, sempre presente, almeno fino al principio degli anni Sessanta, nel dibattito culturale e letterario italiano ed europeo con posizioni di stimolo, provocazione ma anche sintesi. Dal «Politecnico» a «Il Menabò», passando per “I Gettoni”, la sua posizione è sempre stata di stimolo e di organizzazione del lavoro culturale. Francesco Leonetti, ben presto segretario e animatore del gruppo italiano, si muove in modo analogo a Vittorini, ma senza rinunciare, come spiegano le pagine di Anna Panicati, a una propria personale posizione.
Ben presto le diversità tra il gruppo francese e quello tedesco emergono con evidenza. In particolare, si focalizzano nel dissenso intorno al “frammento”, là dove gli scrittori tedeschi si orientano per una modalità di scrittura differente, sia nell’ambito saggistico sia in quello narrativo. Ma non si tratta solo di questo. La costruzione del muro di Berlino, la divisione in due della Germania, spingono gli scrittori tedeschi ad auspicare la pubblicazione di una rivista tedesca, il cui progetto si intreccia ma non coincide con quella comunità di intenti e di lavoro proposta dai francesi. Nell’epistolario – qui pubblicato solo in parte, per ragioni di spazio – il gruppo italiano si fa carico di trovare una soluzione anche pratica al dissidio: anticipare un numero tedesco e poi farlo seguire dal materiale comune – francese e italiano – a partire dal numero due.
Uwe Johnson, a cui il gruppo tedesco ha delegato il lavoro di coordinamento con gli altri, ripete che la rivista deve avere un carattere internazionale, fin dal primo numero, e non essere “la semplice giustapposizione di tre parti nazionali” (1962). I testi raccolti cominciano a delineare il progetto, ma nell’incontro di Parigi diventa evidente che l’idea di letteratura di Vittorini, Calvino e Grass è molto diversa da quella dei francesi; Vittorini scrive a Louis-René des Forêts in questo senso (1963). Egli accusa – forse non a torto – i francesi di essere dei “filosofi”, di fare filosofia, non letteratura. Il problema della “differenza” posto dai francesi è declinato diversamente dagli italiani (Vittorini, Leonetti, Calvino) e dai tedeschi. Risponde Blanchot: “Parlare è il nostro rischio e la nostra necessità” (1963).
In questo dibattito, poi chiarito da una lunga lettera di Enzensberger, si evidenzia la novità della visione letteraria francese, più vicina all’esistenzialismo e alla fenomenologia (Heidegger e Sartre) che non all’idea storicista degli italiani e in parte anche dei tedeschi: la letteratura si misura con la storia, con la società e con la politica, per italiani e tedeschi; con il linguaggio, scrivono i francesi (è il passaggio già avvenuto verso lo strutturalismo e il poststrutturalismo di Foucault e Derrida). Sono due linee culturali e letterarie che attraverseranno gli anni Sessanta e Settanta, divaricando, in una certa misura le letterature nazionali europee. Nonostante tutto Vittorini e Leonetti allestiscono un numero de «Il Menabò» in attesa – ben presto tramontata, anche per la malattia di Vittorini – di arrivare alla rivista internazionale intitolata «Gulliver». Qui pubblichiamo una scelta dei testi raccolti nel numero 7. Forniscono un quadro ben evidente della situazione e anche delle diverse tendenze degli autori (per quanto emerga anche una piccola ma non trascurabile omogeneità di fondo: gli interlocutori si sono avvicinati un poco tra loro).
Il 1964 è l’anno di svolta. La malattia di Vittorini fa precipitare le cose, e le differenze non sono riuscite a dialogare tra loro. Leonetti non ha perso le speranze di un lavoro comune. Percepisce i cambiamenti in corso nel paesaggio culturale italiano, e cerca, scrivendo a Roland Barthes, di trovare elementi comuni; ma il discorso, forse per la stessa nascita del Gruppo 63, per la diffusione dei temi strutturalisti, ha ora degli accenti diversi. Scrivendo a Barthes egli cerca un altro punto d’incontro che non è più quello del “frammento” di Blanchot, cui Leonetti è sempre stato ostile. Ma l’ipotesi di una rivista europea redatta in comune è venuta meno.
Tutti coloro che hanno partecipato al lavoro comune risulteranno in qualche misura mutati; lo stesso Calvino, più estraneo al progetto di Leonetti e Vittorini, trarrà, come sottolinea Guido Bonsaver, motivi di riflessione sul tema del “lettore”, di una diversa costruzione dell’opera letteraria, pur respingendo, cosa che farà nei suoi saggi degli anni Sessanta, motivi che reputa vitalistici e irrazionalistici (ma dieci anni dopo, anche grazie all’incontro con Gianni Celati, Guido Neri e Carlo Ginzburg, farà proprie alcune conclusioni già enunciate da Blanchot). Vittorini, dal canto suo, il più aperto agli influssi dei francesi, sottolinea Anna Panicali, non comprende il senso della “scrittura per frammenti” dei francesi.
Così Uwe Johnson e Ingeborg Bachmann, tra i membri del gruppo tedesco più vicini per sensibilità alle proposte di Blanchot, sono molto concentrati sul destino della loro lingua e del loro paese dopo il nazismo, la sconfitta e la divisione tra Est e Ovest. Non a caso entrambi andranno a vivere fuori dalla Germania, uno in Inghilterra, l’altra in Italia, come risposta a un problema che sentono troppo urgente e ustionante (ma anche Enzensberger andrà per un certo tempo, proprio durante il dibattito sulla rivista, a vivere all’estero). La costruzione del muro di Berlino diventa l’evento decisivo di quella generazione di scrittori, mentre la Germania, scrive Eva Banchelli, assomiglia sempre più a una soffocante provincia. Solo immergendosi a fondo nelle vicende storiche, scrittori come Grass e Enzensberger cercheranno di dare una risposta – a tratti decisamente differente – al problema del lungo dopoguerra tedesco.
Se la rivista non è nata, se «Gulliver» non è diventata una iniziativa comune della cultura europea e internazionale, tuttavia molti dei temi dibattuti nelle lettere, negli scambi epistolari, nei testi preparatori, negli articoli scritti, costituiscono una mappatura del decennio seguente. Così la lettura di questo materiale – qui raccolto nella forma più ampia sin qui edita – permette di cogliere le linee di tendenza e di riscoprire il valore intellettuale di una intrapresa che se non ha raggiunto il suo obiettivo, tuttavia è stata ricca di ragioni e questioni che abbiamo visto maturare solo dieci o vent’anni dopo. In questo senso «Gulliver» non è il nostro passato remoto, ma il passato prossimo, il punto da cui è partita la trasformazione della letteratura europea nell’ultimo ventennio del XX secolo. Non materiali da archivio, ma materiali vivi a cui il presente non ha ancora dato risposta.
Lo stesso esito della neoavanguardia italiana, del Gruppo 63, tra contestazione e integrazione, sperimentalismo e avanguardia, è emblematico Gli anni Settanta decentrano la crisi di un’idea letteraria sperimentale a vantaggio di una radicalità politica che, in alcuni casi, in Italia riscoprirà i temi blanchottiani e del gruppo francese di «Gulliver». Inutile dire che il ripensamento di questo progetto è indispensabile per capire cosa sta succedendo oggi, quando, almeno in Italia, il postmoderno sembra aver chiuso il suo ombrello definitorio sul presente e il futuro è ancora una partita tutta da giocare in letteratura come nell’arte: i giochi non sono mai fatti. L’esperienza di «Gulliver» con tutte le sue diversità ce lo insegna.