Speciale
Intervista a Santiago López Petit
Elia Verzegnassi Molti pensatori hanno provato a considerare la rivolta tanto come evento che sfida l'ordine sociale, quanto come tattica con cui lacerare le maglie di un potere rivelatosi nel tempo intoccabile rispetto ad altre operazioni politiche (rivoluzione, antagonismo, forme alternative di rappresentanza, ecc.). A essere posta in rilievo, in entrambi i casi, è la qualità irruenta della rivolta, la carica con cui essa irrompe nel reale perturbando le condizioni da cui pur essa è sorta. Si potrebbe avvicinare la rivolta, in favore di questo carattere, a ciò che, nel suo Lo Stato guerra. Terrorismo internazionale e fascismo postmoderno, viene definito come «gesto radicale»?
Santiago López Petit Di fronte alla difficoltà di pensare oggi la propria idea di rivoluzione, di fronte all'impotenza alla quale sembriamo condannati, alcuni di noi cercano nella ribellione, o meglio, in ciò che sarebbe una pratica di sovversione, una via per attaccare la realtà. Non è strano che, almeno nel mio caso, questa indagine mi avvicini al pensare il gesto radicale a partire dal gesto dadaista. Duchamp, com'è noto, nel segnalare un orinatoio e chiamarlo «opera d'arte», non solo attacca l'arte borghese bensì distrugge l'arte come istituzione. Ciò che mi proposi, ovviamente con l'aiuto di un'alleanza di amici, fu generalizzare il gesto dadaista. Pensare il gesto radicale come interruzione di tutte le relazioni che costituiscono e mantengono intorpidita la realtà. Cioè, come interruzione delle relazioni di senso, di potere e di sfruttamento. Okupar una casa, il dinero gratis... erano esempi di gesti radicali nel momento in cui sovvertivano il senso comune e permettevano l'esperienza di un noi. Però non riuscimmo a far sì che il gesto radicale che era a disposizione di tutti si ripetesse e prolificasse. Il sogno di una grammatica di gesti radicali non avanzava. Fu nell'anno 2011 e con il movimento 15M (o degli indignados, utilizzando il linguaggio dei giornalisti) che un gesto radicale concreto, quello di prendere le piazze, iniziò a estendersi e ad aprire uno spazio di sperimentazione. Prendere le piazze per prendere la parola. Per dire basta, per affermare che non ci rappresentano. Questa irruzione del malessere sociale che sicuramente ci superò tutti, inclusi coloro di noi che più lo desideravano, non poté sostenersi nel tempo, e il vuoto aperto fu colonizzato nuovamente da vecchi discorsi politici. Per un certo tempo fu chiaro che esistevano due tipi di politicizzazione. Proveniente dallo Stato, e il suo obbiettivo era sempre la costruzione della forma partito. Scaturita dalla propria esistenza, e il suo obbiettivo è l'auto-organizzazione. La gente che si recò nelle piazze non lo fece come portatrice di alcuna identità (lavoratore, cittadino...) bensì semplicemente come qualcuno che si alza e grida di voler vivere. L'utilizzo dello spazio come leva permise che si incontrassero la forza dell'anonimato e la forza di dolore. Che si incontrassero nel fondo della strana allegria che produce lo stare insieme. Durante questo lasso di tempo, noi tutti cessammo di essere unità di mobilitazione per costituirci in anomalie. Figli della notte. Di una notte che la rabbia degna incendia.
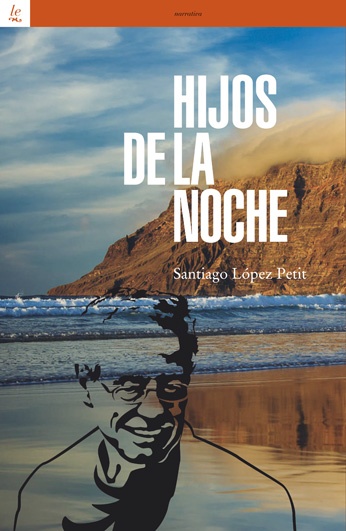
Nel settembre dello scoro anno è uscito in Spagna un libro dal titolo Hijos de la noche (Figli della notte). È uno sforzo durato anni, nel quale è fondamentale il vivere una malattia che distrugge e porta alla disperazione, in una notte che ha poco a che vedere con la notte dei romantici. Il corpo affaticato dalla vita le ha permesso ripensare la malattia e il malato. Il malessere che oggi colpisce ognuno di noi riguarda ciò che lei chiama malattie della normalità: di cosa si tratta?
Effettivamente questo libro parla della malattia, più concretamente della mia malattia. Però, prima di proseguire, mi piacerebbe chiarire una cosa. Quando prendo la parola per spiegare ciò che accade alla mia testa, quando descrivo questo processo di distruzione mentale e fisica che dura ormai da tanti anni, l'Io che parla è ciò che possiede meno importanza. Il racconto autobiografico con il quale inizia Hijos de la noche svolge unicamente una doppia funzione. In primo luogo, e per com'è costruito, deve impedire al lettore di adottare la posizione di esteriorità propria dello spettatore neutrale. In secondo luogo, è il racconto personale in quanto tale a costituire la via di accesso alla notte del malessere. Perché, come già la domanda dice, questa notte del malessere non ha nulla a che vedere con la notte romantica o mistica. La notte del malessere è la notte di uno stare-male che non ha fine e, precisamente per questa ragione, poiché la notte della disperazione si porta con sé, non rimane altro da fare che attraversarla. In questo modo la massima singolarizzazione permette di andare più in là del caso particolare e iniziare a organizzare le domande veramente importanti: che relazione esiste tra la salute e la malattia? Chi non è malato in questa società? Si può fare della malattia un'arma? Per cercare di rispondere a simili domande bisogna evidentemente inserire la questione della malattia in una cornice socio-politica, anche se bisogna farlo con molta attenzione. La politicizzazione della malattia non deve nascondere la dimensione astorica o metafisica che le è essenziale, e che la parola sofferenza esprime, nonostante l'ambiguità che possiede. La nostra sofferenza è sociale. Siamo malati perché viviamo dentro il ventre della bestia, e siamo noi stessi che, semplicemente vivendo, la alimentiamo. Questa metafora dice, allora, che oggi il capitalismo e la realtà si sono identificati l'uno con l'altra e, allo stesso tempo, che siamo passati dallo sfruttamento capitalista alla mobilitazione globale, nella misura in cui il sequestro della vita si è esteso all'intera vita, ben oltre il tempo del lavoro. La mobilitazione globale, cioè la auto-riproduzione di questa realtà resa una con il capitalismo, schiaccia le nostre vite perché vivere ormai non consisterà in vivere bensì nel “possedere una vita” da gestire con successo. Che il capitalismo faccia ammalare è stato denunciato da tempo, la “novità” risulta dal fatto che ora, per adattarci alla normalità, dobbiamo ammalarci. Da lì il termine «malattie della normalità», e l'uso del termine fatica proveniente dalla fisica per includerle tutte. Fatica significa «perdita della resistenza meccanica di un materiale nell'essere lungamente sottoposto a ripetuti sforzi». La normalità è questa vita in movimento, piegata al movimento di un capitale sfrenato. Sindrome da fatica cronica, depressione, sensibilità chimica multipla... «Non c'è modo di etichettarle. Noi, come medici, non osserviamo nulla. E loro, come pazienti, non muoiono mai.»
Nel suo libro Amare e pensare. L'odio del voler vivere emerge con chiarezza l'idea per cui «vivendo riproduciamo le prigioni del possibile», perché la vita è innanzitutto ciò che siamo chiamati a gestire. Alla luce di questo, possiamo pensare la malattia del voler vivere come qualcosa che lotta contro la vita, come qualcosa di essenzialmente inoperoso e tuttavia in atto?
Io lo direi in un altro modo. La malattia del voler vivere non lotta contro la vita ma è il proprio voler vivere che lo fa. Di fronte alle proposte filosofico-politiche che appoggiano un'affermazione vitalistica, ho sempre preferito liberare la vita contro la vita. Liberare la vita contro la vita significa che il voler vivere deve separarsi dalla Vita che lo assoggetta. Dalla Vita con la maiuscola che è uno spazio di possibili nel quale siamo introdotti e dal quale non possiamo uscire. Dalla Vita con la maiuscola che è nella tautologia “la vita è la vita”, banalmente ripetuta dal senso comune. Dalla Vita con la maiuscola che è, in ultima istanza, la mobilitazione globale. La malattia del voler vivere si mostra ora nel suo carattere apertamente politico: voler vivere e non poterlo fare. L'impossibilità di vivere non è un'opzione in più bensì costituisce una posizione. Una posizione, chiaramente politica, innalzata in quel campo di battaglia che è la vita. Perché per i malati di normalità il voler vivere è la loro malattia e, allo stesso tempo, il loro modo di sfidare il mondo. Con l'aiuto di Lautréamont, Artaud e Celan ho cercato di precisare in cosa consista questo sfidare. Concordo con ciò che ha detto, sulla necessità di superare il dualismo attività/passività nonostante voglia precisare che lo sfidare compie una critica pratica ed effettiva. In altre parole la fatica, la malattia del voler vivere, dice la verità del mondo e di se stessi perché la sua contrapposizione è radicalmente pratica: un corpo affaticato interrompe la mobilitazione.
Questo voler vivere è una malattia che sfida la stancante normalità della vita e l'ordine sociale. Malati di voler vivere, nel punto in cui lo stare male e il malessere sociale si incontrano, emerge ciò che lei chiama anomalia. Qual è lo stacco rispetto all'anormalità foucaultiana e come si può vivere questo proprio essere anomalia?
Del malessere sociale si può parlare utilizzando dati statistici. Per esempio si può affermare che in Spagna ci sono dieci suicidi al giorno. Si può anche aggiungere, cosa che si negava fino a ben poco tempo fa, l'influenza della crisi in queste morti. Credo, senza dubbio, che se volessimo veramente politicizzare il malessere sociale dovremmo assimilare il nostro proprio malessere, perché il malessere sociale è, in ultima istanza, uno stare male con se stessi. Nel libro Figli della notte ho cercato di portare questo presupposto il più lontano possibile, e convertirlo in una condizione di veridicità. La diagnosi della mia malattia diventa così la diagnosi di un'epoca, e la fatica, che è un'interiorizzazione della morte per poter vivere, acquisisce una dimensione epistemologica e politica. Introdurre il concetto di anomalia in questo quadro mi permetteva di andare direttamente all'essenziale. Assumere se stessi come anomalia significa attraversare la prova della fatica, cioè constatare l'impossibilità di vivere per il fatto di non trovare esattamente il proprio posto, di non voler trovare il proprio posto in questa realtà. L'anomalia che esprime la malattia del voler vivere non consiste, quindi, in una mera disfunzione che può essere ricondotta a null'altro che a un'altra dimensione della vita che sfida la Vita. Ciò implica che l'anomalia si presenta, simultaneamente, come ombra ed emergenza, come critica della metafisica e della mobilitazione globale. Ora, ogni anomalia, proprio perché si tratta di un'unità di mobilitazione che si rompe e scappa, è una forza di dolore. Assumersi come anomalia significa quindi sgomberare il ruolo della vittima e farsi con questa forza del dolore. Con ciò che si è detto, credo sia chiaro perché il concetto di anomalia si separi dal concetto foucaultiano di anormalità. Per Foucault, nonostante alcune incertezze, la triade malato-pazzo-genio continua a funzionare come una specie di filo sotterraneo. Per il resto, e non serve ricordarlo, questa vicinanza alla «alterità pericolosa» deve completarsi con il riferimento alle istituzioni disciplinari che saranno incaricate di sottometterla. All'anomalia, invece, non può applicarsi né la triade precedente né il sequestro. Perché? Perché il destino dell'anomalia non è l'esclusione bensì semplicemente la sparizione. L'anomalia scompare quando viene introdotta in un limbo giuridico e sanitario in cui è sottomessa a un giudizio che non termina mai. Il sospetto deve strapparle una giustificazione. La verità che porta con sé sovverte non la ragione bensì la sua propria realtà, e per questo bisogna zittirla. Nella vita quotidiana, tale giudizio permanente che cerca la colpevolizzazione dell'anomalia si traduce spesso in una frase non detta che però il malato di normalità intende: «Vivi o muori, però smetti di dar fastidio».









