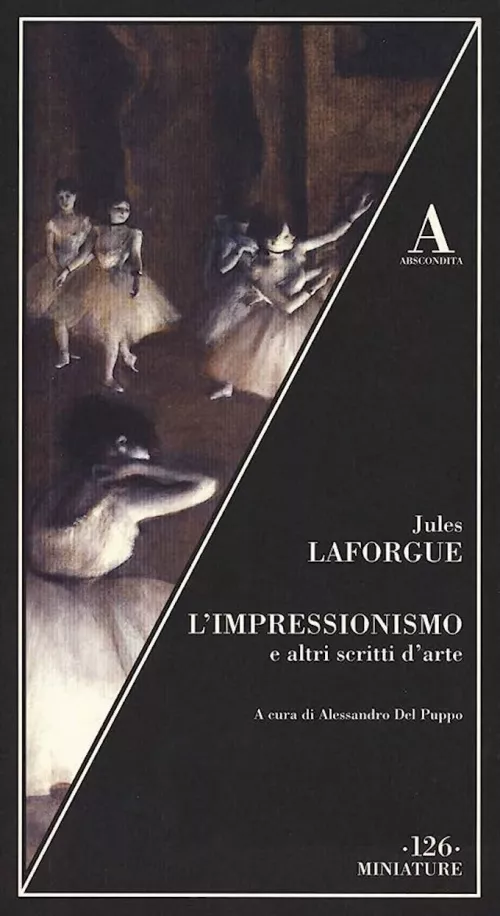Jules Laforgue: vivere per vedere
Lo troviamo adolescente nella Parigi postcomunarda in cui, come scrive Flaubert, “metà della popolazione voleva strangolare l’altra metà, glielo si leggeva negli occhi”. Nella città più cosmopolita d’Europa in cui quasi la metà degli abitanti proveniva da altri paesi del mondo, la più ricca e la più povera di Francia (il settanta per cento dei funerali, ci ricorda Victor Hugo, era di miserabili senza beni di proprietà), Laforgue si trova nel tempo e nel luogo utili per risalire, attraverso la scrittura giornalistica, poetica, drammaturgica la scala sociale.
Brillante, brutale, nemico dei mezzi termini, dell’atonia borghese, la sua prosa d’arte restituisce il sapore della consistenza grassa della pennellata, scrive: “un uccello di un bel bianco, grassamente, saporitamente ritorto, che dà piacere a chi lo degusta”. È Jules Laforgue che, tradotto nelle riviste italiane di primo Novecento – da pochi giorni protagoniste di una bellissima mostra agli Uffizi – guida la ricezione dell’impressionismo francese in Italia a fine XIX secolo; è Laforgue, che introdotto in Italia da Ardengo Soffici nel 1909 (ma era già noto a Guido Gozzano) venne poi letto da Vittorio Pica e accompagnò la ricezione italiana delle prime tele di Pissarro e Degas – di cui va vista, in questi giorni, la mostra alla BNF sulle sperimentazioni incisorie.
“Vorrei perlomeno sognare di essere il John Ruskin definitivo”: così Jules Laforgue (1860-87) di cui escono ora gli scritti sull’impressionismo dall’editore milanese Abscondita, nella traduzione di Greta Bodin e a cura di Alessandro Del Puppo, che nella ricca postfazione ne ricostruisce il percorso critico e l’influsso sui suoi lettori italiani di inizio Novecento, dai citati Soffici e Pica a Roberto Longhi, trovando “convinti ammiratori” anche più tardi, per esempio in Eugenio Montale e Carmelo bene.
“Dupré è senza senso”, scrive, “i due meravigliosi piccoli Corot ghiacciati, argentei, puliti come dei Francesco Guardi…”, “Quando al virtuoso Diaz mancano i suoi fronzoli, io ho il diritto di fischiarlo”: la sua prosa d’arte ha indubbiamente il “vizio del colore” e piace fin da subito al collezionista di Odessa Charles Ephrussi che fa del povero studente di filosofia di Montevideo, decimo di undici fratelli, orfano di madre, il suo segretario personale. Fin da giovanissimo Laforgue si era fatto notare per i suoi disegni arguti e i suoi articoli sagaci su La Guêpe e su La Vie moderne ma fu solo grazie a Gustave Kahn che arrivò alla collaborazione col futuro direttore della Gazette des Beaux Arts, già proprietario di parecchi Degas, Manet e Monet: è con lui, di spalle, in abito nero da sera, che Laforgue compare nel Déjeuner des canotiers (1881) di Auguste Renoir: il contrasto tra le due figure è marcatissimo: il giovane uruguagio è la fresca, franca figura su cui sembra convergere la luminosità bionda di tutta la tela. Pittore lui stesso, Laforgue avrebbe voluto diventare collezionista, ma, senza un soldo, dovette accettare l’impiego, raccomandato da Ephrussi, di lettore alla corte dell’imperatrice Augusta (1883: “Chi l’avrebbe detto, per un bambino di Tarbes!”): partì il giorno stesso del funerale del padre, mancando le esequie per lasciarsi alle spalle anni di indigenza.

I suoi anni tedeschi danno al giovane critico la possibilità di entrare in contatto con artisti ancora sconosciuti in Francia come Max Klinger, che conobbe personalmente “sorta di genio del bizzarro”, e Arnold Bocklin e di definire con più sicurezza la sua ricerca: avverso a Hyppolite Taine e a ogni estetica dogmatica (“non bisogna sperare di giudicare, di gustare le opere contemporanee e del passato se non in modo infinitamente effimero, da creature comuni che siamo..”), Laforgue sostiene un’estetica del dettaglio, del contingente, del transitorio, un’estetica antidealistica, priva di gerarchie di generi: “Rubens è decorativo, non realista, non ha mai studiato le tende, i bacini, i colli, le cosce”.
Non a caso del Puppo lo chiama “il primo modernista”. Scrive di lui Soffici: “Sa veder più a fondo e con maggior chiarezza le cose”. Apprezzato da De Chirico, da Ezra Pound, Laforgue è il partigiano del non finito, del tratto grosso, sbavato, sporco, contraddittorio: “La linea diritta è noiosa – scrive – la linea leggermente flessa è blanda, nauseabonda, noiosa, senza la serenità della linea dritta. L’ideale è la linea spezzata mille volte, che brilla per gli scarti imprevisti, che delude l’occhio, lo frusta, lo irrita, lo tiene sulle spine.” Prima di Walter Benjamin Laforgue si interessa alla dimensione orale, popolare dell’arte, disprezzando le accademie e i Salons: “è un’industria spregevole, una psicologia del melodramma, del teatro dell’Eden. Cieli privi di coscienza, estetica su commissione”. Il pedantismo lo irrita: “Philippe Rousseau è decisamente terribile”, “Baudry è tremendo”, “Benjamin Constant una fricassea rutilante”. Ma Renan “ha una finezza di pastello… immobile, misteriosa, immortalmente preziosa in un angolino del futuro”, Raffaëlli eccelle in un “dignitoso fazzoletto di ciniglia nera”, Dagnan andrebbe “posizionato un po’ più in basso” in modo da poter esser visto con cura dai visitatori più giovani affinché lo assumano come loro modello.
Questa edizione completa della sezione “Critique d’art” dei Mélanges posthumes (1903), scritti su quadernini che l’autore teneva per sé soltanto – va completata con i testi editi in vita ripresi nell’edizione di Losanna (2000) curati da Mireille Dottin – ci restituiscono una scrittura libera, sicura, in cui sentiamo Baudelaire, le filosofie dell’inconscio, l’energia esplorativa delle avanguardie, lo scetticismo verso la “commedia dell’arte moderna” ma anche una felicità scalza, autentica che ci manca oggi come l’aria:
“le armonie di Whistler, le cupe cucine di Ribot, le brillanti illustrazioni di Isabey (senza psicologia, né realtà, né disegno, ma così allegro!).
Laforgue morì a ventisette anni di tisi, poco dopo il suo matrimonio con una ragazza inglese e il suo ritorno a Parigi. È sepolto, un sepolcro essenziale senza decori, nel cimitero di Bagneux, poco lontano dalle tombe di Marcel Mauss e Oscar Wilde. In una delle sue liriche immagina la morte del pianeta terra, il corteo solenne dei soli che “annodano e snodano le loro vaste masse d’oro”, che portano il lutto “molto lento” della loro sorella morta, ricorda la prima giovinezza del pianeta, le lotte febbrili degli uomini, le cattedrali sorte e le invenzioni magnifiche, le pestilenze, “il cervello pazzo di Hegel”, la Legge, il furore, Eppure “Dormi per l’eternità, è tutto finito, puoi crederlo, che questo dramma inaudito fu un incubo (...) hai solo sognato, dormi”.