La nuova carne di Clive Barker
Durante il primo lockdown, nell’aprile 2020, ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare: sono andato da un amico e ci siamo fatti una maratona di tutti i film di Hellraiser, la saga horror incentrata sulle malefatte di Pinhead e dei suoi Cenobiti, demoni sadomaso da un’altra dimensione, e su tutta la banda di pervertiti che incautamente, film dopo film, li evocano per esplorare vette insondate di piacere e dolore. Io ero appena tornato dal Canada, dove lavoravo e da dove ero fuggito allo scoppio della pandemia, mentre Tommaso era rientrato a Padova da Bologna. Entrambi vivevamo soli e avevamo ridotto al minimo le interazioni col prossimo; che rischio c’era, dunque, a trovarci insieme per guardare i dieci (and counting) capitoli di questo franchise horror?
Era una maratona, poi, assolutamente appropriata per il clima pandemico, e solo l’eccezionalità garantita dal lockdown permetteva di ritagliare tutto quel tempo per un’iniziativa tanto improbabile. Ricordo di essere uscito di casa sul fare del tramonto, aggirandomi circospetto per una città deserta munito di autocertificazione taroccata, per ripartirmene il giorno dopo con delle buste di tela vuote, di modo da poter simulare di stare passando al mercato.
La nostra notte del drive-in, inframmezzata da poche ore di sonno vigile per rimetterci in forze e ricominciare a vedere i film sul fare dell’alba, è stata un’esperienza lugubre e lisergica. Dopo il genio di Hellraiser (1987) seguono il disturbante dark fantasy di Hellbound: Hellraiser II (1988) e la pacchiana apocalisse urbana di Hellraiser III: Hell on Earth (1992), mentre Hellraiser IV: Bloodline (1996), si snoda per diversi piani narrativi che vanno dal Settecento francese al futuro, coi Cenobiti lanciati nello spazio profondo. Hellraiser: Inferno, l’ultimo film effettivamente decoroso, è un direct-to-video riscattato solo dalla regia brillante e dalle intuizioni visuali di Scott Derrickson, che non a caso girerà poi un capolavoro come Sinister (2012).
Da lì in poi è tutta salita, e anche il so-bad-it’s-good viene meno per far subentrare un senso di sconforto: Hellraiser: Hellseeker (2002) è sostanzialmente Inferno con attori diversi e il ritorno di Ashely Laurence nei panni di Kristy; Hellraiser: Deader (2005) è ambientato e prodotto in Romania, con Pinhead che si intrattiene nella scena underground di Bucarest; Hellraiser: Hellworld (2005), con una performance a dir poco crepuscolare di Lance Henriksen, trasforma il mondo dei Cenobiti in un videogioco online multiplayer che la scarsità di mezzi rende se possibile datato persino per l’epoca; Hellraiser: Revelations (2011), girato in due settimane con trecentomila dollari per soddisfare un obbligo contrattuale e conservare i diritti sul franchise, è un prodotto poco più che amatoriale, mentre Hellraiser: Judgement (2018) presenta qualche tocco di originalità, ma ricorda più un videoclip di Floria Sigismondi che un vero lungometraggio. A un certo punto, quando in Hellraiser: Inferno vengono inquadrati insieme il cenobita Pinhead e il paranoico detective protagonista del film, io e Tommaso abbiamo avuto l’inquietante sensazione di vedere i nostri volti nei loro – ed eravamo solo a metà della cavalcata.
Questa piccola premessa mi serve per puntualizzare che sono, nei confronti di Clive Barker, il più parziale dei recensori – e che non me ne vergogno. Del resto, nel mio ufficio ho un poster di Pinhead autografato dal suo interprete più famoso, Doug Bradley. Dei dieci Hellraiser, solo il primo porta la firma di Barker, allora al suo esordio cinematografico; e l’autore e regista ha collaborato solo fino al quarto film, ossia fino al momento in cui la qualità non subisce un tracollo drastico.
Eppure, se questa saga spesso bistrattata dai suoi produttori riesce comunque a continuare ad avere adepti (nel 2022 è prevista l’uscita di un nuovo capitolo su Hulu, con l’attrice Jamie Clayton a interpretare Pinhead) non è solo per la voluttà di qualche fanatico di continuare a infliggersi nuove iterazioni degli horror che guardava da adolescente, ma per la forza geniale dell’immaginario che Barker ha saputo creare, infondendo i suoi Cenobiti di un erotismo macabro fatto di latex, piercing, deformazioni, e una sessualità gotica e industriale. Anche nel peggiore degli Hellraiser, in fondo, resta una scintilla dell’intuizione originale di Barker – che l’horror può essere un veicolo di liberazione e di esplorazione della sessualità, e che paura, piacere e dolore possono coincidere.
Barker, tuttavia, non comincia come regista, bensì come scrittore, pubblicando l’antologia di racconti Libri di Sangue, sei parti divise in due volumi che escono rispettivamente nel 1984 e nel 1985, quando l’autore ha appena trentadue anni. Che questi racconti siano una pietra miliare dell’horror contemporaneo è un’affermazione quasi scontata: oltre ad avere influenzato innumerevoli scrittori, le loro numerose trasposizioni cinematografiche hanno contribuito a informare l’immaginario horror dei decenni successivi.
Un esempio su tutti: Candyman (1992), che adatta The Forbidden, spostando l’ambientazione dalle macilente periferie dell’Inghilterra thatcheriana alle case popolari afroamericane di Chicago, è uno dei grandi film di horror sul razzismo e insieme sulle leggende urbane, anticipatore tanto delle riprese contemporanee del folk horror quanto delle opere di registi come Jordan Peele (che non a caso nel 2021 ne produce un remake). Tanto per cambiare, però, i Libri di Sangue di Barker latitavano da tempo dagli scaffali delle librerie italiane, e Fanucci si è fatta carico di riportarceli (per ora la prima metà, in una traduzione forse a tratti un po’ legnosa e letterale ad opera di Silvia Petrone; il resto è in uscita a novembre).
I Libri di Sangue sono senz’altro un classico dell’horror, ma non solo nel senso che sono invecchiati bene, o che continuano a poter essere riletti con novità e profitto. Questo vale anche per molti libri che hanno lasciato un segno molto più labile nella storia del genere. Quello che occorre dire, invece, è che c’è un prima e un dopo l’esordio di Barker nell’horror. Come ha scritto Simone Sauza, “difficilmente si erano viste storie dell’orrore cariche di tensione sessuale, soggettività devianti, temi politici radicali, rabbia proletaria e ironia dissacrante” (https://not.neroeditions.com/clive-barker/).
I racconti, come The Illustrated Man di Ray Bradbury, sono incastonati in una cornice narrativa: i Libri di Sangue sono effettivamente scritti nella carne e nel sangue di uno dei protagonisti. Il lessico ematico, qui, non è né una metafora, né appartiene all’aristocratico vampirismo del cinema dei decenni precedenti, in cui di sangue se ne vedeva colare giusto un rivolo dal collo di qualche giovane dama: no, Barker lancia contro il suo lettore vere e proprie secchiate di frattaglie. Barker lascia da parte le case elegantemente infestate, i fantasmi evanescenti, i vecchi manieri e i paesani sospettosi, per portare l’horror in un qui-e-ora che è sia geografico e cronologico che fisico: qualcosa di molto distante dal fantastico cerebrale e in punta di piedi teorizzato da Todorov.
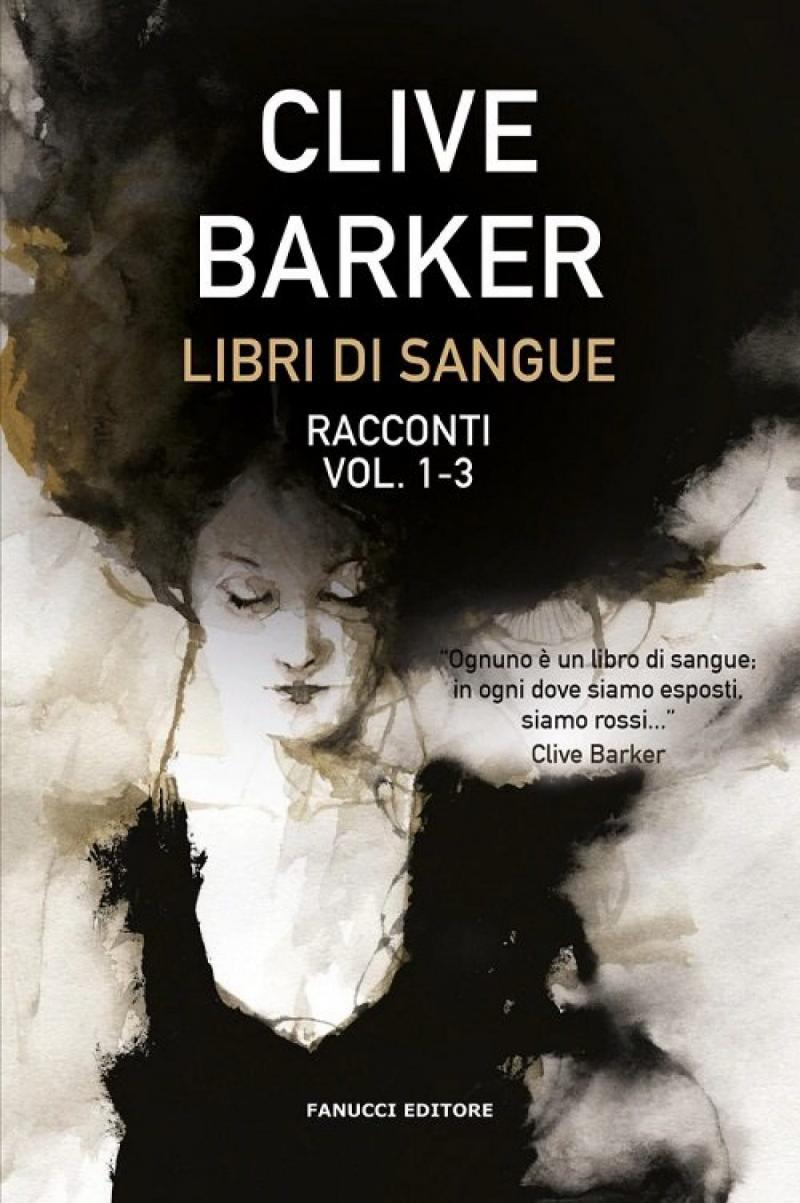
Nel primo racconto della raccolta dopo quello che le dà il titolo, “Macelleria Mobile di Mezzanotte” (brillantemente portato sullo schermo da Ryuhei Kitamura nel 2008), il lettore troverà passaggi come questo:
Riempì tutti i suoi sensi: l’odore delle viscere aperte, la vista dei corpi, la sensazione del fluido sul pavimento sotto le sue dita, il suono delle cinghie che scricchiolavano sotto il peso dei cadaveri, persino l’aria, che sapeva di salato con il sangue. Era indiscutibilmente in compagnia della morte, in quello scompartimento, e sfrecciava nell’oscurità. La carcassa più vicina a lui erano i resti del giovane brufoloso che aveva visto nel vagone uno. Il corpo era appeso a testa in giù, oscillando avanti e indietro al ritmo del treno, all’unisono con i suoi tre compagni; un’oscena danza macabra. Le sue braccia penzolavano liberamente dalle articolazioni della spalla, in cui erano stati praticati tagli profondi tre o quattro centimetri, in modo che i corpi si appendessero più ordinatamente (p. 53).
Nel racconto, Barker immagina un serial killer che si aggira per la metropolitana di New York in cerca di vittime da squartare – mentre la metropolitana si dirige, attraverso gallerie segrete, alle dimore di esseri primordiali e mostruosi che il macellaio ha il compito di nutrire con la carne dei cittadini newyorkesi. “Noi siamo i Padri della Città”, dice una di queste creature, “E madri, figlie e figli. I costruttori, i legislatori. Abbiamo creato noi questa città” (p. 60). La macelleria delle pagine di Barker non si limita a riportare al centro dell’horror una dimensione corporale liberata dai ceroni hollywoodiani, ma la aggancia a questioni sociali e politiche contingenti – in questo caso, una critica acida e grottesca al consumismo americano, che si nutre letteralmente dei propri cittadini.
A impressionare, dei Libri di Sangue, non sono solo la mole e la raffinatezza compositiva, ma anche l’assoluta novità del repertorio, che rifiuta quasi completamente i topoi tradizionali del racconto horror, in favore di un immaginario personalissimo e conturbante. I protagonisti di Barker sono il più delle volte dei reietti della società, come i giovani delinquenti di “Mai dire maiale” o il prostituto di “Resti umani” (uno dei racconti migliori); soprattutto, si tratta quasi sempre di personaggi che l’Inghilterra thatcheriana classificherebbe come sessualmente deviati – omosessuali (come lo stesso Barker), prostitute, pornografi, erotomani. A questa esplorazione di soggettività marginali e di sessualità difformi Barker accompagna un investimento immaginativo di rara potenza, come a voler dimostrare che dallo scontro tra norma ed eccezione non può che risultare un’esplosione di sangue che è sempre traumatica e violenta, ma anche dolorosamente liberatoria.
In uno dei racconti più giustamente celebri della raccolta, “In collina, le città”, una coppia di uomini si reca in Jugoslavia per una vacanza romantica, e rimane invischiata in una strana tradizione locale. Un altro scrittore avrebbe forse inventato qualche rito obliquo, qualche misteriosa trama contro gli stranieri, come in The Wicker Man o in qualche epigono lovecraftiano: in Barker, invece, questa tradizione consiste nell’assemblarsi degli abitanti di due città in enormi giganti antropomorfi. Il risultato è un’epica della dissoluzione corporea e dello splatter che ha pochi paralleli nella narrativa dell’orrore:
Podujevo [una delle due città] stava urlando: un grido di morte. Qualcuno nel fianco debole era morto per lo sforzo e aveva dato il via a una catena di decessi nel sistema. Un uomo abbandonò il suo vicino e quel vicino abbandonò a sua volta il suo, diffondendo il cancro del caos nel corpo della città. La coerenza della torreggiante struttura si deteriorò con terrificante rapidità, poiché il cedimento di una parte dell’anatomia esercitava una pressione insopportabile sull’altra. Il capolavoro che i buoni cittadini di Podujevo avevano costruito con la propria carne e il proprio sangue vacillò e poi, come un grattacielo fatto esplodere, iniziò a cadere. Il fianco spezzato vomitava cittadini come un’arteria squarciata che sputava sangue.
Poi, con una pacata eleganza che rendeva ancora più orribili le agonie dei cittadini, si piegò verso terra, spargendo tutte le sue membra nella caduta. L’enorme testa, che aveva appena sfiorato le nuvole, era ributtata indietro sul suo collo spesso. Diecimila bocche pronunciarono un unico grido nella sua bocca immensa, un appello muto, infinitamente pietoso, al cielo. Un ululato di perdita, un ululato di anticipazione, un ululato di perplessità. Come esigeva quell’urlo, poteva il giorno dei giorni finire così, in un tumulto di corpi che cadevano? (p. 170)
Barker ama giocare col suo genere di elezione e con le aspettative dei suoi lettori, sempre mescolando modelli standardizzati e invenzione immaginifica. In “Rawhead Rex”, per esempio, Barker recupera un topos consolidato della narrativa weird, quello dell’antica divinità pagana che si risveglia nel presente, salvo farne una violentissima parodia sessuale, dotando la divinità in questione di una testa marcatamente fallica: “si chiamava Rawhead, perché la sua testa era enorme, e del colore della luna, e cruda, come la carne” (p. 407). In “Nuovi omicidi in Rue Morgue”, il capolavoro di Poe viene riscritto in chiave gerontofila e zoofila, mentre “Yattering e Jack” rivisita una possessione demoniaca da parte di un demone piuttosto inetto.
Questa tendenza al gioco metatestuale, al cozzo di alto e basso, e alla messa in scena di soggettività disgregate permettono facilmente di inscrivere Barker (senza tuttavia costringercelo) nel filone del gotico postmoderno. Questo appare particolarmente evidente in una delle storie più stupefacenti dell’intero libro, “Figlio della celluloide”, in cui il tumore di un evaso che muore nell’intercapedine di un cinema assume una vita autonoma e comincia a uccidere spettatori e inservienti manifestandosi come divi di Hollywood quali John Wayne e Marilyn Monroe (l’espediente dell’opera d’arte che prende vita è un classico del gotico, e negli stessi anni viene svolta in maniere simili a quella di Barker in capolavori come Demoni di Lamberto Bava, 1985, e Un gatto nel cervello di Lucio Fulci, 1990). Scrive Barker:
Lo spazio, però, l’aria stessa, avevano vissuto di una propria vita durante quei cinquant’anni. Come un accumulatore, l’intercapedine aveva ricevuto gli sguardi elettrici di migliaia di occhi. Mezzo secolo di spettatori avevano vissuto nei panni altrui sullo schermo del Movie Palace, riversando le proprie passioni e le proprie simpatie nelle tremanti illusioni visive, l’energia delle proprie emozioni, accumulate e intensificatesi come un cognac dimenticato, in quello stretto passaggio d’aria. Prima o poi tanta energia avrebbe dovuto trovare uno sfogo. Mancava solo un catalizzatore. Fino al cancro di Barberio (p. 360)
“Io sono un morbo sognatore”, si presenta poi il cancro, “Non c’è da meravigliarsi se amo il cinema”: e si rivela come “un essere disgustoso, un tumore ingrassato per essersi cibato delle passioni altrui, un parassita con la forma di una lumaca e la consistenza di un fegato crudo” (p. 386). Di nuovo, il gioco metatestuale di Barker non è freddo e calcolato, ma si spinge fino alle province più recondite del corpo umano, disfacendolo e rifacendolo in maniere meravigliose e terribili.
La carne, in Barker, è l’avamposto di nuove scoperte – su di sé e sugli altri. Non stupisce che il suo lavoro, specialmente in Hellraiser, sia così influenzato dalle contemporanee sottoculture industrial e BDSM, in un profluvio di latex, menomazioni, modificazioni corporee, e truculenti riti orgiastici: al centro dell’immaginario horror di Barker sta sempre lo spazio vuoto tra quello che desideriamo e quello che non osiamo ammettere di desiderare. In questa chiave, i Libri di Sangue invitano a rileggere e interrogare quel libro di sangue che siamo noi stessi, per scoprire, attraverso il filtro dell’orrore, cosa veramente si cela tra le sue pagine. Come scrive Barker,
Ecco allora le storie scritte sul Libro di Sangue. Leggi, se ti fa piacere, e impara. Sono la mappa di quella oscura autostrada che conduce fuori dalla vita, verso destinazioni sconosciute. Pochi la imboccheranno. I più percorreranno pacificamente le strade illuminate dai lampioni, accompagnati fuori dalla vita con preghiere e carezze. Ma per pochi, pochi scelti, gli orrori arriveranno, saltellando, per portarli sull’autostrada dei dannati (p. 36).









