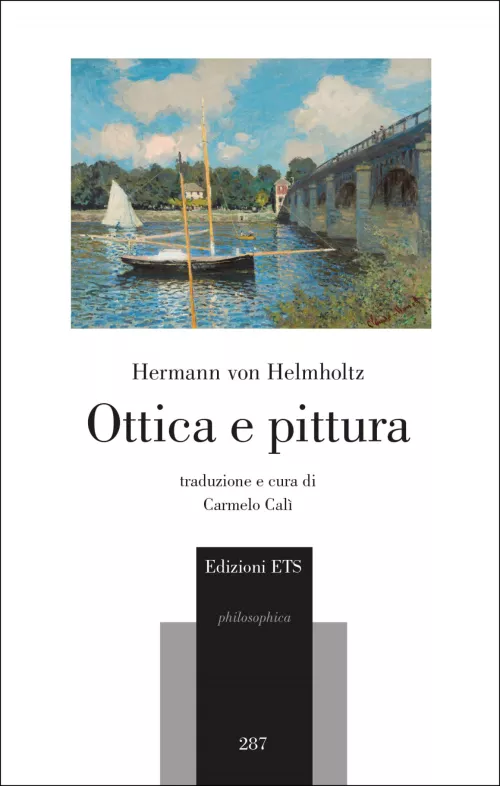La realtà dipinta
Nel nostro abituale modo di vedere gli oggetti ci appaiono sotto prospettive che mutano in continuazione e proiettano sulle nostre retine un flusso continuo di immagini sempre diverse, che variano al mutare del punto di vista da cui li osserviamo quando ci avviciniamo e gli giriamo intorno. Ognuna di queste proiezioni presenta poi una specifica configurazione delle zone in ombra rispetto a quelle in luce, che si ricompone ad ogni nostro minimo spostamento. Noi non abbiamo consapevolezza della complessità delle informazioni che il nostro occhio è chiamato a discriminare e selezionare nell’istante di un colpo d’occhio. Ignoriamo del tutto che ad ogni minima variazione della distanza di osservazione, della direzione e dell’intensità dell’illuminazione, della posizione e dell’orientamento dell’oggetto, mutano in continuazione tutti i parametri ottici; i valori e i rapporti tra tutte le variabili visive che compongono l’immagine retinica di quell’istante di visione.
L’incensante ridefinizione di questa enorme quantità di informazioni porta ad escludere perentoriamente che possa sussistere una qualche corrispondenza tra l’immagine retinica che si forma nell’occhio e l’immagine che un pittore dipinge sulla tela quando guarda una qualunque scena. Si deve escludere a priori che il sistema visivo possa compiere una pedissequa registrazione e successiva memorizzazione del flusso continuo di informazioni visive che, in ogni momentanea fissazione, inondano la retina dell’occhio: la quantità di tempo, di memoria e di energia che richiederebbe contrasta con i principi percettivi di economia, selezione e prontezza affinati dall’evoluzione per rispondere efficacemente alle esigenze dell’adattamento e della sopravvivenza.
È del tutto evidente, quindi, che la rappresentazione pittorica della forma degli oggetti tridimensionali posizionati a diverse distanze nello spazio non può contenere tutte le informazioni che l’occhio rileva nella loro visione diretta. Questa conclusione rende particolarmente intrigante indagare e studiare quali siano i procedimenti che adotta l’occhio del pittore, per far sì che la raffigurazione, piana e statica, di questi oggetti sulla superficie della tela possa comunque presentarli all’occhio dell’osservatore con tale realismo da indurlo a credere che siano realmente davanti ai suoi occhi.
Uno dei più articolati studi sull’argomento lo intraprese l’ecclettico scienziato, fisico e fisiologo, tedesco Hermann von Helmholtz in tre conferenze che tenne a Berlino, Dusseldorf e Colonia negli anni compresi tra il 1871 e il 1873, sinteticamente intitolate Ottica e pittura (trad. e cura di C. Calì) Edizioni ETS, Pisa 2022.
Sebbene il termine ottica, presente nel titolo, lasci supporre che l’argomento trattato riguardi una mera comparazione degli aspetti fisici con quelli figurativi, in realtà ciò che Helmholtz intende per ottica non è riducibile a una branca della fisica, ma estende il suo ambito oltre i meccanismi della percezione visiva per cercare di comprendere le modalità mediante le quali l’occhio umano apprende le proprietà sensibili del mondo visibile. A partire dalle battute iniziali della prima conferenza, lo scienziato tedesco spiega che all’interno dello stesso termine include anche la trattazione di tutti i fattori e i meccanismi della percezione visiva, “perché lo studio fisiologico della maniera in cui la percezione si realizza tramite i sensi e le impressioni provenienti dal mondo esterno (…) presenta molti punti di contatto con la teoria delle belle arti.”
Il testo, dunque, è incentrato sulla costruzione di una teoria della raffigurazione che, alla luce delle scoperte nel campo della fisica, della fisiologia, della psicofisica e della psicologia del tempo, fornisca le basi allo studio dei problemi percettivi che il lavoro del pittore deve risolvere affinché le immagini che dipinge risultino realistiche, ovvero forniscano agli occhi dell’osservatore gli stessi stimoli che riceverebbe se si trovasse davanti agli oggetti reali. “Il fine primario del pittore è provocare in noi con la tela colorata una vivida intuizione visiva degli oggetti che ha cercato di raffigurare,” precisando, tuttavia, che, sebbene, il suo compito non sia quello di creare un’illusione come quella, attribuita erroneamente ad Apelle anziché a Zeusi, di dipingere l’uva con un realismo tale da spingere gli uccelli a beccarla, debba comunque produrre nell’osservatore una vivida e forte impressione da fargli “vedere l’oggetto raffigurato come se lo avesse realmente di fronte.”
Helmholtz per poter spiegare questi procedimenti sente di dover prima assumersi il compito di dimostrare che il processo della visione non si riduce a una mera registrazione delle apparenze ottiche, ma persegue un fine fondamentalmente conoscitivo che implica l’attivazione di molteplici strutture mentali e complessi processi psichici, dalla memoria al ragionamento logico, dall’intuizione all’immaginazione, alle pulsioni dell’inconscio soggettivo che concorrono a formare quelle essenziali inferenze considerate dallo scienziato delle componenti fondamentali nella percezione, la cui importanza non è inferiore a quella dei fattori ottici e fisiologici.
Uno dei suoi contributi più rilevanti, infatti, riguarda proprio il ruolo che il meccanismo psicologico delle “inferenze” esercita all’interno del processo della visione, in assenza del quale l’occhio non solo andrebbe incontro a valutazioni errate ma impiegherebbe un tempo eccessivo per processare il flusso delle informazioni che riceve dalle apparenze ottiche: senza il ricordo del colore di un determinato oggetto, di una foglia, di un frutto, di una sedia… l’occhio non riuscirebbe a separare il colore intrinseco degli oggetti dagli effetti cromatici che questi subiscono, a causa dei cambiamenti dello spettro dell’illuminazione solare nelle diverse fasi del giorno. Come ben precisa il curatore del volume nell’introduzione, per Helmholtz le inferenze sono dei processi mentali che si connettono nella percezione in uno schema che ricalca il processo induttivo, in cui la conoscenza acquisita per esperienza passata fa da premessa maggiore e le sensazioni derivate dalla stimolazione attuale fanno da premessa minore nella funzione conoscitiva dell’apparenza visiva dell’oggetto osservato.
Il saggio di Carmelo Calì, particolarmente ampio e articolato, non si limita ad introdurre il testo di Helmholtz ma ne descrive gli elementi di novità, ne esplora la portata teorica e scientifica comparandola con le tesi sostenute da autori coevi e antecedenti come quelle di Wolfgang Goethe, Michel Eugène Chevreul, Gustav Theodor Fechner, Immanuel Kant, mettendo in evidenza i punti ancora validi alla luce anche delle ricerche più recenti delle neuroscienze.
La teoria della percezione elaborata da Helmholtz si prefigge di fornire la spiegazione di un fenomeno di fondamentale importanza nelle nostre esperienza e cognizione del mondo, al quale abbiamo attribuito, fin dai primi segni impressi sulle pareti di oscure grotte preistoriche e più che mai oggi, il potere incontrastabile di sostituire la realtà: soltanto estraniandoci dalle nostre consolidate e inalienabili abitudini percettive possiamo permettere alla nostra coscienza di destarsi, di recuperare la distanza della ragione critica che le permetta di prendere atto che vedere degli oggetti tridimensionali e la profondità dello spazio in un’immagine pittorica bidimensionale significa assistere a un incantesimo collettivo, vivere un’allucinazione lucida, a cui, non avendone consapevolezza, non riusciamo (e non vogliamo) a rinunciare, né separarci.
È come se non ignorassimo che noi vediamo il mondo con due occhi, che essendo posti in due punti diversi della fronte proiettano due immagini dello stesso oggetto da due prospettive leggermente differenti una dall’altra, affinché il cervello possa avere una visione stereoscopica della tridimensionalità dei corpi e della distanza da cui vengono visti; informazioni che mancano del tutto all’immagine dipinta, la quale presenta la stessa prospettiva ad entrambi gli occhi.
Questa monocularità rappresenta un grosso limite per il pittore perché non può sfruttare quello che “è il più importante mezzo naturale che consente all’osservatore di stimare la profondità degli oggetti raffigurati nel dipinto.” Per ottenere comunque l’effetto della profondità spaziale il pittore è costretto a ricorrere ad altri espedienti ausiliari, agli indizi sulla profondità, ripresi negli anni Sessanta del secolo scorso da James Jerome Gibson, che qui elenchiamo soltanto per ragioni di spazio: gli oggetti più vicini occludono parzialmente la forma di quelli più lontani; la grandezza e la chiarezza apparente degli oggetti varia in relazione alla distanza di osservazione; la direzione delle ombre proiettate; la prospettiva aerea; il gradiente di densità della tessitura delle superfici e la prospettiva lineare.
Tuttavia, siamo convinti di vedere nella riproduzione naturalistica di un paesaggio gli stessi valori di chiarezza e di oscurità che l’occhio percepirebbe se lo avesse realmente davanti, cosa del tutto infondata, in quanto il bianco più chiaro in un dipinto può avere circa 1/20 della chiarezza di un foglio bianco illuminato direttamente dal sole.
L’intensità luminosa che l’occhio rileva nei fenomeni cromatici naturali può essere riprodotta nella figurazione pittorica soltanto in una scala di quasi cento volte più bassa, pertanto è del tutto vano proporsi di riprodurre in un dipinto la vividezza dei contrasti cromatici osservati negli oggetti in piena luce, in considerazione anche del fatto che i pigmenti utilizzati dai pittori non solo non possiedono lo stesso livello di brillantezza e luminosità, ma anche perché le loro imprescindibili mescolanze ne abbassano ancor più il grado. “Quindi, non si può semplicemente imitare i colori dei corpi degli oggetti con colori ottenuti per mescolanza, (…) l’artista non può trascrivere la natura e deve tradurla.” Alla luce di queste considerazioni, insieme a molte altre che tralasciamo per ragioni di spazio, ci sorge spontanea la domanda: ma, allora, quello che vediamo in un’immagine dipinta non è altro che un’illusione?
Un’irresistibile illusione che il pittore costruisce “ad arte” per ingannare il nostro occhio, confidando sul fatto che, anche nella visione diretta, gli oggetti tridimensionali proiettano una forma bidimensionale sulla superficie della retina dell’occhio. Di fatto si tratta di un’illusione, anche se molto differente da quelle canoniche prodotte nei laboratori dai percettologi, in quanto in questo caso sono i procedimenti intrinseci della figurazione pittorica stessa a tradurre i meccanismi della percezione visiva e non il contrario: è la pittura che traduce la visione in figurazione.
Per Helmholtz questa “illusione” percettiva si basa sul fatto che l’osservatore non inferisce la presenza della tela, ovvero rimuove il supporto dell’immagine e concentra la sua attenzione visiva unicamente sulla presenza degli oggetti dipinti, ciò fa sì che questi appaiono come se fossero al di là della tela stessa, quindi non più nell’immagine ma in uno spazio reale.
Ciò che induce Helmholtz a ritenere convincente questa teoria è avere riscontrato che “esiste in realtà uno stretto legame tra le caratteristiche della tecnica pittorica, che le ricerche di ottica fisiologica ci hanno indotto a considerare, e i fini più elevati dell’arte.” Tuttavia alla conclusione delle sue conferenze per definire il fine della pittura la sua argomentazione è costretta a mutare il registro lessicale, connotando il percepire come un sentire e sostituendo le sensazioni con i sentimenti, sostiene che siamo autorizzati a pensare che “il segreto della bellezza artistica, la meraviglia del piacere che proviamo in sua presenza, si fondi essenzialmente sul sentimento del fluire lieve, armonico e vivido che … rendono pienamente intuibili leggi finora celate e permettono di guardare nell’intima profondità del sentimento del nostro stesso animo.” Solo guardando la pittura da questo angolo visuale appare chiara la comprensione del potere che l’arte esercita sull’animo umano, in una misura anche superiore alla realtà.