La scrittura e l’azzardo. Flaiano, 50 anni dopo
Il primo fotogramma è quello che vede un uomo di fronte alla possibilità di prendere una scorciatoia. Siamo in Etiopia, durante l’avvilente campagna coloniale italiana del 1935-1936, l’uomo è un giovane tenente, è sopravvissuto a un incidente di camion e decide di abbandonare il suo compagno di viaggio per avventurarsi da solo nella boscaglia, convinto di poter arrivare in breve alla città dove un dentista lenirà il suo mal di denti. Mai scelta si sarebbe rivelata più sbagliata. Come prevedibile, infatti, l’uomo perde la strada e si inoltra in un viaggio che lo porterà a uccidere una donna indigena e a venirne – realmente o simbolicamente – contagiato: un morbo senza nome, il cui tanfo lo inseguirà anche quando riuscirà finalmente ad abbandonare quella maledetta Africa.
La scorciatoia è il primo capitolo di Tempo di uccidere, romanzo con cui Ennio Flaiano – di cui ricorrono oggi i cinquant’anni dalla morte – vince a sorpresa la primissima edizione del Premio Strega, nel 1947. Un esordio in grande stile, si potrebbe dire, sebbene quella vittoria avesse suscitato gli attacchi della critica più ideologicamente schierata, che vedeva in lui un esponente della destrorsa scuderia longanesiana. Una scorciatoia inattesa, forse, che aveva permesso a un giovane giornalista di origine abruzzese, sbarcato a Roma pieno di ambizioni e spinto dalla passione per il teatro, di diventare subito una figura di rilievo del panorama letterario italiano del dopoguerra. E tale sarebbe rimasto, Flaiano, sebbene da una posizione sempre marginale, o volontariamente defilata. Come ogni scorciatoia che si rispetti, infatti, anche quella vittoria lo aveva condotto in un vicolo cieco, con un romanzo che mal si conciliava con il clima neorealista di quegli anni (e che anzi, a detta di molti, con i suoi sprofondamenti psicologici rievocava le atmosfere tipiche di un “romanzo della crisi” che ci si voleva lasciare alle spalle). In realtà Tempo di uccidere era un romanzo del colonialismo in straordinario anticipo sui tempi, capace di porsi in serrato dialogo con quei capolavori che avevano saputo interrogare la coscienza dell’uomo bianco di fronte all’alterità nera (come Cuore di tenebra o il Viaggio al termine della notte); ma nessuno se ne accorse. Dopo quella prova, Flaiano abbandonò la forma romanzo, per dedicarsi a narrazioni brevi o addirittura brevissime, a scritti di cronaca e costume, a recensioni teatrali, oltre alle ben note sceneggiature per il cinema (con Fellini, ma non solo).
Il paradosso che accompagnò la vita di Flaiano, cronista cinico di una società dello spettacolo di cui pure si sentiva estraneo (e molti in questo senso hanno letto la parabola del Marziano a Roma, 1954), si è replicato anche nella sua vicenda postuma di autore sempre presente in libreria, grazie alla cura solerte degli editori (Rizzoli, poi Bompiani con l’edizione delle Opere, infine Adelphi che sta riproponendo oggi tutti i suoi titoli) e di un manipolo di studiose filologicamente avvertite (su tutte Anna Longoni e Maria Corti, a cui si deve aggiungere anche Gino Ruozzi), eppure scarsamente letto e difficilmente storicizzato – e chissà che non possano aiutare una migliore ricezione l’appena uscito Diario di un’estate marziana di Tommaso Pincio e la riedizione di Ennio l’alieno di Renato Minore e Francesca Pansa.
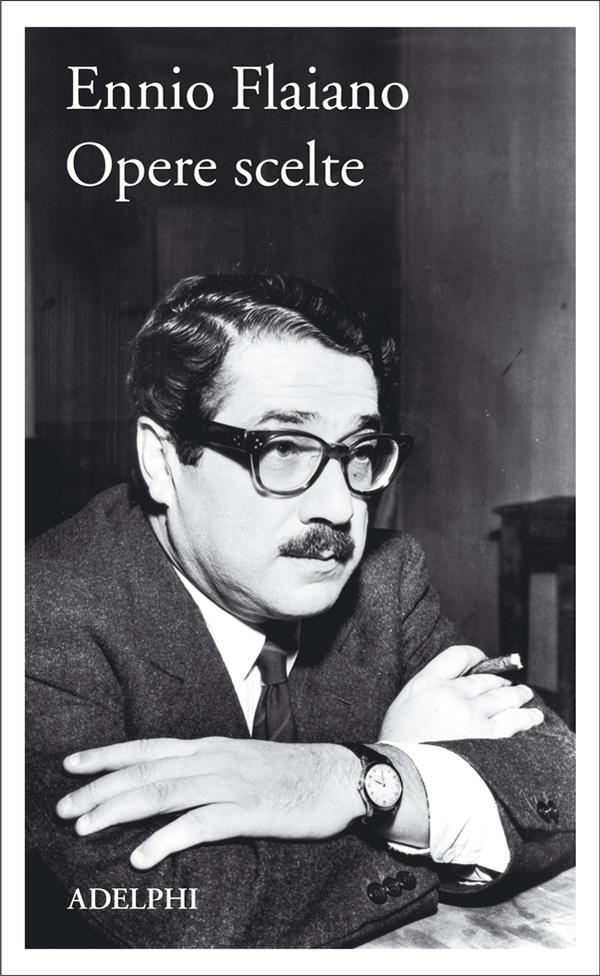
Scrive Flaiano nel suo Frasario essenziale: per passare inosservati in società: «La disattenzione è il modo più diffuso di leggere un libro». Senz’altro immaginava che quel destino sarebbe toccato un giorno anche ai suoi libri, afflitti dalle tante “leggende” che, in questi decenni, hanno impedito una lettura all’altezza del valore della sua opera. Ecco allora il Flaiano autore dell’unico romanzo che mal si concilia con il Flaiano aforista, mentre il Flaiano cronista dialoga distrattamente con il Flaiano scrittore pigro e annoiato, che tutto appunta e nulla mai sistema per la pubblicazione. Tante leggende quanti sono stati i profili dello scrittore, tutti peraltro ad alta vocazione di marginalità – l’umorista, l’autore di racconti e microracconti, lo sceneggiatore e via dicendo. Come se tutti questi profili poi non rientrassero in un’unica, più complessa e anche dolente identità autoriale.
È forse per questo che la vulgata ha privilegiato nel tempo, nella vasta bibliografia di Flaiano, i libri che ne potessero confermare la fama del dissipatore, dello scrittore votato all’incompiutezza, ma anche a un astuto riuso di brani nati per una destinazione e reintegrati nel tempo in compagini testuali più ampie (capita, ad esempio, a diverse tessere del postumo Diario degli errori, 1976). La raccolta di “pezzi sparsi”, come Il diario notturno (1956) e Le ombre bianche (1972), è diventata la cifra distintiva di un maestro dell’inventio, sempre troppo impegnato a fare altro – o a far nulla – per dare a quella prima scintilla un adeguato sviluppo narrativo (o per organizzare in una struttura testuale efficace quella miriade di frammenti).
In questo modo la propensione all’estrema concisione dell’appunto, al lampo che può contenere un’intuizione o un episodio da inserire poi in un mosaico più ampio, ha oscurato la propensione complementare al “rigonfiamento” del racconto, che riconosciamo quando Flaiano si cimenta in una narrazione lunga o “lunghetta”, com’è nel caso dei dittici di racconti contenuti in Una e una notte (1959) e Il gioco e il massacro (1970). E tuttavia è in queste opere che si stende il ponte che consente di collegare le isole dell’opera di Flaiano.
Questi racconti ci mostrano personaggi disorientati, diversi tra loro ma tutti in qualche modo incarnazioni del borghese annoiato e indolente; non sanno bene dove andare e quindi si mettono in cammino, in attesa che il destino, o il caso, offra loro qualche sorpresa interessante (una sorpresa che molto spesso ha le fattezze di una donna, che risveglia l’atavico istinto predatorio dell’uomo).
Che si tratti del cielo stellato in cui si avventura l’astronave su cui viene caricato il Graziano di Una e una notte o la New York in cui passeggia lo scrittore Giorgio Fabro in Melampus o ancora la campagna laziale percorsa in auto dall’eponimo protagonista di Adriano, in questi racconti viene messa a tema l’erranza (l’errore all’origine dell’errare), un’inconcludenza che si trasforma spesso in quell’ossessione che aveva afflitto anche il tenente di Tempo di uccidere. Un’ossessione che viene spesso sfogata nella scrittura. Pullulano nell’opera di Flaiano i diari, i taccuini e le scritture quotidiane, e in questo senso possono essere interpretate anche le sue raccolte di pezzi brevi, espressioni di una nevrosi scrittoria propria di chi, di fronte all’insipienza o all’incomprensibilità della vita quotidiana, non può far altro che affidarsi alla penna.
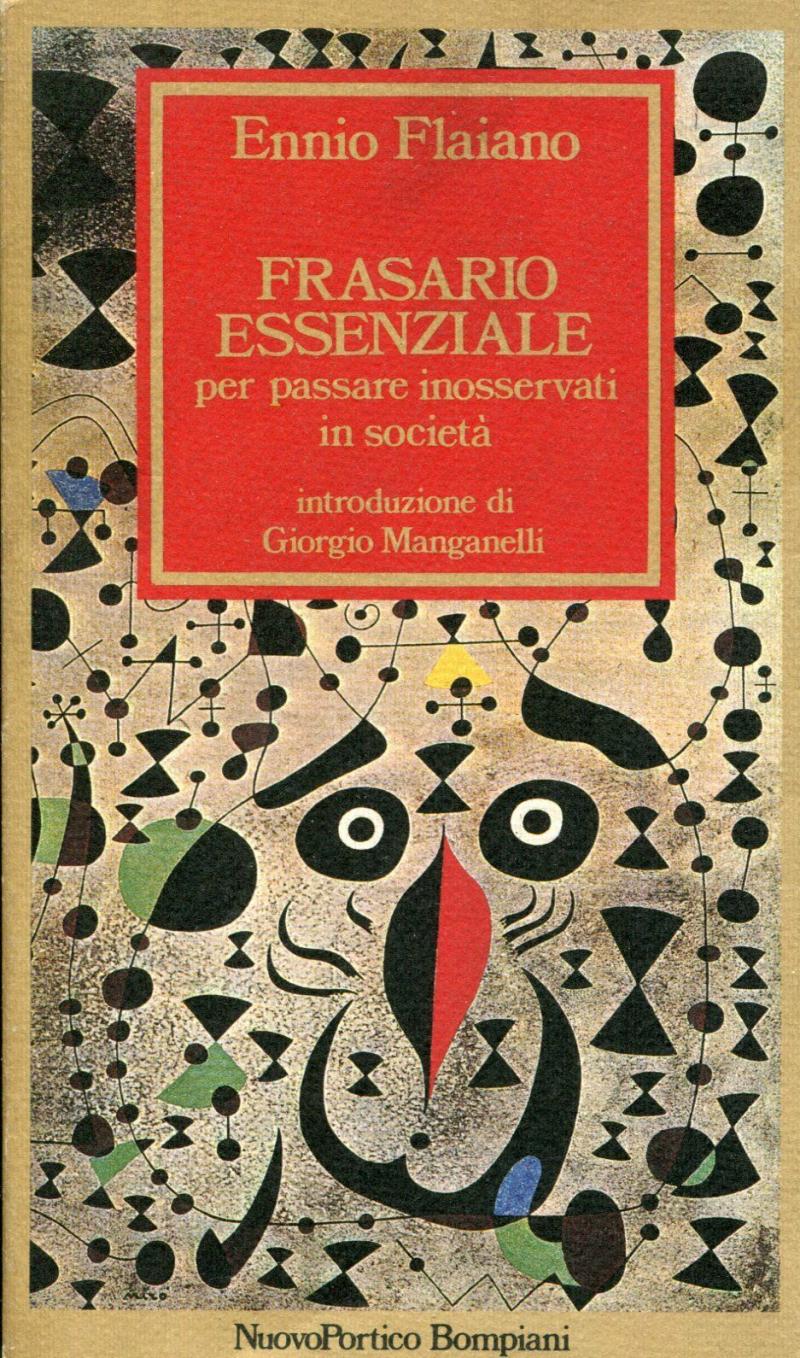
Aveva visto giusto Giorgio Manganelli, quando, introducendo il Frasario essenziale, aveva definito tutta l’opera di Flaiano come un grande zibaldone. Calderone in cui possono rientrare massime di fulminante intelligenza, ma anche notazioni banali, osservazioni distratte, proprie di una scrittura continua ma a bassa intensità, che torna indietro o si proietta in avanti secondo traiettorie imprevedibili. Lo zibaldone, diceva sempre Manganelli, è un libro fatto solo di didascalie a un’opera che è in realtà la vita vera, che resta sempre fuori dalla letteratura. Una vita che Flaiano tentò così di proteggere, anche per il tanto dolore che gli provocava.
In Tempo di uccidere un orologio rotto è l’oggetto magico che segnala la perdita di contatto da parte del giovane tenente con il tempo della storia – quella storia di violenza e privilegio di cui era incosciente protagonista – per entrare in un tempo nuovo, sospeso, ancestrale o biblico, il tempo dell’espiazione, ma anche di un’esperienza spaesante – che pure egli avrebbe dimenticato rapidamente prendendo il mare per l’Italia. Da un certo punto di vista l’orologio rotto può essere considerato il simbolo dell’intera opera di Flaiano, insospettabile nipotino di quel Tristram Shandy che raccontando la propria vita istante per istante sperava di rimandare all’infinito il confronto con la morte.
Radicalizzando il modello sterniano, Flaiano fa esondare l’espansione divagante dal singolo libro per condurla lungo un’intera opera, frammentaria e labirintica. L’arabesco diventa così la figura adatta a rappresentare l’accumulo disordinato di pezzi difformi, l’erranza della scrittura che, dietro l’apparente levità, dietro il sorriso malinconico, nasconde la disperata volontà di fermare il tempo. Scrivere per non dover vivere, insomma; riempire diari e taccuini come esorcismo contro la vita vera. E leggere Flaiano, oggi, significa in qualche modo rendere giustizia a quell’azzardo. Destinato a fallire come ogni vera sfida letteraria.









