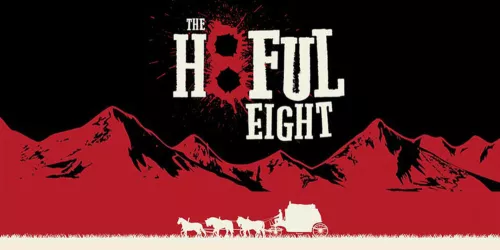Otto Tarantino e mezzo
In primissimo piano c’è un crocifisso coperto di neve, l’inquadratura a poco a poco si allarga e mette a fuoco una diligenza tutta nera che avanza, il cocchiere è irriconoscibile, il galoppo dei cavalli è leggermente rallentato, la musica ossessiva e manierata. La tempesta che spazza il paesaggio per i due terzi del film è definita spooky nella sceneggiatura, cioè spettrale, paurosa come lo è un fantasma, e «l’estetica del crocefisso mostra un’origine slava, la scultura sembra essere stata messa lì già secoli prima dell’arrivo dei padri pellegrini». Sono elementi che fanno pensare a The Fearless Vampire Killers di Polanski o al Dracula di Coppola. Invece è l’inizio del secondo western di Tarantino, The Hateful Eight. Se Django Unchained denunciava con la sequenza d’apertura il genere d’appartenenza, H8 è incoerente come Inglourious Basterds, il film di guerra che comincia come uno spaghetti western. H8 è una vicenda western dentro una cornice detective-horror: i dieci personaggi principali rimangono intrappolati in un rifugio e nessuno di loro risalirà più sulla diligenza che lo doveva portare alla città di Red Rock.

Lo eight del titolo non sono sicuramente gli occupanti della diligenza (5) né quelli del rifugio (10). Chi sono, allora? C’è da pensare che la dichiarazione autocelebrativa nei titoli di testa dia la soluzione: The 8th Film by Quentin Tarantino. Dunque The Hateful Eight è una specie di Maledetto 8½ (se Kill Bill conta più di uno e meno di due). Perché hateful? Probabilmente un film non può essere così odioso o molesto per nessuno quanto per chi lo ha fatto. I dieci protagonisti sembrano esserne consapevoli: non sanno come comportarsi, come passare il tempo, come “andare avanti”, cosa che capita agli sceneggiatori in difficoltà. Il mestiere di metteur en scène integrale è davvero hateful, ingrato, soprattutto se uno lo fa per l’ottava volta. Almeno in Reservoir Dogs c’era da aspettare gli ordini del capo e i personaggi lasciavano a turno la rimessa per vedere cosa succedeva fuori. Adesso, invece, è difficile anche soltanto aprire la porta, perché fuori la tempesta infuria. Non c’è nulla da fare, c’è soltanto da capire chi è chi, chi è arrivato per caso e cerca riparo e chi, sotto le mentite spoglie del viaggiatore, è lì perché vuole liberare l’assassina Daisy.
Ambientato una decina d’anni dopo la fine della guerra civile, il film si svolge in luoghi neutri, come lo spazio della diligenza su cui viaggiano Ruth e Daisy, che per definizione non appartiene a nessun luogo. Militarmente neutrale è lo spazio del Wyoming, che divenne Stato soltanto nel 1890, in cui non ci fu nessuna battaglia e che l’immaginario collettivo non associa né all’Unione né alla Confederazione (sarebbe un po’ come ambientare a Lipari un film sulle conseguenze dell’8 settembre). Neutro è il tempo atmosferico e il paesaggio senza sole, senza luna, senza terra e senza cielo, perché sole, luna, terra e cielo sono stati cancellati dalla tempesta. La neve e il freddo sono ovunque, confondono la notte e il giorno. Se è vero che il senso del western è di mettere alla prova l’appartenenza del protagonista e della sua cerchia al mondo che abitano – per cui, da una situazione iniziale di scollamento e pericolo, l’azione del duello fa muovere i protagonisti verso la conciliazione finale –, in H8 non c’è nessuna possibilità di saldare insieme i personaggi e l’ambiente. L’ambiente è significato dalla montagna azzurra che buca il nero dello schermo all’inizio e che rimane in campo lunghissimo con la sua irrimediabile indifferenza verso quello che il film racconterà. Dopodiché l’unico spazio dell’azione diventa l’haberdashery di Minnie, una cosa di difficile definizione anche per un americano, via di mezzo tra un saloon, una merceria e un rifugio. È a suo modo confortevole, ha cibo, bevande, suppellettili, calore, la reclusione dei dieci potrebbe andare avanti indefinitamente, ma allo stesso tempo non permette a nessuno di riposarsi, è vietato chiudere gli occhi, perché nasconde pericoli e trabocchetti, la morte può arrivare da chiunque e da ogni angolo e quando l’azione finisce (ai due sopravvissuti non rimane che attendere anch’essi la morte) diventa la scenografia di un’esecuzione capitale.
Chi sono i “pessimi dieci” del film? Uno è Kurt Russell, Ruth “The Hangman”, ma è ancora lo Stuntman Mike che terrorizzava il Texas e il Tennessee in Death Proof. Finalmente è riuscito mettere le mani su una preda, Daisy Domergue, che è “The Bride” di Kill Bill, ammanettata, resa innocua e che le prende soltanto invece, anche, di darle. Una volta arrivati al rifugio Daisy è costretta alla quasi immobilità e diventa il perno conficcato nel terreno intorno al quale ruotano gli altri, mentre la sua faccia si copre di sangue e diventa a poco a poco la maschera di Carrie, grossomodo come succedeva con l’orologio caricato a morte di Tim Roth, il poliziotto infiltrato che scandisce il tempo di Reservoir. Anche Stuntman Mike non è più quello di prima: è invecchiato e colle donne è violento non per passione ma solo per mestiere. Ruth è detto “The Hangman”, cioè il Boia, perché invece di ammazzare i fuorilegge e consegnare i cadaveri allo sceriffo – come fanno tutti i bounty hunters ragionevoli – ha l’abitudine di catturarli vivi. Una briga non indifferente, come gli fanno notare più volte: perché lo fai? perché rendersi la vita così difficile, perché il lavoro dev’essere così duro? Lui risponde che è «per non togliere il lavoro al boia». Quello che Ruth vuole è «sit back on that wagon wheel, watch and laugh!», starsene comodamente seduto, guardare l’impiccagione e ridere, «sentire con le mie orecchie il collo che si spezza», come se il patibolo fosse una sala con il Dolby-surround. Ruth è preoccupato che qualcuno gli porti via Daisy prima dell’esecuzione, rovinandogli così la festa, rendendo impossibile lo spettacolo. La sua ossessione è che ci siano accordi sottobanco tra i passeggeri della diligenza oppure (come, infatti, è) tra gli occupanti del rifugio.
I dieci di H8 sono versioni in sedicesimo dei basterds degli altri film di Tarantino. In tanti tornano, ma sono peggiorati. Non solo Ruth-Stuntman Mike e Daisy-Bride. L’Oswaldo Mobray di Tim Roth è il Dr. Schulz di Django. Schultz era un bounty hunter tedesco e un po’ dandy, Oswaldo affetta un inglese british e si atteggia a dotto uomo di legge, ma è un delinquente (il cui vero nome è Hicox, forse il nonno del tenente Archibald Hicox di Inglourious con cui ha in comune il piacere di bere di «whiskey e acqua»). Michael Madsen-Joe Gage è una lontanissima eco del Mr. Blonde di Reservoir (appare la prima volta dietro una tenda di catene che pendono dal soffitto e fanno pensare a strumenti di tortura), ma è soprattutto il Budd di Kill Bill, sempre più imbolsito e vile: la sua arma è un’improbabile boccetta di veleno, alla prima sparatoria alza le mani e si arrende, per poi a tradimento tirare fuori un revolver da sotto il tavolo.
Budd è, insieme a Oswaldo, il messicano Bob e Jody, un membro della banda Domergue: hanno fatto fuori i proprietari del rifugio, fanno finta di essere degli avventori, aspettano Ruth per ammazzarlo e liberare Daisy. Tutto andrebbe probabilmente secondo i loro piani, ma la diligenza ha raccolto per strada anche il rinnegato sudista Chris Mannix e un altro bounty hunter, Marquis Warren-Samuel L. Jackson, ex-ufficiale dell’Unione e nero, così da uno gli uomini da uccidere sono diventati tre.

«Domergue’s got a secret», dice la voce off del narratore (che poi è Tarantino), Daisy sa che Budd ha versato il veleno nel caffè perché Ruth e gli altri ne bevano. Ma dal punto di vista di Ruth tutti gli ospiti del rifugio hanno qualcosa da nascondere. «Just a bunch of nefarious guys in a room, all telling backstories that may or may not be true», è la definizione sommaria che Tarantino dà dei personaggi del film, un mucchio di disgraziati che, studiando ciascuno le mosse degli altri (non per nulla vicino al camino c’è una scacchiera), parlano del proprio passato e non necessariamente dicono la verità. Warren porta sempre con sé una lettera del presidente Lincoln che dovrebbe funzionare come una specie di lasciapassare morale, ma è un falso. Mannix dice di essere il nuovo sceriffo di Red Rock, ma c’è il forte sospetto che voglia solo farsi dare un passaggio e guadagnare un po’ di autorità tra i compagni di sventura. Il generale della Confederazione Smithers – l’unico a trovarsi nel rifugio davvero per caso – nasconde a Ruth e agli altri quel che è accaduto poco prima, cioè l’uccisione di Minnie e dei suoi per mano della banda Domergue. Quelli della banda si spacciano per rispettabili viaggiatori ma nulla significano i documenti d’identità presentati da Oswaldo, che afferma di essere il nuovo boia di Red Rock. Gli ordini di esecuzione e i mandati che in Django davano il via libera ai portatori, sono diventati carta straccia, dei falsi clamorosi, come la lettera di Lincoln. Jody, invece, non ha un segreto, ma “è” un segreto: il capobanda nonché fratello di Daisy si è nascosto nello scantinato prima dell’arrivo di Ruth e aspetta il momento opportuno per agire. Gli unici a non avere qualcosa da nascondere sono Ruth – perché l’occhio del regista non ha un dentro, è tutto estroflesso verso lo show – e O.B., il cocchiere – perché O.B. è il caso che fa incontrare gli altri nel rifugio, incarna la funzione narrativa della coincidenza, non ha storia perché è l’occasione che mette in moto la storia.
«Tu che vuoi scrivere storie, perché non mi racconti la storia che ti ha portato fin quassù?», è la domanda del sospettoso Ruth a Joe, che, per darsi un atteggiamento davanti all’uomo che vuole ammazzare, finge di scrivere un diario. Ma è la domanda che lo spettatore vorrebbe fare a tutti i personaggi del film, senza per lungo tempo trovare una risposta. L’incertezza assoluta sul dove e il quando la violenza esploderà allarga a dismisura lo spazio di per sé angusto del rifugio. La dilatazione dello spazio e del tempo è una situazione tipica, appunto, dell’horror, che non conosce il luogo e l’ora in cui il mostro o il vampiro farà la sua comparsa, quando invece nel western si sa benissimo che gli indiani devono spuntare fuori da quelle alture e che il fuorilegge uscito di galera torna in città con il treno di mezzogiorno.
Un primo tentativo di mettere ordine in questo spazio incerto è di Oswaldo, che propone di dividere il rifugio in due: da una parte gli yankees dai modi spicci, dall’altra i nostalgici del romantico e laido Sud, ma serve a poco, l’unico effetto sortito è che la macchina da presa frammenta ancora di più il già sparpagliato spazio dello haberdashery (come ha scritto Dana Stevens su Slate). Anche Ruth vuole fare ordine e così decide di presentare sé e la ragazza agli altri occupanti: «Okay everybody, hear this. There is Daisy Domergue…». Ruth è il regista della situazione. Vuole mettere in chiaro che cosa ci sta a fare lui lì dentro e vuole che gli si ubbidisca. L’inquadratura stringe su Ruth e Daisy (probabilmente la sequenza più memorabile del film) e gli altri personaggi sono mostrati ad uno ad uno con un montaggio lento che giustappone i pezzi di uno spazio non-totalizzabile.
Questa incapacità di integrazione non riguarda soltanto le immagini, ma anche la sceneggiatura. Il suo tratto caratterizzante è la sfasatura. Se questa volta Tarantino rinuncia alla destrutturazione temporale degli altri film, in H8 il tessuto del racconto è più sfilacciato di quel che sembra. La vicenda prende le mosse da alcune coincidenze e affinità che sembrano promettere uno sviluppo organico: due bounty hunters (Ruth e Warren) che già si conoscevano adesso s’incontrano per caso su un sentiero innevato del Wyoming. Un noto rinnegato delle squadracce punitive del Sud post-bellico, Mannix, deve salire sulla diligenza in cui c’è un ex-soldato nero dell’Unione. Smithers aveva combattuto nella stessa battaglia in cui, sul fronte avverso, c’era anche Warren, il quale, in altre circostanze, sembra essere stato l’uccisore di suo figlio. Ma queste coincidenze producono soltanto una serie di azioni divergenti a mano a mano che il film procede e non riescono mai a raccogliere più di tre o quattro personaggi nella stessa inquadratura (infatti O.B, l’uomo-coincidenza, è il primo a morire). Il segno più evidente della sfasatura è che le due figure principali, Ruth e Warren, si sono distribuiti male i ruoli. Per uscire vivi dal rifugio dovrebbero essere una persona sola e invece sono due: Ruth, nella sua paranoia, è certo che qualcosa non va bene dentro il rifugio, ma non sa dire cosa. È troppo rozzo per notare quelle incoerenze (una caramella nelle scanalature del pavimento, un posto vuoto nella teca dei dolciumi, la porta che nessuno ancora ha riparato…) che invece non sfuggono allo sguardo da detective di Warren, il quale è però troppo compiaciuto della propria capacità d’osservazione per darsi da fare al momento giusto. Sfasata è la voce off dello storyteller che prende la parola per la prima volta verso i due terzi del film e, più avanti, per introdurre un flashback che non aggiunge quasi nulla alla struttura narrativa.
L’incertezza sul passato dei personaggi e sulle presenti intenzioni dà una funzione anomala ai piani fissi (assai più numerosi che negli altri film di Tarantino) che di solito vivono di una tensione misurabile fra quella che i teorici del cinema chiamano l’“azione-pretesto” (quel che viene agito esplicitamente dai personaggi, per esempio: mangiare assieme) e l’“azione-reale” (il significato intenzionale dell’azione, per esempio: attendere il momento buono per ammazzare il vicino di tavola). La cecità dello spettatore-Ruth e del detective-Warren circa le intenzioni che i tre banditi mascherano dietro la nonchalance di avventori occasionali apre la situazione a sviluppi del tutto imprevedibili e aumenta a dismisura la distanza tra l’aspetto pretestuoso e quello reale dell’azione. Al punto da rendere necessario lo scoppio della violenza per dare una direzione alla vicenda: solo la violenza, infatti, identifica l’aspetto pretestuoso e quello reale con un’inequivocabilità di cui neppure le scene di sesso sono capaci (l’unica azione-pretesto che non nasconde nessuna azione-reale, perché è già per intero azione-reale, è picchiare e ammazzare).
L’altra peculiarità della violenza è di non essere immediatamente reciprocabile. Il violento colpisce senza essere toccato (la velocità dello schiaffo o del pugno che feriscono e si ritraggono prima che il colpo diventi tatto). Tutto congiura a rendere impossibile un vero piano d’insieme: il rifugio – come dice Joachim Lepastier, nella sua per altro impietosa recensione sui Cahiers – raccoglie parecchi specimina antropologici dell’America con i suoi vizi capitali, violenza, razzismo, cupidigia. Neppure razzismo e cupidigia sono comportamenti centripeti, che raccolgono, ma centrifughi, esplosivi, non possono essere immediatamente reciprocati. Non tengono insieme nello spazio ma, in mancanza di motivi più validi, fanno avanzare il tempo. Infatti, chi li subisce vuole farli subire ad altri: dopo che le abbiamo prese c’è sempre qualcuno di più debole da angariare, se il prezzo è congruo anche un fuorilegge può trasformarsi in un cacciatore di taglie (forse Mannix non ammazza Warren solo perché Daisy non gli permetterebbe d’incassare i 50.000$ di ricompensa per il corpo del fratello) e i perseguitati sono desiderosi di trovare altre minoranze da perseguitare (il maggiore Warren si è guadagnato la fiducia dei nordisti ammazzando pellerossa; nel flashback apprendiamo che Minnie era una nera che aveva affisso all’ingresso del rifugio il cartello Niente cani o messicani). Per questo non c’è niente di più vitale della morte e della violenza nei film di Tarantino. Ogni volta che esplode, un pezzo di violenza si aggrappa addosso sopravvissuti, come l’avambraccio di Ruth a Daisy, costringendo l’azione a continuare.
Quando sono rimasti in tre, tutto ciò che c’è da fare è esaudire il desiderio del regista-Ruth: non ammazzare Daisy con la rivoltella ma allestire lo show dell’impiccagione: «Hold on Daisy, I wanna watch!», la schernisce Warren. Ci si ripaga per essere finiti nel posto sbagliato al momento sbagliato con uno spettacolo: l’unico piano d’insieme del film raccoglie in plongée Warren, Mannix e Daisy che pende dalla trave. Tutti i pezzi dell’America che resta sono tenuti insieme in modo posticcio dalle parole del presidente Lincoln, che Mannix legge ad alta voce. «That’s a nice touch!», Mannix quasi sorride e si complimenta con Warren per la chiusa ad effetto della lettera apocrifa. Poco importa se di lì a poco moriranno entrambi dissanguati. Ma verso cosa esplode quest’ultima violenza, dopo la quale per forza di cose non può più succedere nulla? A cosa fa segno? Alla neve, la neve là fuori: la neve del cinema, scriveva Bazin, «non è estranea a una confusa coscienza d’un simbolismo di morte […]. Sotto l’uniformità di un colore che poi “uno” non è, perché in potenza li contiene tutti, la neve riconcilia misteriosamente la vita e la morte».
Leggi anche:
Marco Belpoliti, Pulp Fiction vent'anni dopo.