
M - la serie: ritratto di un divo
M come medium
Se, come vuole il titolo della miniserie di Joe Wright (e prima ancora il romanzo di Antonio Scurati da cui è tratta), Benito Mussolini è il figlio del secolo, l’immaginario del Novecento, a sua volta, è figlio anche del cinema e delle mitografie che ha contribuito a creare e diffondere. Ci sono i rimandi espliciti, volti a restituire al medium un ruolo di primo piano attraverso l’uso del found footage (è il caso delle sequenze tratte da A Noi!, un “dal vero” del 1922 che riprende le fasi della marcia su Roma); ma non mancano le allusioni più sottili: uno dei tanti primi piani di M (Luca Marinelli) che contrappuntano il racconto, appare deformato dal riflesso in un bacile d’acqua increspata, richiamando una sequenza del primo Pinocchio cinematografico (Giulio Antamoro, 1911), in cui, proprio grazie a questo espediente, il burattino scopre la propria trasformazione in asino.
A proposito di trasformazioni, M offre al protagonista un catalogo di cambi d’abito degni di Leopoldo Fregoli, incarnate da un uomo che ama il potere e in esso proietta una propria immagine idealizzata, già divistica. In una delle ultime puntate, vediamo M, ormai a capo del governo, soffermarsi adorante davanti a un busto bronzeo che lo ritrae – dono di Margherita Sarfatti (Barbara Chichiarelli) – che richiama Dux, opera realizzata da Adolfo Wildt. Durante la Resistenza, una copia della scultura, recentemente esposta al Mart, venne deformata dalle picconate inferte da partigiani divenendo una testimonianza “aumentata”, ma quanto mai fedele, della tragica sorte che attese il dittatore.

M come maschera
Pinocchio, quintessenza di umanità e italianità, non è l’unico riferimento ai giochi di specchi che caratterizzano il protagonista della serie. Di Mussolini emerge un ritratto sanguigno e anfibio: da un lato imbonitore e sensale di grana grossa, tendenzialmente vigliacco; dall’altro, rabdomante opportunista, capace di fiutare la volontà delle masse sulla scorta delle teorie di Georges Sorel. Il protagonista è un caleidoscopio di maschere, intuizioni e plagi, assorbiti in misura diversa tanto dai suoi sgherri quanto da Gabriele D’Annunzio (Paolo Pierobon) e Filippo Tommaso Marinetti (Stefano Cenci), tessere di un mosaico che ne compone il ritratto. Questi ultimi sono gli unici personaggi a cui la serie concede di guardare direttamente in macchina, sebbene non permetta loro di rivolgersi allo spettatore, un privilegio riservato al protagonista e alla moglie Rachele (Benedetta Cimatti): un espediente su cui torneremo.
Se in Italia si è mai fatto i conti con il cosiddetto “duce” ciò è avvenuto anche attraverso il cinema e la televisione, che hanno offerto utili momenti di comparazione. Considerando il secolo che ci separa dai fatti, l’immagine interiorizzata del dittatore – divinizzata e, dunque, nell’ambito della celluloide, divistica – riemerge negli epigoni grottesco-comici presenti nei vari Amarcord felliniani. Tra le righe della performance di Marinelli si riconoscono sfumature che rimandano a Ettore Petrolini. In particolare al suo Nerone, caricatura di un imperatore inadeguato, sorta di Bacco assetato di consenso, il cui delirio si sublima in un paradossale duello a colpi di “bravo” e “grazie”. Non manca poi un omaggio a Totò, i cui abiti chaplinani (bombetta, marsina e gilet) sono rievocati nel M sansepolcrista; così come nel M vestito da aviatore si può trovare il Vigile (Luigi Zampa, 1960) di Alberto Sordi, colto con le braccia ad anfora a offrire un cortocircuito attoriale. L’abito, in M, contribuisce a fare il monaco.


Marinelli pare attingere anche da un immaginario caricaturale più recente, tra radio e televisione: ad esempio la macchietta Ermanno Catenacci – più mussoliniana di Mussolini – interpretata da Giorgio Bracardi, per approdare al turpiloquio romagnolo di un’altra filiazione ducesca che si riconosce nell’assessore Palmiro Cangini alias Paolo Cevoli, fino all’eloquio scandito à la Guido Notari reinterpretato da Corrado Guzzanti per Fascisti su Marte. Sfumature percettibili per quanto dosate per evitare alla performance mimetica il rischio della banalizzazione.
Spazio è dato al Mussolini oratore istrionico: la mascella volitiva, le labbra torte, gli occhi spiritati e le mani saettanti, sono caratteristiche immortalate dal Luce, spesso incipit per sequenze di violenza narrate con il piglio visionario del kubrickiano Arancia meccanica (1971), rappresentate nella loro brutale “creatività” animalesca. La fiction, in questo senso, non vuole edulcorare la ferocia dello squadrismo, restituendone tutta l’intensità cruda e irrazionale, evidenziando in M la figura del mandante vigliacco che non si sporca mai le mani.
Questo M è uno, nessuno e centomila, lo è mentre di volta in volta si atteggia a intellettuale o si improvvisa comandante. Ma egli è convinto di essere una bestia dotata di fiuto ancestrale, qualità ben più importante per perseguire il potere rispetto alle apparenze di stratega o di profeta con le quali di volta in volta si presenta al prossimo. E come Totò anche M utilizza la lingua in modo strumentale, per abbagliare l’interlocutore.

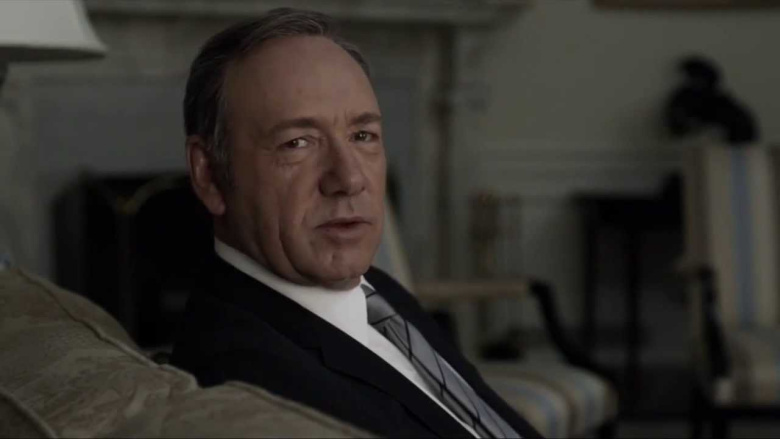
M come metamorfosi
M è un camaleonte che frequenta il raffinato salotto Sarfatti e i teatrini scalcagnati gremiti di reduci che lo venerano (o lo vogliono far fuori), pur comprendendo poco di ciò che egli, talentuoso improvvisatore, ordina loro di eseguire al di là delle spedizioni violente che costellano quegli anni. La volgarità di Mussolini emerge non solo nel turpiloquio autenticato dall’accento romagnolo. Questo aspetto, lungi dal voler indurre alla caduta comica, sottolinea l’anima proletaria di M, rendendo verosimile una interpretazione che non è mimetismo.
Nelle polemiche dedicate alla serie emerge la cosiddetta rottura della quarta parete, ossia l’insistito appello diretto allo spettatore da parte di M che rimanda – per rimanere nell’ambito della serialità contemporanea – al Frank Underwood interpretato da Kevin Spacey in House of Cards (2013-2018). Anche in questo caso l’intento appare chiaro: mettere alla prova l’arte di seduzione di M facendola traboccare dai limiti che garantiscono la sospensione dell’incredulità. L’appello restituisce l’impressione di quella “faccia sempre in vista” – come ebbe a scrivere Italo Calvino in un celebre articolo-saggio del 1983, I ritratti del Duce – parte di una ventennale ossessione istituzionalizzata. M è l’incarnazione del perdente di successo, assistito dalla fortuna e dal fiuto (ma anche tradito da entrambi), circondato da persone pronte a perdonarne i tradimenti col miraggio di vampirizzarlo una volta al potere. Tutto ciò perché, nonostante M sia un dilettante incurabile, riesce a incantare i serpenti. È un personaggio che sembra uscito dalla penna di Plauto, reincarnazione del miles gloriosus. Per dirla con Carlo Emilio Gadda, tra i più sferzanti esegeti della parabola mussoliniana, M è un erotomane, dotato di un’incontenibile fame di potere: M come mostro, visto l’ammiccamento al capolavoro (1931) di Fritz Lang.
M ritratto nei primi due episodi appare intriso di miseria, tanto umana quanto materiale. L’umile casa in cui Rachele vive con i figli ne è simbolo. Egli è l’arrivista che pone quale meta un miraggio, dotato di sufficiente cinismo e indifferenza necessari per andare avanti senza alcuno scrupolo accessorio. Un divo di massa che, a suo stesso dire, è odiato proprio perché amato.
M come manipolazione
M, giocatore d’azzardo, è roso dall’imminenza della catastrofe. Le fasi della macchinazione, che sfocia in una sorta di insurrezione disomogenea e velleitaria, sono sottolineate dalle mutevoli espressioni e dai silenzi accigliati del protagonista, controcanto ai medesimi atteggiamenti degli uomini delle istituzioni liberali. La miniserie mette in risalto una galleria di poker face: figure in attesa che qualcun altro risolva la situazione al posto loro. L’aurora del regime si conferma fosca e ridicola a un tempo, ed è accentuata dall’uso di un registro grottesco che illustra l’ascesa di uomo nuovo perché improbabile, se giudicato secondo la tradizione delle istituzioni parlamentari, con un contegno feroce e volgare finché si vuole, ma tremendamente puntuale al cospetto della Storia. M emerge così come il “male minore” di fronte alla minaccia bolscevica, concreta dopo la repentina caduta del moloch zarista. Il re in una notte di tregenda si trova ad affidare il destino del Paese a un diavolo romagnolo che pochi mesi prima voleva detronizzarlo. La regia insiste anche sulle contraddizioni interne al branco squadrista, mostrando i volti sempre più “familiari” di Dùmini, Volpi, Balbo, De Vecchi, De Bono, Farinacci resi grotteschi dalle parole di odio che articolano gigionescamente, sottolineando come l’apparente solidità del movimento sia in realtà retta da compromessi e ambiguità. Comprimari di una vittoria personale di M, più che del fascismo.

M come M
Volendo tratteggiare una sorta di bilancio della serie, il M di Wright non compone una caricatura del personaggio storico Mussolini per fini di dileggio, così come non vuole rappresentarne il “vero” profilo secondo strumenti storiografici. Il complesso ritratto del protagonista filtra elementi di avanspettacolo (sottolineato dalle ambientazioni teatrali), l’inevitabilmente comico (alcuni camera-look fanno pensare a Oliver Hardy) e il cipiglio di Al Capone, ossia lo stereotipo noir del gangster, del boss mafioso, che si rinnova anche nel più recente The Pinguin (2024), interpretato da un Colin Farrell reso irriconoscibile da un pesante trucco prostetico al pari di quello indossato da Marinelli.
Grazie a questo proteo imprendibile, la serie riesce a restituire con verosimiglianza la prima parte della contraddittoria parabola di un uomo spregiudicato, capace di tradire tutto e tutti, se stesso compreso; un professionista della menzogna e della prevaricazione politica alla quale ha dato un nome efficace – fascismo – adottato dal linguaggio internazionale. M pare muoversi su tre livelli di rappresentazione: l’alto, ossia la figura idealizzata di Giacomo Matteotti (Gaetano Bruno), simbolo di un Parlamento che come lui è destinato alla macellazione; il basso, M e gli squadristi, e, nel mezzo, il grigio, rappresentato dalla pavida nomenclatura liberale, dalla corona e dal cinismo vaticano.
Tra i momenti più riusciti, spicca l’arringa difensiva di M, sottoposto a processo dai suoi tra le rovine delle Terme di Caracalla. La sua bocca si arcua tra disgusto e compiacimento, nel mentre si tramuta in prestigiatore riuscendo a indossare una maschera inquietante e tragicamente farsesca: sempre meno M il servile delle prime puntate e sempre più M il temerario, regista di una marcia su Roma che non è mai stata tale. La quinta puntata, in particolare, fa emergere M in tutta la sua essenza di vigliacco di successo: Marinelli interpreta il bestemmiatore sciupafemmine, gonfiando il petto, strabuzzando gli occhi bovini e illustrando al pubblico le reali intenzioni della sua macchinazione. Col superamento dell’insuperabile, M cavalca il benaltrismo, spianando così la strada all’autocrazia e al totalitarismo.

Una ulteriore caratterizzazione è data dal rapporto di M con cinque donne: Rachele, la moglie, una popolana pragmatica che poco si cura degli onori preoccupata dai continui tradimenti; Margherita Sarfatti, consigliera e amante, dark lady a metà tra Asta Nielsen e Pina Menichelli, influente ma altrettanto cosciente che non potrà mai competere con la cupidigia di potere di M; Ida Dalser (Jessica Piccolo Valerani), la cui tragica vicenda è stata raccontata magistralmente da Marco Bellocchio in Vincere (2009); Bianca Ceccato (Cosima Centurioni), la segretaria anch’ella resa madre da M che al contrario di Dalser pare accettare il rifiuto sprezzante dell’amante; e infine Edda (Matilde Potenza), la figlia preadolescente che lo venera ma al contempo lo sfida, proponendosi come alter ego del padre. Ogni figura femminile esalta inevitabilmente la mediocre statura morale di M, che all’esame di coscienza preferisce la fuga.
Lungo la serie possiamo incontrare sovente l’immagine capovolta del protagonista. È certamente un presagio di Piazzale Loreto, le cui immagini tragiche sono poste in esergo, ma vi possiamo riconoscere il sintomo di un capovolgimento in atto della realtà, delle istituzioni post-belliche, prese con la forza da una generazione di giovani cui lo Stato stesso ha insegnato a uccidere ed è ancora pervasa di quell’esperienza tragica.
Affidare un progetto complesso, concepito per un pubblico internazionale, a un regista come Joe Wright, noto per adattamenti di opere letterarie o film basati su eventi storici, si è rivelata una scelta non solo felice, ma anche strategica. Un’opzione utile per superare il consueto approccio “strapaesano”, lasciando a Marinelli il compito di catalizzare tutta l’attenzione mediatica nostrana. La popolarità divistica dell’attore associata a quella del personaggio storico che interpreta lo ha reso bersaglio di un dibattito declinante, in cui il buon lavoro d’insieme finisce per passare in secondo piano. Marinelli ha dimostrato di avere la forza necessaria per sostenere il peso della sfida, nonostante l’evitabile reazione difensiva legata alla sfera familiare. Non c’è nulla di intrinsecamente sbagliato nell’interpretare Mussolini (e perché mai dovrebbe?). Semmai, è la rimozione del fascismo dal discorso pubblico che fa del suo fantasma uno spauracchio talvolta efficace.
Leggi anche:
Simone Spoladori | M - la serie: l’eccezione e la svolta









