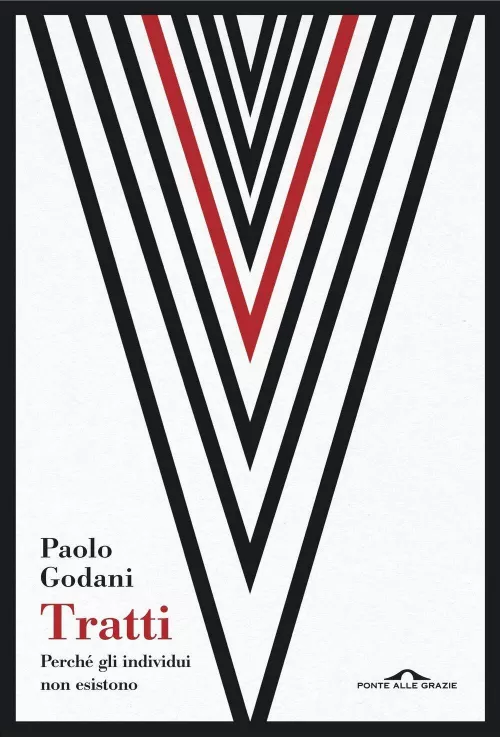L’intermittenza di una vita / Perché gli individui non esistono
Ci sono immagini che si imprimono in maniera indimenticabile nel nostro ricordo. Per esempio la luce di un volto, il lampo di un sorriso. Anche quando non ne conosciamo il nome, un volto o un sorriso diventano l’evidenza stessa che esprime l’unicità di quella donna, di quell’uomo, di un certo momento. Eppure capita anche che quei tratti così caratteristici scorrano come sabbia tra le dita di un pugno chiuso, quando cerchiamo di richiamare una particolare espressione o un sorriso inconfondibile. La nostra memoria, a cui il ricordo di un determinato volto appartiene, fallisce nell’impresa di rendercelo più vicino, più nostro. In quel momento è come se il presente e il passato fossero onde che continuano a mescolarsi, confondendosi. Anche nelle immagini più memorabili qualcosa tremola, cede il passo, non si lascia pienamente riattualizzare. Per quanto sappiamo che sia lì, contenuto e anzi impresso nella nostra memoria, resta confuso, fuori fuoco. Forse perché nessun volto fissato in immagine è mai statico: la sua presenza è attraversata da una corrente contraria che ne allontana da noi il sembiante, pur tenendocelo sempre davanti agli occhi.
I ricordi così come le immagini che sono non solo più care, ma che consideriamo quasi le evidenze della nostra vita e le parti costitutive di noi stessi, sono sempre presi in questa tensione dinamica tra unicità e ripetizione, tra singolarità e sostituibilità. Da qui la domanda: ammettiamo pure che siano ricordi, ma i ricordi di chi? Di chi sono questi ricordi che sembrano avere vita autonoma rispetto al soggetto che li considera suoi? Di chi sono se l’intenzione più ferma non li salva non dico dall’oblio, ma neanche dalle lacune e dai mancamenti con cui sfuggono a una presa sicura da parte nostra?
Devo pensare a questo paradosso leggendo il libro di Paolo Godani Tratti. Perché gli individui non esistono (Ponte alle Grazie, 2020), perché la tesi su cui si sviluppa – l’irriducibilità della vita umana rispetto alla forma-individuo – si colloca proprio sul crinale di questa tensione tra noi e le nostre immagini. E forse devo pensarci anche perché nel libro affiora sempre di nuovo l’esempio del sorriso, solitamente raro nei libri di filosofia. A chi appartiene quel sorriso indimenticabile, ma così inafferrabile, se è vero che sul volto di quella persona che ora sorride è sul punto di scomparire, magari per ripetersi in altre occasioni, a cui non sappiamo se saremo ammessi? Possiamo davvero dire che quel sorriso (magari particolarmente bello o per noi felice) sia di quel determinato individuo? C’è un individuo “dietro” a quel sorriso?
Solitamente individua una persona un certo numero di qualità. Se però seguiamo la straordinaria intuizione di L’uomo senza qualità di Musil, le esistenze ci appaiono “senza qualità”, non perché siano inutili o segnate da una tara irreparabile, ma perché non hanno mai qualità che siano loro proprie, per esempio di una esistenza e non di un’altra. Piuttosto bisognerà dire che le qualità circolano, che “non si raccolgono più attorno alla personalità di un individuo come fosse il loro luogo d’appartenenza”. Allora quelle stesse qualità che caratterizzano le singole esistenze umane non sono più di nessuno in particolare, ma hanno un essere che è comune a ciascuno. Così, riprendendo la distinzione di Musil tra “reali possibilità” e “realtà possibile”, Godani mostra come un certo sorriso sia reale in quanto presente qui e ora sul volto di chi sorride, ma come esso sia al contempo un sorriso possibile e come tale iterabile all’infinito: è singolare, situato in un preciso momento, ma è allo stesso tempo astratto, dato che può essere estratto da quel singolo istante, da quel volto che ora ci sorride, e ripetersi in seguito, in altre situazioni. Quel tratto particolare che rende così singolare quel sorriso non solo non esclude la ripetizione, ma anzi ci mostra come quella particolare sfumatura, quell’unica gradazione, quel tratto così specifico e distintivo di un volto, vivano proprio nella molteplicità delle occasioni nelle quali hanno luogo, accadendo.
La nostra esperienza del mondo si costella dunque di elementi che non corrispondono alla permanenza individuale delle caratteristiche di una vita. Non che queste caratteristiche non esistano, esse non sono però proprie di un individuo e non di un altro, ma piuttosto come i nostri ricordi conducono un’esistenza autonoma e appartengono contemporaneamente a questa e a quella vita. Sono, cioè, tratti singolari e comuni al tempo stesso.
Ci sono in questo senso delle indicazioni nella vita di ciascuno, per esempio quando ci accorgiamo che il contenuto di un’esperienza resiste alla sua appropriazione, restando “refrattario a ogni individuazione”. Eppure se continuiamo a credere alla leggenda che ci vuole tutti individui, è forse perché buona parte della nostra educazione è un’educazione all’individualità. Se diventare adulti vuol dire diventare individui, la ricchezza del bambino sta invece nel fatto che né i soggetti né gli oggetti della sua esperienza sono mai perfettamente individuati, ma partecipano entrambi a una dimensione impersonale che è l’atmosfera nella quale s’incontrano e accadono.

Opera di Christiane Spangsberg.
Il nostro mondo – dalle relazioni affettive alle carriere lavorative – pare essere interamente sospeso alla capacità dei soggetti di dire “io”. In questo senso assistiamo a una vera e propria invenzione dell’individuo: se crescere significa dare forma alla propria vita, nella nostra cultura la forma individuale è quella prevalente, assegnata o auto-attribuita alla nostra esistenza. Il perché di questa propensione individualista è presto detto: l’io individuale è il dispositivo che mira a sconfiggere la paura, da cui è prodotto, di fronte al non-individuato, al doppio, alla ripetizione, assegnando all’esistenza umana un senso di unicità che la conforta del fatto di non essere mai assolutamente originale ed eccezionale. Almeno due fattori concorrono al successo della formula-individuo: da un lato il timore di non avere accesso alla sensatezza della propria esistenza, che la rappresentazione individuale sembra invece garantire; dall’altro l’individuo è associato all’idea che ciascuno possa permanere identico attraverso il tempo e attraverso i propri mutamenti, riuscendo così ad affermare la propria “consistenza identitaria” (l’espressione è di Barbara Cassin). Naturalmente questa prospettiva fantastica presuppone l’idea di un tempo lineare all’interno del quale sarebbe così possibile fissare un posto per ciascuno.
Per rendere ineffettuale e inoperosa la nozione di individuo e il suo utilizzo, Godani propone di intendere l’individuo come costellazione di tratti qualitativi e caratteristici. I corpi, gli oggetti, i fenomeni psichici, le esistenze, le esperienze stesse non sono forse altro se non – spinozianamente – la connessione aleatoria e impermanente di questi elementi costitutivi. Un pensiero che rinuncia alla nozione di individuo non potrà non pensare per costellazioni: non si danno mai tratti che non siano in relazione con altri tratti, la cui connessione non ha perciò niente di contingente, ma è essa stessa necessaria.
È tramite questi tratti caratteristici che noi siamo capaci di riconoscere un certo oggetto – una situazione, un volto – come tale. Eppure questi tratti si danno prima e a prescindere dall’oggetto così conosciuto, a cui pure verranno assegnati come suoi elementi caratteristici, come sue qualità imprescindibili che sono al contempo qualità comuni, cioè né particolari (proprie di un solo oggetto) né universali (astratte da ogni evento concreto, da ogni incarnazione che ne fa le qualità di quella determinata esistenza). In quanto tali le qualità sono prive di individuazione: quando diciamo “questo rosso”, diciamo che si tratta di “un” rosso singolare, ma che è a sua volta ripetibile in altre situazioni, altre esperienza, altri luoghi e tempi.
Ora, quali sono le conseguenze più inaggirabili di questa destituzione dell’individualità a cui buona parte della filosofia contemporanea lavora e a cui Tratti offre una speciale occasione di approfondimento? Partiamo dalle implicazioni antropologiche, dal momento in cui siamo noi umani che affidiamo al permanere delle nostre “identità” una missione particolare, quella di evitare di dissolvere l’unicità di una vita nella sequenza dei suoi stati, senza continuità né comunicazione tra l’uno e l’altro. Ma come mostrare che l’uomo è attraversato da potenze che ne dissolvono la cosiddetta individualità e che permettono l’aver luogo – l’accadere – di qualità che manifesta l’essere comune della sua singolarità?
L’idea che prevale in Tratti è che al nome proprio non corrisponda un’individualità determinata e costante, quanto piuttosto un individuo vago. La sua vaghezza non è in rapporto alla ristrettezza delle nostre conoscenze, quanto al fatto che le cose di cui facciamo esperienza non sono che costellazioni di qualità ovvero molteplicità di tratti e pluralità di determinazioni. Il loro insieme vale in un determinato tempo. È per questo che ci capita di incontrarle in un tempo e non in un altro.
Ma forse l’implicazione maggiore di una metafisica del singolare (come recita il sottotitolo dell’edizione francese del libro) consiste nel fatto di ridisegnare filosoficamente la questione dello sguardo, in particolare nella connessione tra sguardo e temporalità. Abitualmente l’istanza individualistica si coniuga con l’idea che le cose sono sottoposte al tempo, dunque alla morte e alla fine, da cui dunque dipendono. Così si traccia un quadro fatto di generazione e corruzione, che finisce per produrre “una cattiva interpretazione dei fenomeni dell’apparire e dello scomparire”. È qui che si impone un passaggio – opportunamente posto sotto la protezione tutelare di Spinoza – che consiste nella necessità di guardare alle cose sub specie æternitatis, smettendo di “fissare il proprio sguardo terrificato sugli individui e sulla loro avventura disastrosa, per guardare attraverso di loro, notando nella loro apparente, solidissima presenza, la sussistenza di elementi che, per la loro natura ripetibile, conferiscono ad ogni individuo un carattere ammirevolmente fantasmatico”.
Non è certamente solo la filosofia a coltivare questa preziosa attitudine. Un alleato prezioso lo si trova in Proust quando – alla fine de All’ombra delle fanciulle in fiore – tratteggia il personaggio di Albertine in modo che non emerga come un individuo, ma, come ha scritto Gérard Genette, “come un tipo, una classe di determinate manifestazioni”: Albertine non è che un nome proprio di una sequenza i cui momenti mostrano caratteristiche e qualità differenti e talora in contraddizione l’une con le altre. Questo effetto non consegue l’adozione di determinate tecniche letterarie, ma discende direttamente da una visione della realtà che Proust chiama “radiografica”. Il suo sguardo non mira a ricostruire un ritratto psicologico che creda nell’interiorità del personaggio. Si limita piuttosto a cogliere i personaggi nella loro natura “intermittente” e ad ascoltare così le variazioni “interne” di un personaggio, ma anche i tratti che i personaggi hanno in comune tra di loro e che, dunque, come tali non sono né dell’uno né dell’altro in forma esclusiva.
Abbiamo oggi necessità di questo sguardo libero, non assoggettato né al dogma dell’individuo né al naturalismo che coltiva la presunzione di vedere direttamente qualcosa. Solo una tale libertà permette di accedere a quello stile che ogni vita reca inscritto su di sé come sua cifra. La sua singolarità non è allora più un privilegio esclusivo di una singola vita, ma piuttosto ciò che la mantiene in una costellazione comune con le altre vite.