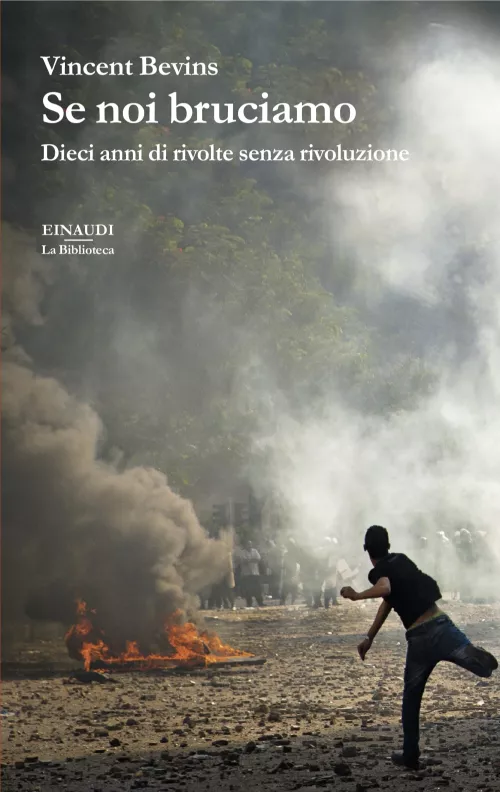Un mondo in rivolta
In alcune delle sue straordinarie pagine sulla sollevazione spartachista a Berlino nel 1919 da parte del gruppo costituitosi attorno a Rosa Luxemburg e a Karl Liebknecht, Furio Jesi si interroga sulla differenza tra rivolta e rivoluzione. Jesi mostra come essa derivi da una diversa esperienza del tempo, a cui ciascuna di loro apre: la rivolta corrisponde a “un improvviso scoppio insurrezionale”; non deve necessariamente mancare di un progetto a lungo termine, ma di per sé non lo implica. Diversamente, la rivoluzione è “un complesso strategico di movimenti insurrezionali coordinati e orientati a scadenza relativamente lunga verso gli obiettivi finali”. A distanza di più di mezzo secolo dalla stesura del manoscritto di Spartakus. Simbologie della rivolta, la preferenza di Jesi per la rivolta diventa per noi una sorta d’intuizione premonitoria: è la rivolta, non la rivoluzione, a essere la chiave di lettura delle tensioni politiche e delle loro espressioni del nostro presente, che siano assalti ai parlamenti, occupazioni di strada, manifestazioni di piazza o quant’altro. È il carattere fulmineo delle rivolte – più della strategia a lungo raggio della rivoluzione – a costituire la vera cifra e, in un certo senso, il sintomo più profondo della nostra epoca. L’hanno intuito in molti e molte che si sono occupati del tema in questi ultimi anni: più vicino a noi penso al dossier che questa rivista ha dedicato al tema della rivolta o al fortunato libro di Pierandrea Amato, La rivolta (Cronopio editore) o anche ad almeno uno dei numeri di “K. Revue trans-européenne de philosophie et arts”, dedicato alla rivolta spartakista.
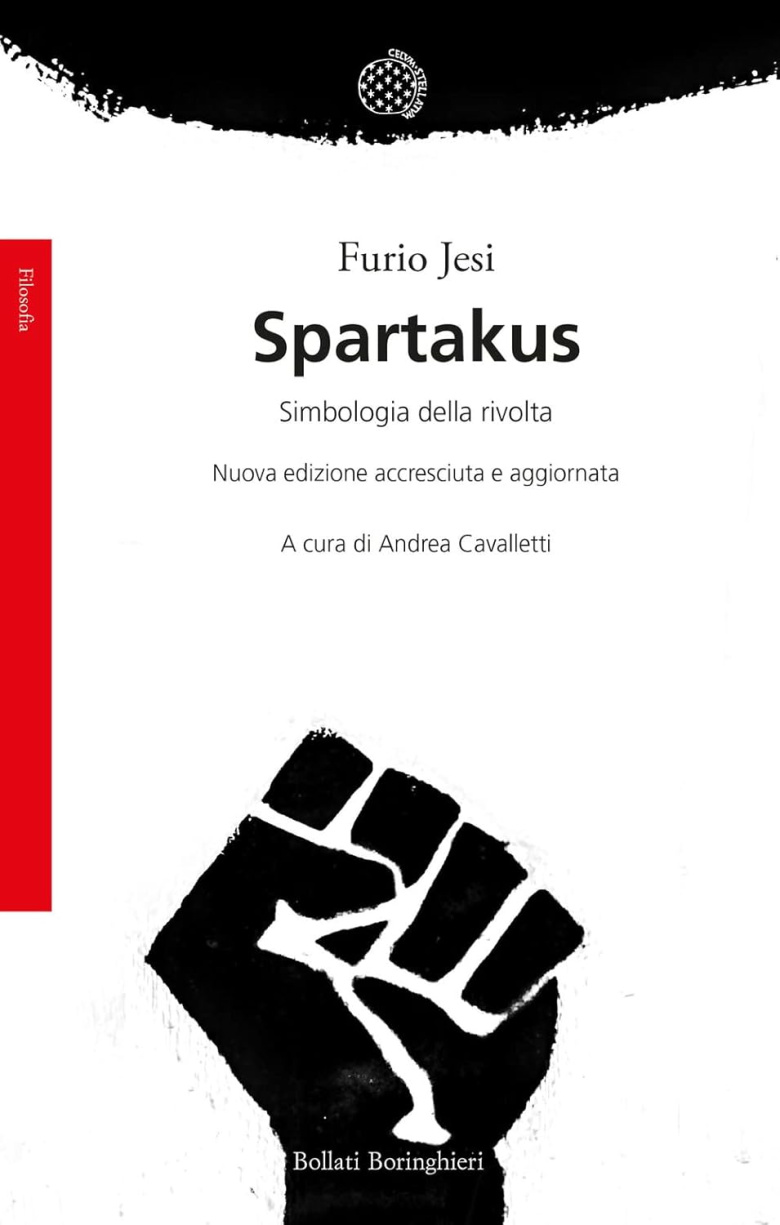
Come Jesi sapeva, la rivolta non si misura su ciò che conquista, ma sulla sua capacità di instaurare un tempo in cui “tutto ciò che si compie vale per se stesso, indipendentemente dalle sue conseguenze”. Semplificando molto, si potrebbe dire che quella delle rivolte è un’esperienza dell’immanenza, che vale per ciò che si realizza nel tempo che dura la rivolta stessa, non su quanto essa riesce a guadagnare. Il paradigma rivoluzionario corrisponde, invece, a un atto che, benché umano, è sostanzialmente trascendente: il suo intervento nel tempo storico arriva quasi da un fuori della storia, per modificarla. Ma se interviene nella storia è perché, come Jesi aveva ben intuito, nutre una profonda credenza nell’esistenza della storia. E forse questa è una prima evidenza di ciò che le rivolte ci mostrano: una perdita irreparabile tale per cui il nostro tempo non crede più all’esistenza della storia, a un grande orizzonte che sia capace di dare senso alle nostre azioni. Per la rivolta questo senso – ammesso si trovi – dev’essere tutt’al più cercato qui e ora, perché un altro tempo o un altro dove non sono dati. Da qui il carattere rabbioso e disperato delle rivolte, il loro tratto estemporaneo e improvvisato, laddove la strategia rivoluzionaria richiederebbe ben altra lucidità e ben altra pianificazione. Alla lunga scadenza della rivoluzione la nostra epoca ha dovuto, per forza di cose, sostituire una scadenza sempre più breve; alla credenza nella storia e nella concatenazione di cause ed effetti storici, la rivolta si pone dal lato della sospensione del tempo storico ossia del riconoscimento che gli uomini e le donne impegnate nel cambiamento politico e nelle proteste non possono più prevedere le conseguenze dei loro atti. È il suo carattere spontaneo che è per Jesi capace di disattivare le componenti della stessa ideologia che ha dato origine alla rivolta, destituendola di significato e di importanza (non facendo di una sua eventuale mancanza un impedimento). Così la rivolta non è la realizzazione di una teoria, ma un’invenzione al di fuori dal cono d’ombra che l’ideologia stessa potrebbe proiettare sugli eventi. Così, se la rivoluzione presuppone un soggetto (il proletariato, nei termini marxiani), la rivolta si pone dal lato di un popolo che ancora non c’è e che si autorealizza solo in seno alla rivolta stessa. Esiste con essa e con essa scompare. Essa realizza l’invenzione di una collettività (e di modi della collettività) che prima non esistevano.
È impossibile non pensare alle memorabili pagine di Jesi leggendo questo Se noi bruciamo. Dieci anni di rivolte senza rivoluzione (Einaudi) di Vincent Bevins o come recita il titolo originale: un decennio di proteste di massa e la rivoluzione mancante. Sulla base di una presenza sul campo e di un numero consistente di interviste, il libro realizza una ricostruzione del decennio di rivoluzioni mancate 2010-2020. Contestualmente l’autore offre anche una ricognizione delle forme della protesta, dei modi e dei tempi, dell’influenza dei social media e dell’informazione, oltre che delle impasse su cui quei movimenti hanno trovato il loro limite.
L’energia politica dello scontento, della diseguaglianza e della sua ricerca di migliori condizioni di vita si incanala nella protesta a cui manca, appunto, una dimensione rivoluzionaria. Pure quell’energia non smette di cercare le sue forme espressive in un mondo in cui la credenza in un orizzonte storico e nello stesso futuro manca o manca comunque di profondità. Ciò che Se noi bruciamo mette a fuoco nella sua estesa indagine giornalistica è come nella durata dei movimenti di protesta intervenga un fattore – quello temporale, appunto – in forza del quale le stesse rivolte sono da un lato costrette a dotarsi di un assetto organizzativo, dall’altro non sono fenomeni già decisi in anticipo, ma vengono attraversati da altri movimenti, correnti, opinioni e, perché no?; fake news che influenzano il corso stesso delle proteste. Che siano le proteste di piazza Tahrir al Cairo o quelle di Gezi Park a Istanbul, le cosiddette primavere arabe o le manifestazioni in Brasile o a Hong Kong, con tutte le loro differenze, esse incarnano la speranza di travolgere un mondo di ingiustizie e di crescenti diseguaglianze, senza spesso riuscire a immaginarsi un mondo a venire, ma avendo ben chiara la propria sete di equità e la fame di un riconoscimento effettivo e non solo formale dei propri diritti. La persistenza e il numero di questi fenomeni, diffusi in tutto il pianeta, non consentono di considerarli delle eccezioni. Essi sono, tutt’al più, l’ulteriore conferma del principio per cui lo stato d’eccezione è diventato una norma. Quelle che sono state condizioni straordinarie e temporanee si trasformano gradualmente in una pratica costante. La stessa frequenza del concetto di “crisi” nei discorsi contemporanei rappresenta un’evidenza sintomatica di questo stato di cose, in cui la distinzione tra “ordinario” ed “eccezionale” si confonde o scompare del tutto.
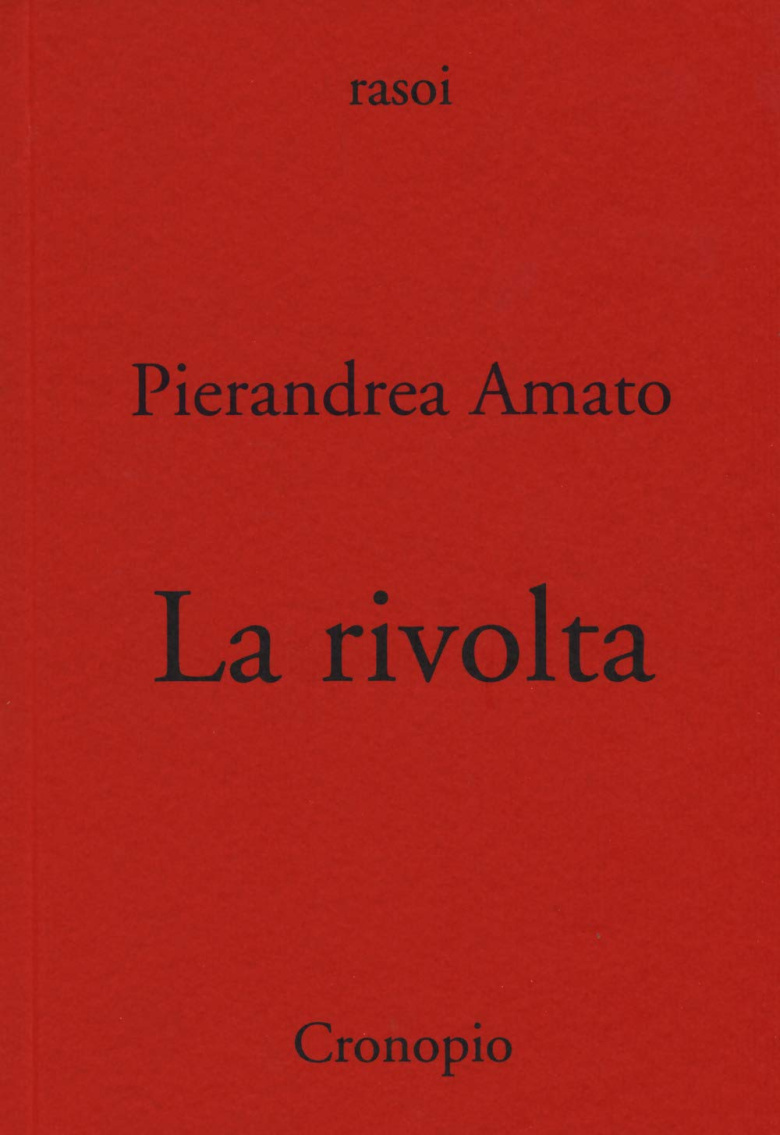
In tutto questo colpisce come all’inizio anche i soggetti che partecipano alle manifestazioni non sappiano bene perché siano lì. Hanno forse avvertito che la strada ha cominciato a parlare una lingua che corrisponde al loro malessere? In che modo la copertura mediatica ha un suo impatto sulla partecipazione alle rivolte? E in che modo una copertura mediatica tradizionale non è più all’altezza della complessità delle manifestazioni di strada? Sono tra le giuste domande che guidano l’indagine di Se noi bruciamo. Ma c’è una domanda in particolare a essere cara all’autore. “Il particolare repertorio di conflitti diventato tanto diffuso dal 2010 e 2020 da sembrare quasi naturale – proteste di massa apparentemente spontanee, coordinate digitalmente, organizzate in modo orizzontale e senza leader – ha funzionato molto bene per aprire varchi nelle strutture sociali e creare i vuoti politici”. La domanda che si pone è quali siano le forze che all’ombra di una rivolta si preparano per occupare quei vuoti. In Egitto – osserva Bevins – “sono stati i militari. In Bahrain sono stati l’Arabia Saudita e il Consiglio di cooperazione del Golfo. A Kiev si è trattato di un gruppo diverso di oligarchi ed è rimasto un po’ di spazio anche per i militanti nazionalisti ben organizzati” e così via. La diagnosi su cui il libro converge afferma, in altre parole, che le manifestazioni di strada o le proteste di massa danno vita a situazioni potenzialmente esplosive (“rivoluzionarie” le definisce Bevins, con una certa confusione concettuale), ma per lo più non sono attrezzate a trarre vantaggio dalla novità politica o dal vuoto che hanno creato. Sono sempre altri soggetti e altre forze a incaricarsi di questo compito. In fondo è questa l’impasse in cui resta bloccata la reportistica del libro: c’è un quantum di potere, che è mobile ed è reso fragile dalle proteste; i soggetti delle rivolte non sono in grado di intercettarlo o lo sono assai raramente; altri soggetti politici si impongono sulla scena, non sempre migliori di quelli che sono stati destituiti dalle proteste pubbliche. Risuona, tra le righe, il vecchio – e per molti versi comprensibile – refrain: la rivolta crea situazioni che non è in grado di gestire politicamente o di sfruttare ai fini della realizzazione delle proprie aspirazioni. E non ci riesce perché essa impegna un coacervo di soggetti senza un denominatore comune. Quello che per Jesi era la grande mossa destituente della rivolta – mobilitare un popolo che prima non c’era – nella critica ordinaria diventa l’occasione per invocare un soggetto unitario della politica, la cui evenienza è più rara della riapparizione dei dinosauri, o misurare la rivolta che pure è il tema del libro sul fondo del suo funzionamento. Ovvero, come intitolava il Corriere della sera un’anticipazione dell’uscita italiana del libro, a dominare è l’idea che le rivolte siano sempre e comunque “rivolte naufragate”. Così Bevins scrive, la rivolta “ha preso la forma della distruzione di proprietà e degli scontri con la polizia. In che modo questo particolare repertorio è diventato egemonico? Perché nel periodo 2010-2020 la «protesta» globale ha assunto così spesso questo aspetto? In un certo senso, il mistero non è solo perché questo insieme di conflitti non abbia funzionato, ma perché abbiamo pensato che potesse funzionare”. Se anche non si volesse disconoscere a questo modo di argomentare una sua ragione, bisognerebbe pure riconoscerne la legittimità solo all’interno di quel paradigma storico che metteva un cosiddetto orizzonte a disposizione delle aspirazioni politiche più o meno ideali. Altra cosa è ragionare a partire dall’assenza di questo orizzonte che caratterizza il nostro presente e nel diffuso clima apocalittico dei nostri giorni. È l’idea stessa del “funzionare” e del “non ha funzionato” che tradisce l’incapacità di comprendere l’evidenza sintomatica che la sua indagine ha pure contribuito a mettere in luce in maniera sistematica. Ciò che il libro finisce per fare è registrare una diffusa e confusa fenomenologia delle rivolte, condendola con storie personali e una varia aneddotica da reportistica di guerra, senza riuscire a fornire una vera chiave di lettura del presente.
Più a fondo, la questione resta se una ricostruzione di questo tipo non finisca per tradursi nell’espressione estenuata di un’impotenza politica, già per altro diffusa e leggibile come vero sintomo della nostra epoca in affanno. Penso soprattutto a quelle generazioni che sono oggi alla ricerca di un proprio gesto politico, non condizionato o il meno influenzato possibile dalle forme passive e rinunciatarie o di disinteresse e apatia, che le circondano. Occorre forse accostare la lettura di Se noi bruciamo a un piccolo saggio, uscito di recente per le edizioni di Cronopio, Il Disertore di Francesco Misiano. Si tratta del discorso che Misiano stesso, allora deputato socialista, tenne alla Camera nel 1920 in difesa del suo atto di disertare i fronti della Grande Guerra. Quella di Misiano è una storia straordinaria e di estrema attualità che è stata tirata fuori dagli archivi dalla sapiente cura di Luca Salza. Senza poter in questo contesto approfondire tutta la portata del gesto della diserzione, ricorderemo solo che Misiano rifiutava la guerra tra i popoli, avendo invece partecipato attivamente alla guerra di classe, prendendo parte all’insurrezione spartachista a Berlino nel 1919, di cui ci parla Jesi nel libro citato in apertura.
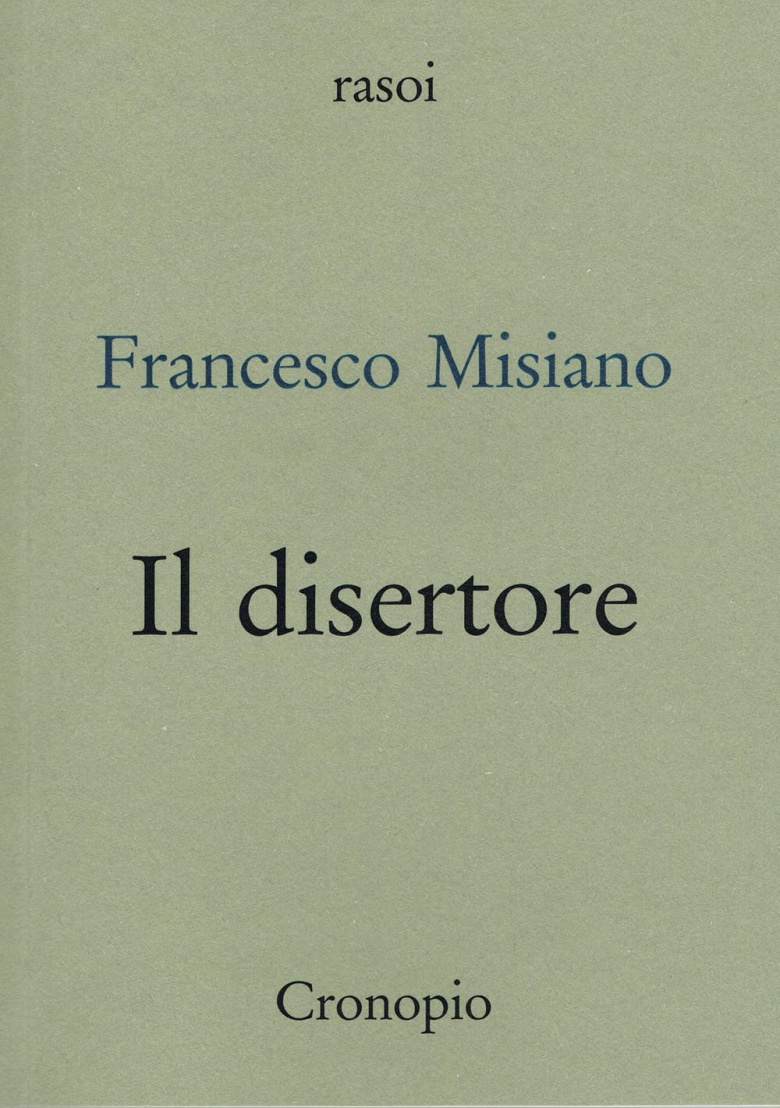
Che cosa sia singolare nella vicenda di Misiano e che cosa ci mostri rispetto al tema della rivolta, è forse da ricercare proprio nella postura del rifiuto, del sabotaggio, del no. “I “morti di fame” di una parte, disertando il comando di guerra dei loro governi, fuggendo dalla trincea in cui sono stati costretti” aprono a “una possibilità della fuga che dischiude un nuovo mondo sempre inedito”. Nella sua posizione di internazionalista, Misiano sa che la guerra è un’espressione degli stati borghesi che, quando si dichiarano guerra, lo fanno esclusivamente per il proprio interesse, sacrificando le masse popolari. La guerra di tali stati non era e non sarebbe mai stata capace di portare alcuna emancipazione politica. Così, ciò che il libro di Misiano-Salza ci mostra, al di là dello stigma che ancora oggi segna la parola “disertore” e “diserzione”, è come oggi più che mai occorra interrogarsi sul senso delle parole che gravano sulle nostre opinioni e sulle scelte, indicando la necessità di un’invenzione che sia un esperimento politico in tempi di conformismo crescente. Non era l’unico, Misiano. Come Salza ricorda nella sua lunga e meditata prefazione, “in un romanzo come Viaggio al termine della notte […] diventa evidente che per combattere la guerra bisogna innanzitutto scrollarsela di dosso, estirparla da dentro di sé. […] Con Foucault, potremmo dire che Misiano stia costruendo una forma di resistenza al potere politico che non è dialettica, ma che si dispiega a partire da pratiche etiche, da un lavoro su se stessi, da una trasformazione della propria esistenza”.