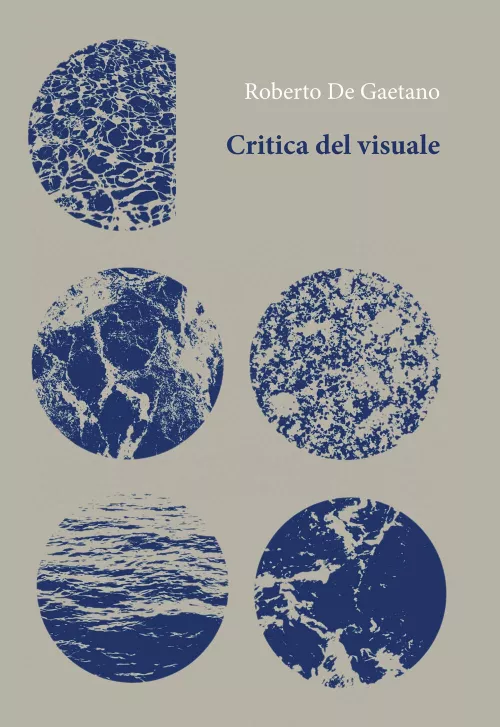Uno, cento, mille schermi
Un tempo sono esistiti due tipi di schermi: il piccolo e il grande, la televisione e il cinema. Il secondo coincideva con una visione collettiva, pubblica, di immagini proiettate in sale non di rado fumose, in origine addirittura in presenza di un’orchestra che accompagnava con la musica lo scorrere delle scene. Il piccolo schermo prese anno dopo anno il sopravvento, offrendo una visione inizialmente diffusa anche nei circoli, ma poi sempre più domestica. Offriva un comodo piacere casalingo, il cui sogno era quello di sostituire la visione pubblica con uno spettacolo chez soi: miniaturizzato nel formato, ma non nel piacere, si supponeva. Oggi è diventato infrequente sentire parlare di piccolo schermo. Non solo gli apparati televisivi sono cresciuti in dimensioni e in qualità tecnologiche. È soprattutto l’ambizione delle grandi piattaforme internazionali che mal si concilia con la modestia della formula del “piccolo schermo”, tutta piena di una certa soggezione nei confronti delle sale cinematografiche. Del resto, il cinema nasce popolare, mentre la TV diventa abbastanza rapidamente l’apparecchio di quella che Debord avrebbe chiamato “la piccola borghesia planetaria”: rassicurante e fondamentalmente omologante.
Questa distinzione tra un piccolo grande schermo è venuta meno anche per un altro motivo. La proliferazione di schermi di formati differenti, la maggior parte dei quali mobili, capaci di seguirci nelle nostre vite sempre più ubique, rappresenta la vera trasformazione della visione, come si è andata configurando negli ultimi decenni. Lo schermo della televisione funzionava già come riduzione dei materiali pensati per lo schermo cinematografico: formato e velocità di proiezione cambiavano, oltre a cambiare l’ambiente stesso di visione.
Ma cosa succede quando è sempre più abituale guardare film o altri contenuti video su computer portatili, tablet, cellulari? La questione non è solo cosa si veda, a essa segue l’altra domanda: come si vede? Perché è indubbio che, se i dispositivi si sono evoluti e ancora si evolvono a un ritmo sorprendente, la visione ne risulta completamente trasformata. Abbiamo imparato a fare a meno del buio della sala, a guardare piccoli o piccolissimi schermi, la cui immagine non ci assorbe, ma è invece sempre circondata da un alone di realtà, dentro il quale sono incastonate le scene in movimento. In cambio abbiamo ricevuto un controllo inaudito sul video, che ci permette di fermare l’immagine e magari di riprenderne la visione giorni dopo.
Devo pensare a queste trasformazioni, che sono vere e profonde destrutturazioni della nostra stessa soggettività, leggendo un passaggio di Critica del visuale di Roberto De Gaetano (Orthotes, Napoli-Salerno 2022) in cui si dice: «Il cinema costruisce sempre un altrove, un mondo i cui effetti sono quelli di intersecarsi con il “mondo della vita”. Il cinema senza altrove, o dove l’altrove non è che la conferma del qui, è la televisione». Questa riflessione rimanda a una straordinaria intuizione del teorico e redattore dei Cahiers du cinéma, Serge Daney: «Mi rendo conto che sempre con emozione che ripeto questa piccola e tuttavia vaga parola: “Il mondo” […]. Tuttavia, la mia cinefilia non è consistita nel fuggire dalla società (attraverso il sogno) né nell’attaccarla (attraverso la rivolta), piuttosto nell’avvicinarla (il più tardi possibile) attraverso la deviazione del cinema, deviazione formatrice del viaggio nel mondo promesso dal cinema». Il cinema, potremmo dire nasce dalla promessa di avvicinare il mondo, con tutta la cautela possibile, attraverso quella meravigliosa deviazione che sono le immagini in movimento. Diversamente, la televisione nasce o nascerebbe come una conferma: «la conferma del qui» che fa a meno dell’altrove e che si attesta sulle proprie posizioni rassicuranti.
Certo, nella sintesi la distinzione rischia di suonare generica e superficiale. Sappiamo che alla televisione non sono mancati i suoi teorici, i quali ne hanno immaginato e a volte realizzato sviluppi altri e usi imprevisti (si vedano, per esempio, gli articoli dedicati alla tv nel libro di Enrico Ghezzi, L’acquario di quello che manca). L’aspetto che qui però interessa è come questa dicotomia tra televisione e cinema segnali soprattutto una metamorfosi della visione, cioè una trasformazione radicale dell’esperienza dell’immagine, tutta intrecciata alle nostre abitudini di vedenti. Questa riflessione non attiene solo alla qualità della visione, ma in primo luogo – come più volte De Gaetano opportunamente sottolinea – al «carattere radicalmente etico» del nostro rapporto con le immagini.
La domanda non è se si veda meglio o peggio sul piccolo schermo rispetto al grande schermo della sala cinematografica. La questione centrale risiede, invece, in quella «promessa del mondo che il cinema ci fa» e che è «sempre promessa di una nuova possibilità di vita, di un nuovo “abitare” il mondo». Rispetto a queste coordinate, le riflessioni di Critica del visuale introducono con puntualità una questione immensa: ciò che resta al fondo di ogni differente visione è sostanzialmente proprio l’immagine come differenza. Lo spiega bene la chiusa del primo capitolo (Oltre il visuale: l’immagine immaginata) in cui l’immagine è pensata come una sospensione rispetto ai dispositivi estetici, culturali o comunicativi correnti. In altri termini l’immagine deve essere pensata come «qualcosa che resiste e che fa problema» ovvero come qualcosa «che inscrive nel sapere una sospensione», che chiede di essere ascoltata (vista) e pensata. Questa sospensione del sapere che l’immagine introduce nelle nostre vite implica che l’immagine è una forma di non sapere che come tale chiede di essere riconosciuto: non so cosa vedo, cioè vedere significa essere espropriati del sapere in anticipo il senso della visione, accettando la nostra fragilità quando guardiamo senza sapere. La vista non è un senso della distanza, ma un’esposizione radicale di chi guarda rispetto a ciò che guarda.
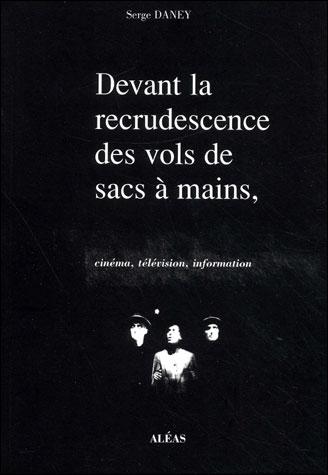
Questa sottolineatura è oggi tanto più urgente, quanto più il registro dell’immagine tende a essere confuso con quello del visuale, ovvero con la dimensione mediale in cui l’immagine viene fatta coincidere con la dimensione tecnologica attraverso la quale la guardiamo. Si finisce così per decretare una sostanziale indifferenza delle immagini nella loro singolarità, dal momento che a essere ritenuto decisivo è unicamente l’aspetto tecnico-dispositivo attraverso il quale le immagini vengono trasmesse, diffuse e mostrate. Un certo discorso dominante fa come se la sfera mediale annullasse la singolarità delle immagini, riassorbendola dentro la strumentalità tecnologica. Questa idea finisce per voler rendere intercambiabili e convertibili, cioè sostanzialmente identiche e irrilevanti, tutte le nostre immagini. Purché si diano immagini, la loro intensità finisce per passare in secondo piano, producendo immagini-stereotipo.
Daney parlava di un’“esasperazione” che persiste al fondo delle immagini, in quanto portatrici di un supplemento. Questa esasperazione è necessaria per vedere attraverso le immagini al di là del nostro sguardo naturale. In essa risiede la possibilità di vedere ciò che è eterogeneo rispetto a una certa tendenza dello sguardo umano a insistere sull’omogeneità. Questo significa, nello specifico, che proprio questa natura dell’immagine permette una visione critica capace di «vedere del montato là dove gli altri vedono dell’omogeneo (cioè del “naturale”)».
Questo aspetto porta con sé più conseguenze di rilievo. La prima è che il cinema non è mai la rappresentazione di qualcosa che accade, ma sempre l’invenzione di un tipo tutto particolare: «l’invenzione di ciò che esiste». Questo programma, che è estetico ma anche profondamente etico e politico, è il programma fondatore del cinema stesso, inteso non come storia dell’insieme dei film girati da poco più di un secolo a questa parte, ma come «l’insieme dei mondi costruiti dei film e pensati dalla critica».
È dal montaggio che discende la potenza delle immagini. Discende dalla consapevolezza che ogni singola immagine «è già fin dall’inizio almeno due: abitata da altre immagini, della loro temporalità (eterogenea), e dal senso che scaturisce dalla restituzione “sintetica” di questo concatenamento delle eterogeneo». L’immagine è impensabile fuori da questa nozione di composizione: è tale perché porta sempre con sé un’eterogeneità radicale. Piuttosto, si potrà dire che a cancellare l’eterogeneità delle immagini è sempre un esercizio funzionale al potere, che pretenderebbe di strumentalizzarle, rendendole docili strumenti della propria egemonia. Questo fa sì che molte immagini si dispongano a essere standardizzate, private di ogni esasperazione, ridotte allo stereotipo di immagini già viste. Davanti ad altre immagini riconosciamo, invece, che ci fanno vedere il mondo così come non lo abbiamo mai visto.
Se questo è vero, ne deriva che l’immagine deve essere pensata non come fosse una cosa, quanto piuttosto nei termini di ciò che diviene, di una processualità: «certo, molte immagini si dispongono esse stesse ad azzerare la loro immaginità o a restituirla in una codificazione prevedibile. O servono proprio per tale codificazione standardizzata, come le immagini pubblicitarie o quelle di propaganda. Si tratta di immagini senza “supplemento” (Daney). Ma quando l’immagine diventa visuel […] fa capire che non c’è più nulla da vedere».
Queste riflessioni hanno evidentemente un altro correlato, che riguarda la nozione stessa di critica, presente fin dal titolo del libro. Per discorso critico De Gaetano intende quel discorso «capace di costituire […] uno spazio di discussione pubblica». In esso la forma finita e singolare si dà come pensiero, secondo la definizione di Godard: Une pensée qui forme, une forme qui pense. Ma, appunto, proprio perché l'opera non coincide mai con una totalità, ma sempre con una forma limitata, si apre uno spazio di espressione per la critica come quella prassi specifica in cui «l’opera si espone nella sua verità». La critica è, cioè, una forma di conoscenza. In questo senso il discorso critico non è semplicemente un discorso sul cinema, ma quell’accompagnamento necessario del cinema che permette di continuo di ricrearlo, di rimontarlo, ossia di trovare nelle opere la grande opportunità di una reinvenzione permanente di quanto è stato in grado di catturare anche solo per un istante il nostro sguardo.
È in questo senso che il cinema nella sua capacità di inventare mondi è essenzialmente intrecciato con questa dimensione critica, che si tratta di riattivare. Se il cinema ci riconsegna alle cose, è proprio perché le sue immagini sono capaci di svincolare il mondo dalle sue codificazioni prestabilite. Il cinema incarna nelle sue immagini quell’eccedenza a cui si appella anche la critica, quando si tratta di restituirci un mondo attraverso il proprio stile.