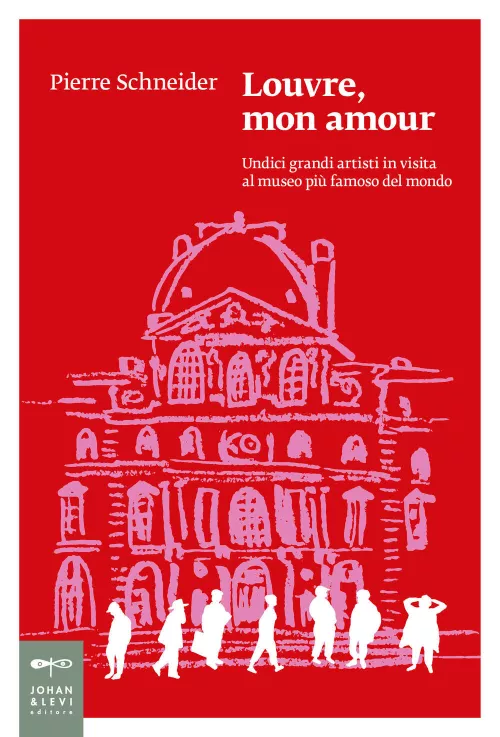Pierre Schneider. Al Louvre con gli artisti
Era uscito in prima traduzione italiana una decina d’anni fa, quale motivo spingerebbe a ristamparlo ora? Ne dico uno. C’è stato un tempo in cui gli artisti non andavano al museo per imbrattare Guernica (Tony Shafrazi, 1974: sì, proprio colui che come gallerista s’inventò il mercato dei graffitisti; oggi sodale trumpiano). Non ci andavano per lavare e spazzare le scalinate d’accesso o rinettare le vetrine delle teche in un rivendicativo gesto femminista (era Mierle Laderman Ukeles, Transfer: The Maintenance of an Art Object, 1973). Non ci andavano neppure per restituire alla sua funzione originaria l’orinatoio di Duchamp nell’unico modo possibile, cioè pisciandoci dentro (lo fece più d’uno, a partire da Brian Eno, sì, proprio lui, di solito così mite).
Ci andavano invece, gli artisti al museo, per vedere e rivedere dipinti e sculture, in un gesto che poteva essere di rispettosa sudditanza, di consapevole deferenza, di colta rilettura oppure di sfida villana all’autorità dei grandi maestri. Ci andavano anche perché trascorrevano il loro tempo disegnando, dipingendo e certo anche cazzeggiando tutti i santi giorni nelle Accademie, quando ancora alle Accademie era legata una pinacoteca – Brera, Venezia – e non erano quell’incrocio tra un centro sociale e una sala da videogiochi che sono oggi. Ma gli artisti al museo ci andavano anche, un po’ come tutti gli altri visitatori, per starsene al caldo, per chiacchierare, per dare un appuntamento galante: lo suggeriva Baudelaire, e si sa che la dritta molto tempo dopo venne colta anche da Barack Obama, che a Chicago diede il primo appuntamento a Michelle davanti alla Grande Jatte di Seurat.
Il godibilissimo libro di Pierre Schneider (Louvre, mon amour. Undici grandi artisti in visita al museo più famoso del mondo, Johan&Levi 2023) principia dal racconto di come il museo diventò tale con la Rivoluzione, atto stesso fondativo della modernità. Da spazio del vivere il Louvre divenne spazio del vedere. Alla cacciata dei sovrani, gli ammezzati del palazzo furono invasi dai pittori. A partire dal cittadino David vi s’installarono non meno di duecento artisti; un po’ tutta l’arte di fine Settecento fu domiciliata al Louvre. Durò poco. Napoleone imperatore ordinò di cacciare via gli artisti e restituire le sale alle opere, prima, e ai conservatori poi, in origine pittori anche loro ma molto opportunamente chiamati all’epoca concierges.
L’arte iniziava a fare a meno degli artisti: la loro cacciata dal Louvre rappresentò in effetti l’atto museografico per eccellenza. Collocata fuori dal suo contesto originario, resa autonoma da una filosofia dell’arte che distingueva il bello dal vero e dal buono, sottoposta a un imperioso regime di riproducibilità tecnica, l’arte si avviava a diventare moderna. E ancora tutti “moderni”, ciascuno a proprio modo, erano gli autori che negli anni sessanta Schneider accompagnò lungo le sale del Louvre, in una conversazione ordinata in undici incontri che si legge un po’ come una versione parigina e polifonica delle Tre ore al Museo del Prado di Eugenio d’Ors.
Si inizia con Chagall che s’incanta per il Gilles di Watteau e discetta un po’ ovunque sul colore dei grandi maestri dell’Ottocento quasi a volersi accreditare, lui nato russo, più francese dei francesi. E poi con un gran salto si passa a un pittore americano come Sam Francis, che non ebbe remore a definire piuttosto sbrigativamente il museo come “un grande luogo in cui stanno le cose, in cui le si può notare o no” – il che non è del tutto sbagliato nel suo un po’ rude pragmatismo.
I raffronti visivi sulle pagine non temono accostamenti azzardati. Un etereo Francis a fronte di un ritratto del Fayum, Mirò a contatto con i mosaici romani, la rastremate figurine di Giacometti che si rispecchiano nei lividi corpi di Goya: ma è proprio da questa attitudine disinvolta, se non scanzonata, del tutto libera dalle pastoie della storia dell’arte e dai suoi studiati confronti e paragoni che prendono vita letture sorprendenti. Sotto gli occhi degli artisti, e con la guida di un accorto maieuta come Schneider, ogni dipinto e ogni scultura diventano un inciampo nella rassicurante narrazione evolutiva. Più che oggetti da ammirare sono botole che si aprono per far cadere dentro pregiudizi e concezioni ossificate. A volte si esagera: considerare l’Incoronazione dell’Angelico come una pittura psichedelica che “fa pensare agli hippies” può costituire una irrispettosa e delirante decifrazione. Ma fa capire molte cose rispetto alla maniera in cui l’artista guarda l’opera degli altri.
Nel loro insieme gli enunciati di questi artisti appaiono infatti come la migliore conferma di quell’excursus sul concetto di “influenza” su cui ragionò Michael Baxandall in Forme dell’intenzione (2000). Anche Schneider sapeva queste cose; lui d’altra parte passò buona parte della vita a frequentare casa e atelier Matisse per costruire la memorabile, insuperata e definitiva monografia sul grande pittore. Ed ecco, i suoi interlocutori nelle passeggiate lungo sale e corridoi manifestano l’intero arco delle possibili attitudini. Dalla rispettosa pedagogia di Giacometti (“Copiare per vedere meglio”) alla sublime noncuranza di un pittore medio, ma non mediocre, come Riopelle (“Un tempo si imparava copiando i maestri. Oggi il mestiere consiste nell’essere consapevoli dei propri mezzi”) al graffio geniale di Saul Steinberg: “In Europa i musei hanno un odore di prefettura, di scuola elementare; in America hanno l’odore delle banche”. Per arrivare alla sfrontatezza magnificamente rivelativa di Barnett Newman, che giunto al Louvre per la prima volta a sessant’anni consegnò un’intera sequela di perle. Davanti alla Madame Rivière di Ingres: “Questo tizio non sa disegnare”. Ispezionando in dettaglio l’alluce di Teti, sempre di Ingres: “sembra un Arp”. Ammirando tutto quel trambusto del Sardanapalo di Delacroix: “Rauschenberg ha preso molto da qui”. E poi Maria Helena Vieira da Silva che spiega come le sue prospettive vertiginose e catafratte in fin dei conti vengano fuori dalle tovaglie di Bonnard, come dai pavimenti dei senesi… per finire con Bram van Velde che conferma la natura maniacale e ossessiva di certi incontri (Rembrandt su tutti), il suo vagare come un sonnambulo tra i corridoi, la restituzione pittorica in atelier accettata come tracciato psichico di una sofferenza, o un’immagine elusiva e sabbiosa.
Man mano che Schneider accompagnò i suoi ospiti dinanzi alla Maestà di Cimabue, alla Nike, alla battaglia di Paolo Uccello, all’autoritratto di Tintoretto, alla Zattera della Medusa, o all’atelier di Courbet (non esisteva ancora l’Orsay, ricordiamolo), indugiando poi nelle sale della Mesopotamia, dell’arte copta o dell’arte cicladica, il running commentary che ne venne fuori prese forma di referto sulla contemporaneità. Si constatò la morte di quel rapporto che per secoli si era mantenuto vivo fra il pittore e la cosa da dipingere. E si accettò il destino del reale, che nell’arte figurativa si dava sotto forma di apparenza e nell’arte non figurativa sotto forma di esperienza. Ma emerse soprattutto la coscienza di un’irrimediabile distanza, che si poteva e si doveva colmare in molti modi. Quello in fin dei conti costituiva il rovello dell’artista – stiamo parlando di figure alla cerniera del Novecento –, questo in fin dei conti è ancor oggi il racconto del libro.
“Le grandi opere rinascimentali e postrinascimentali sono degli ingranaggi – riconobbe a un certo punto Pierre Soulages, abbacinato dalla magia nera di Paolo Uccello – non mi piace infilarci le mani”. Aveva ragione.
Per lo storico, sintetizzò Schneider, l’oggi nasce dallo ieri; per l’artista creatore, lo ieri nasce dell’oggi. È difficile essere più puntualmente laconici.