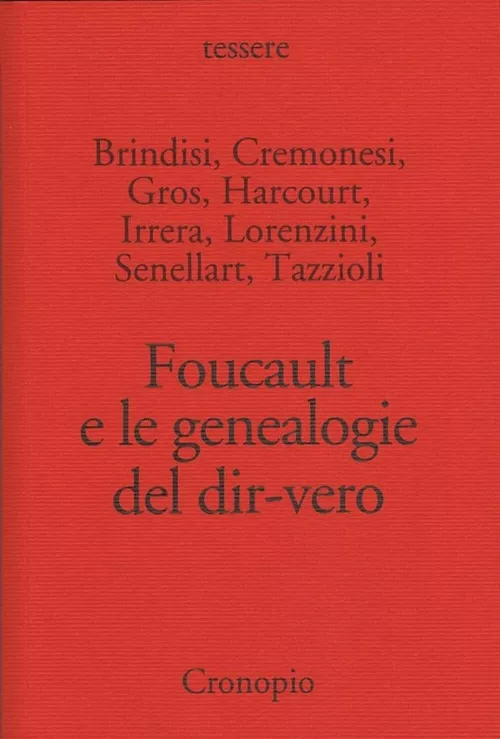Su Foucault e le genealogie del dir-vero
Dopo la pubblicazione dei corsi tenuti da Foucault al Collège de France tra il 1979 e il 1981, dedicati rispettivamente a Soggettività e verità e al Governo dei viventi, si va completando un quadro genealogico dischiuso anni fa con la pubblicazione del corso del 1981-82 su L’ermeneutica del soggetto e via via arricchito da quella delle lezioni tenute a Berkeley nel 1980 Sull’origine dell’ermeneutica del sé e del corso tenuto a Lovanio nel 1981 su Mal fare, dir vero; si tratta di un affresco complesso e sfaccettato col quale Foucault, insieme alla metamorfosi delle tecniche del sé ereditate dal pensiero tardo-antico, ha ricostruito – ma sarebbe forse meglio dire de-costruito – la dimensione pastorale del processo di soggettivazione moderno, e quindi delle pratiche di veridizione operanti nei vari campi del potere-sapere (giuridico, economico, medico-psichiatrico, ecc.). Utilizzando come ‘attrezzi’ e così attualizzando alcuni geniali spunti presenti in tale quadro (soprattutto nel corso del 1980-81 sul governo dei viventi, come pure in quello di Lovanio e in La verità e le forme giuridiche del ’73, attraverso cui ad esempio Harcourt ‘legge’ la crisi economica contemporanea), ma anche evidenziandone la rigorosa coerenza teorica e la straordinaria ricchezza storico-documentale, gli autori riuniti in questo volume si interrogano, a trent’anni dalla morte di Foucault, sulla persistenza dell’ingiunzione a “dire il vero” nei meccanismi governamentali contemporanei – cioè sul modo in cui oggi si continua a governare gli uomini e a produrre soggettività conformi attraverso un uso strategico e soprattutto politico della verità –, ma anche sui possibili spazi di resistenza che si aprirebbero, più che al di fuori, all’interno o magari al di sotto dei dispositivi governamentali che ‘fungono inconsci’ nel mondo globalizzato (primo fra tutti, il web).
Potremmo dire che la questione di fondo che percorre l’intero testo, fin dall’introduzione firmata dal gruppo della rivista mf, è la seguente: il governo dei viventi è oggi dell’ordine della terapia intesa come terapia di verità, come obbligo di confessione di sé che sembra ormai divenuto, nel non-luogo della rete, obbligo narcisistico di veridizione? E se lo è, se il suo essere terapia e non cura di sé (centrata come sappiamo, nell’antichità, sull’autonomia e la padronanza) rinvia all’inferiorità o meglio alla non-perfezione del paziente-utente-consumatore (che fa pendant con l’inferiorità degli irregolari-esclusi che cercano di sfuggire al governo della verità), allora da dove proviene quest’ingiunzione che fa sistema con l’esercizio del potere-sapere sui soggetti-assoggettati nel medio del linguaggio? In altri termini, che rapporto c’è, in Occidente, fra l’orizzonte linguistico della verità e quello pratico-politico della soggettivazione?
Ebbene, la risposta che gli autori del volume traggono dall’affresco genealogico foucaultiano e declinano criticamente nei diversi contributi, è più o meno questa: è nel cristianesimo dei primi secoli che si è formato un legame oscuro e articolato, ma al tempo stesso “essenziale” e, aggiungerei, crudele, “tra l’obbligo di verbalizzazione della verità e l’istanza di obbedienza assoluta all’altro”. Soltanto comprendendo la persistenza, seppur parziale e metamorfosata, di questo legame nella società contemporanea, possiamo “far emergere la storicità della nostra attuale forma di soggettività” – una storicità che sembra invece completamente occultata dai dispositivi ‘naturalizzati’ in cui ci troviamo a pensare e ad agire –, e così provare a “trasformarla”, cioè a trasformarci, abbandonando la conoscenza in fondo servile di se stessi a favore di una nuova, plurale ‘politica di noi stessi’ che sia anche una ‘vita altrimenti’ – secondo il suggerimento formulato da Foucault nelle lezioni di Berkeley e nell’ultimo corso al Collège. Ciò equivarrebbe a dissolvere, a polverizzare il soggetto dell’ermeneutica del sé, sciogliendo il legame che lo lega al potere: un movimento di svincolamento ma anche di indocilità critica che può trasformare il soggetto nel rapporto ch’egli mantiene con la verità, disancorandolo dalla verità come conoscenza e mostrandogli la verità come forza (come mostra Orazio Irrera nel suo contributo).
In tale coraggiosa prospettiva di “mobilità”, Frédéric Gros sottolinea ad esempio, nel suo contributo come Foucault non abbia affatto proposto, con l’etica della cura di sé, la costruzione o la nostalgica riconquista di un sé assolutamente puro e singolare – in quanto tale, aggiungerei, metafisico e dunque verticalmente relato all’Essere –, ma l’esperienza di un sé eticamente e politicamente orientato agli altri: non un sé-sostanza, ma un rapporto a sé attraverso gli altri, vale a dire un sé relazionale e orizzontale, non verticale. Se insomma la cura di sé e degli altri non è terapia, ma un altro modo di fare politica in cui la verità è forza, e non debolezza dell’obbedienza; se ‘prendersi cura’ non significa esercitare sugli altri, in quanto inferiori (=bambini) il soffocante potere del maternage, ma occuparsene “in altro modo” realizzando con essi la ‘vita altrimenti’, bisogna tuttavia riconoscere che la maggiore – e forse la migliore – parte dei saggi che compongono il volume insiste sulle modalità e le forme in cui il soggetto ossessionato dalla verità, come pure il soggetto della conoscenza ‘vera’ inaugurato dai padri della Chiesa, il soggetto obbediente nato nei monasteri medioevali e ri-generato dalla Controriforma cattolica, non solo hanno continuato a esistere nell’antropologia, nelle scienze umane e, ad esempio attraverso la sessualità discorsiva, nella psicoanalisi, ma continuano a esistere ancora oggi come soggetti inferiori (cioè in-fantili seppur capaci di linguaggio) perché assoggettati all’ingiunzione al godimento e al consumo, che insieme a quella all’auto-realizzazione sembra aver sostituito, con esiti subdolamente pastorali, quella cristiana alla verità.
In questa, più cupa, prospettiva genealogica, oltre a quello di Brindisi – per il quale il moderno processo di soggettivazione sembra essere il frutto di una trasformazione “delle forme punitive di stabilimento della verità, delle tecnologie morali, [ecc…], che ripete gli elementi del paradigma edipico su un altro piano di senso e di esperienza”, per cui ad esempio la dipendenza della psicoanalisi da tale paradigma, più che una scoperta dell’universale destino edipico del desiderio, rinvia ad una “generalizzazione soggettiva del modello indiziario e disciplinare” e rivela un’angosciante “consistenza poliziesca del mondo” –, spiccano i contributi di Michel Senellart e Laura Cremonesi.
Il primo analizza il nesso, finora poco indagato, tra i corsi sulla confessione/veridizione e l’indagine sulla storia della sessualità, partendo dall’importanza che, nel corso del 1980-81, viene assegnata al timore e alla sua elaborazione dottrinale nella patristica cristiana, in particolare in Tertulliano: “Il timore riguardo a se stessi, il timore di ciò che si è”, nota Foucault, sarà d’importanza decisiva per la soggettività occidentale, per il rapporto di sé con sé e con “la verità che l’individuo può scoprire in fondo a se stesso”. La remissione dei peccati non è mai in grado di liberare completamente il fedele (che resta perciò inferiore, direi, come un bambino perverso) dal timore – al quale anzi egli deve rimanere sottoposto per tutta la vita, in un rapporto a se stesso perennemente inquieto che riecheggia anche nell’agostiniano ‘inquietum est cor nostrum’. L’inquieta ricerca della verità su se stessi, nota Senellart sulla scia di Foucault, è pervasa dal timore dell’aspirante alla purezza – all’origine, il catecumeno che si prepara al battesimo – nei confronti delle proprie pulsioni sessuali, percepite come espressione della presenza di Satana nella sua anima. Come ribadisce anche Daniele Lorenzini seguendo Foucault, nel cristianesimo “siamo chiamati a scoprire la verità di noi stessi in funzione del sacrificio di noi stessi, dato che tale verità è in realtà il male, è l’Altro in noi, è Satana che si è insediato nella nostra natura in seguito al peccato originale”.
Questa sorta di possessione a bassa intensità investe il senso della rinuncia sessuale che caratterizza l’ascesi monastica cristiana e più in generale le pratiche imposte dal potere pastorale: la verità su di sé, attraverso l’obbligo di manifestarla agli altri, diventa il prodotto della mortificazione della carne, della lotta e del combattimento con l’altro; di conseguenza, l’anima non diviene mai trasparente a se stessa, pura e dunque forte, ma ricomincia sempre daccapo il processo confessionale di veridizione nella non-perfezione e nella debolezza della tentazione: se temere di peccare ancora significa sentirsi sempre minacciati di cadere, perseverare nel timore significa abbandonare ogni idea di perfezione, sapendosi indefinitamente fallibili.
Questa lotta contro il male che abita l’uomo, contro la corruzione della natura umana, non solo dura tutta la vita e caratterizza, in quello che potremmo definire lo psichismo cristiano, il rapporto del soggetto con se stesso, ma soprattutto, nota Cremonesi, fa sorgere l’“idea di uno spazio interiore abitato da una presenza estranea e maligna” – idea destinata, com’è noto, a una grande fortuna nella filosofia moderna, ma anche a una significativa manipolazione in ambito medico-psichiatrico. Infatti la continua verbalizzazione dei pensieri e delle intenzioni, che per Foucault mostra l’insorgenza, ad esempio in Cassiano, dell’ermeneutica del sé, sembra basarsi, secondo Cremonesi, “su un doppio presupposto”: da un lato, essa presuppone l’esistenza di una “verità del sé sotterranea e nascosta”, che può essere portata alla luce solo attraverso una pratica della confessione che annichilisca la volontà di colui che viene ‘diretto’; dall’altro lato, però, essa implica un’efficacia della verbalizzazione nel cancellare le colpe, che definirei terapeutica: in quanto tale, quest’efficacia non può che essere parziale e imperfetta come il soggetto che la invoca – poiché, come abbiamo visto, la confessione non libera, non guarisce, se non temporaneamente. È attraverso questo gioco, allora, che “si inizia a scavare uno spazio nuovo, quello di un’interiorità animata da forze sconosciute e invisibili”: un’invenzione psicotizzante “tipicamente cristiana”, sulla quale si è innestato il potere psichiatrico moderno e sulla quale s’innesta, oggi, quello governamentale. Questo potere appare centrato, da un lato, sulla terapeutizzazione dell’esistenza – per cui il disagio psichico non è prodotto dal particolare assetto economico-politico della società, ma da ‘forze’ oscure, inconsce, che opprimono il soggetto in quanto debole e inferiore – ; dall’altro, con una sottile quanto devastante contraddizione, esso si basa sullo sfruttamento del ‘capitale umano’ che il soggetto, a sua insaputa, possiede.
Da tale punto di vista, l’ingiunzione a dire la verità su se stessi e quella all’autenticità o alla realizzazione di se stessi, che caratterizza l’attuale imprenditoria del sé (apparentemente liberatoria e narcisistica), sono in realtà due facce della medesima medaglia ermeneutica. Se infatti, come insegna Foucault nel corso sul governo dei viventi, è l’imperfezione a imporre al soggetto cristiano l’interpretazione di sé come unica possibile forma di salvezza, è la stessa imperfezione a imporre al soggetto contemporaneo quella tirannica ricerca di successo e godimento che dovrebbe affrancarlo dalla vecchia dimensione religiosa della penitenza e della mortificazione di sé, ma in realtà lo inchioda alla sua nuova dipendenza – dipendenza dalla terapia, dal counseling, ma anche dai dispositivi governamentali e, più profondamente, dal giudizio altrui. Si tratta cioè, ancora una volta, di obbedienza assoluta all’altro divinizzato: obbedienza non solo al consumo, ma anche alla tecnologia digitale, o alla stessa strategia identitaria dell’imprenditoria del sé, grazie alla quale ad esempio le nuove forme psicotiche (le cosiddette ‘psicosi fredde’), normalizzandosi, sfuggono persino alla presa terapeutica.
Il libro: Foucault e le genealogie del dir-vero, a cura di mf - materiali foucaultiani, Cronopio, Napoli 2014.