Speciale
Canetti, la curiosità dello scrittore
L’anno prossimo verranno de-secretati gli sterminati diari di Canetti, per sua volontà solo a trent’anni dalla morte (1994): il cantiere dello scrittore sarà definitivamente aperto per soddisfare la curiosità dei lettori nei confronti del suo dialogo “col terribile partner” (come definì l’esercizio autoscopico in Potere e sopravvivenza), o quella, più morbosa, per la sua vita sentimentale, alimentata dalla recente pubblicazione degli Aforismi per Marie-Louise von Motesicky (Adelphi 2015), sua amante a Londra durante la guerra: una raccolta di appunti che lascia già presagire Massa e potere ma sfiora appena il privato di quest’ometto bruttino dai grossi occhiali – immagine decisamente incompatibile con il plastificato estetismo contemporaneo (l’epoca ‘social’ è dominata da una paradossale ignoranza voyeuristica: dalla coazione a guardare, più che a leggere e a conoscere). Dal canto suo, Canetti sapeva bene che cos’è, in termini foucaultiani, la volontà di sapere come brama di leggere e di vedere, inseparabile dal rifiuto di essere soltanto sé stessi – nel suo caso, un uomo piccolo e occhialuto; non si trattava però di una volgare forma di compensazione, bensì, appunto, di curiosità.
Innanzitutto per le facce: durante la sua lunga vecchiaia a Zurigo, l’Eden dal quale la madre lo aveva cacciato da bambino per condurlo in Germania e dove si sarebbe rifugiato negli anni settanta, Canetti usciva di casa solo per salire sui tram e osservare i volti dei viaggiatori. Questa singolare pulsione scopica ha nutrito la sua volontà di scrivere insieme al dolore dell’espulsione: “Il paradiso zurighese era finito, finiti gli unici anni di perfetta felicità. Forse se lei non mi avesse strappato da lì avrei continuato a essere felice. Ma è anche vero che venni a conoscenza di altre cose, diverse da quelle che sapevo in paradiso. È vero che io, come il primo uomo, nacqui veramente alla vita con la cacciata dal paradiso” (La lingua salvata). Con la stessa durezza con cui gli aveva insegnato in tre mesi il tedesco, la madre trasmise al figlio la curiosità per la realtà: “La realtà è tutto. Chi si ritrae dalla realtà non merita di vivere” (La lingua salvata), tantomeno di scrivere. L’ammonizione materna sul valore etico della realtà deve aver accompagnato Canetti ogniqualvolta s’immergeva nel tremendum et fascinans dello spazio interfacciale umano: nella brulicante varietà dei volti, che però per lo scrittore – come per il potente, ma in senso diametralmente opposto – tendono a essere trasparenti.
Chi esercita il potere e la violenza osserva il volto dell’altro come se fosse una ‘cosa’ (Ding o anche Stück, pezzo: l’ebreo nel lager nazista): la sua visione binoculare, panoramica e predatoria, è tanto curiosa quanto negatrice, sostenuta dall’implacabile opacità del proprio sguardo, della propria fissità soggettiva, insomma del proprio antimutamento (termine con cui Canetti identifica la triste rigidità del potente); l’intelligenza come proprietà e controllo dei pensieri implica che gli altri siano diafani e prevedibili, quindi stupidi e inferiori: la signoria sullo spazio interfacciale consiste nel combattere la curiosità altrui attraverso la costruzione di una maschera impenetrabile, immutabile, opaca agli occhi del servo, il cui volto viene invece trafitto con reificante invadenza.
Anche per lo scrittore nessun volto è opaco, ma l’imponderabile fonte della sua curiosità trapassa in pietà metamorfica: lo sguardo di Canetti scruta le facce allo stesso modo in cui le sue orecchie ascoltano le urla strazianti dei pazzi rinchiusi nello Steinhof, a Vienna, negli anni in cui progetta di scrivere una Comédie humaine dei folli, o, anni dopo, le voci incomprensibili degli abitanti della Mellah, il ghetto ebraico di Marrakech: “Alla categoria delle qualità ultime appartiene […] la mia passione per le persone. Si può descriverla, si può rappresentarla – la sua origine deve restare oscura per sempre” (Il gioco degli occhi) – forse perché è legata alla paura. “L’unica passione della mia vita è stata la paura” ha scritto Hobbes, di cui Canetti interpreta, in Massa e potere, un’altra celebre frase: “Il riso è la subitanea sensazione di superiorità” – è l’inaspettata e quindi irreprimibile “compulsione fisica” di colui che invece (o prima) di straziarla, indugia con lo sguardo sullo “spettacolo” della vittima, ma anche di chi, ridendo, cerca di vincere la paura. In effetti, soltanto l’uomo ride di sé stesso e dell’inferiorità dell’altro, come pure della soddisfazione della propria curiosità – che poi è quella del viaggiatore: “Quando si viaggia […] lo sdegno rimane a casa. Si osserva, si ascolta, ci si entusiasma per le cose più atroci solo perché sono nuove”; “i buoni viaggiatori sono gente senza cuore” (Le voci di Marrakech), cioè senza paura di abbandonarsi alla novità.
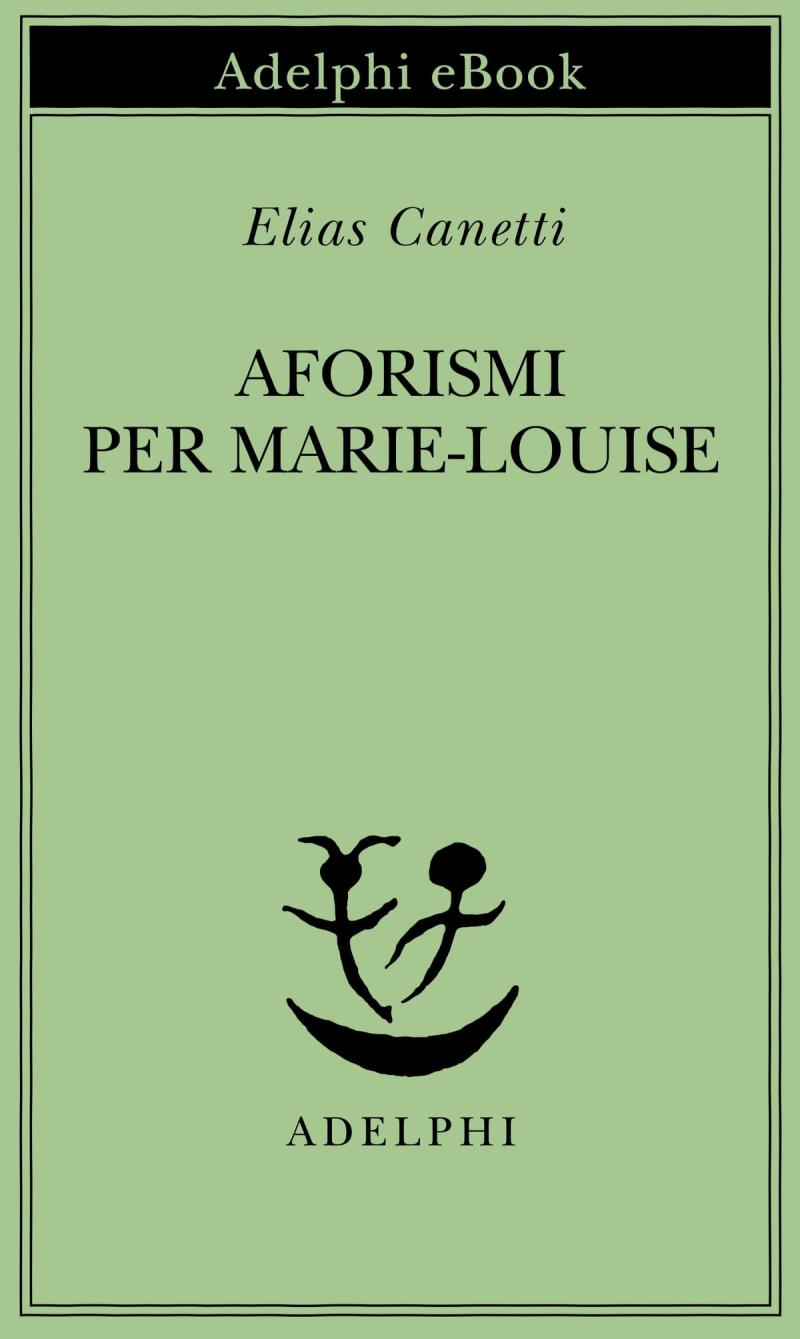
Se insomma “tutto sta nel rapporto tra il riso e la meraviglia” (Aforismi per Marie-Louise), si potrebbe suggerire che la curiosità vince la paura nella misura in cui fa paura. L’occhio intrusivo del potere è figlio del terrore di toccare, di trasformarsi nell’altro: per superare la fobia da contatto metamorfico, l’uomo asseconda il suo meta-animalesco desiderio di afferrare, smontare, ‘aprire’ l’altro, riducendolo, direbbe Sloterdijk, a oggetto di esplicitazione (Explizierung).
Per seguire questa pista dobbiamo rinunciare alla semantica buonista della curiosità come stupore infantile e prefilosofico, opponendo al paludamento moralistico-interdittivo della sua aggressività (Non guardare e non toccare, altrimenti verrai punito!) uno spostamento nietzschiano delle prospettive. Per esplicitare la verità della ‘volontà di sapere’ (titolo del primo corso di Foucault al Collège de France, non a caso dedicato allo smontaggio della contemplazione aristotelica della ‘realtà’) dobbiamo cioè passare dalle conseguenze della pulsione scopica sul soggetto della curiosità, alle conseguenze sul suo oggetto: la curiosità uccide non tanto chi viola il tabù, ma la vittima della sua violazione. La curiosità è an-etica. Al di sotto della sua etimologia medievale (XIII secolo), la curiositas nasconde infatti una doppia richiesta, o meglio una richiesta che si trasforma insensibilmente in inchiesta: ben lungi dall’essere semplicemente premuroso e sollecito, il curioso è colui che chiede qualcosa a qualcuno senza motivo – si pensi al quaerere latino: la quaestio è l’indagine come pura sete di conoscenza (e di verità) che però trapassa facilmente in fame, ovvero in desiderio non benevolo di vedere, ascoltare, capire e così carpire, prendere e possedere – in petere, chiedere per ottenere. La curiosità è la madre della sapienza perché săpĕre, assaggiare e quindi conoscere, significa afferrare e incorporare l’oggetto (vengono in mente le pagine di Massa e potere dedicate alla mano e alla bocca come organi del potere). Ad essere bizzarro e mostruoso non è dunque ciò che viene ‘aperto’ e dissezionato, ma il movimento stesso dello squarciare per vedere cosa c’è dentro, che assomiglia al gesto con cui i bambini sollevano il guscio delle chiocciole per guardarle sciogliersi al sole, ma anche alla selvaggia precisione con cui il cieco, in Auto da fé, taglia la gobba del nano Fischerle.
Anche la scrittura ha in sé qualcosa di questa volontà di sapienza e di potenza: lo scrittore è “il custode delle metamorfosi” (La missione dello scrittore) perché ne è curioso; ma per osservare e descrivere senza paura le trasformazioni dei viventi – la più mostruosa delle quali è la morte –, bisogna saperle persino produrre. Il contraltare del rifiuto canettiano della morte – il rifiuto di abbandonarvisi e di accettarla in nome di una passione etico-mnestica – sta dunque nella curiosità per la morte, che, se non il desiderio di procurarla per stare a guardare, nasconde la capacità di sopportare la vista del cadavere, nonché il “sentimento del cimitero” (Massa e potere), l’inconfessabile soddisfazione di sopravvivere alla massa dei defunti. Pur non essendo mai disgiunta dalla protesta (cfr. il postumo Libro contro la morte, Adelphi 2017), la curiosità di Canetti per la morte è tanto manifesta, nonché associata al coraggio di guardarla in faccia – si pensi alla riproduzione della Pala di Isenheim di Grünewald ch’egli teneva appesa alla parete della sua camera da studente a Vienna –, quanto ironicamente adombrata dai plot delle sue commedie – soprattutto Vite a scadenza (1956).
In entrambi i casi, si direbbe che solo la “conoscenza più nera” (La provincia dell’uomo) della morte salva dalla morte, e che quest’oscura conoscenza autoptica non coincide con la lettura, bensì con la scrittura: “Spesso ho l’impressione che tutto quello che imparo e leggo sia inventato. Ma quanto io stesso scopro è come se in verità ci fosse da sempre” (La provincia dell’uomo). Quest’appunto, che risale alle interminabili letture preparatorie di Massa e potere, allude allo sforzo di convertire lo sprezzante soggettivismo di Peter Kien, cioè di Canetti stesso, in metamorfosi. Il compito dello scrittore non è “leggere in continuazione” (La lingua salvata: ciò conduce al rogo dei libri che conclude Auto da fé), ma guardare e ascoltare la realtà: egli deve passare dalla volontà di sapere e di uccidere, essa stessa mortale, alla sublimazione scritturale della curiosità.
Canetti ha oscillato per tutta la vita tra l’odio per gli esseri umani (che sarà letteralmente proiettato nell’analisi del potere, come di tutto ciò che è mostruosamente grande) e l’interesse per il piccolo, l’effimero e il marginale – una curiosità profondamente ebraica che condivide con Kafka e Benjamin, e in cui ha metaforizzato, cioè letteralmente trasferito, la volontà di sopravvivenza. La pulsione scopica esplicitante e aggressiva è stata parimenti temperata da quella acustica, che tende allo scioglimento dell’io nei suoni, anziché nella massa; ma, per diventare un “testimone auricolare” (Il frutto del fuoco) della realtà, Canetti ha dovuto affinare la propria feroce capacità di guardarla e de-scriverla – di decostruirla – senza essere travolto dalla paura: “Mostro tanto sprezzo per la realtà solo perché mi impressiona in modo così tremendo. Non è neppure più quella che gli altri chiamano realtà, né rigida né invariabile, né azione né cosa: è come una foresta vergine che cresce dinanzi ai miei occhi, e mentre cresce, accade in essa tutto ciò che fa parte della vita di una foresta vergine” (La provincia dell’uomo). Si direbbe che lo scrittore provi a epochizzare l’abitudine alla realtà per incontrare il reale, dacché per lui la cacciata dal paradiso ha coinciso con l’ingresso in un sublime inferno metamorfico: obbedendo all’imperativo etico della madre, Canetti ha dominato “l’impeto raccapricciante con cui la realtà ci si scaglia contro”, minacciando di divorarci – ha lottato contro questa “belva splendente” con l’omeopatica curiosità della scrittura. Come forma di sopravvivenza alternativa a quella, fallimentare, del potere, e a quella illusoria della fede, essa presuppone una sistematica violazione del mistero del reale – e della morte – traducibile in una paradossale modifica del motto wittgensteiniano: di ciò di cui non si può parlare, si deve scrivere.









