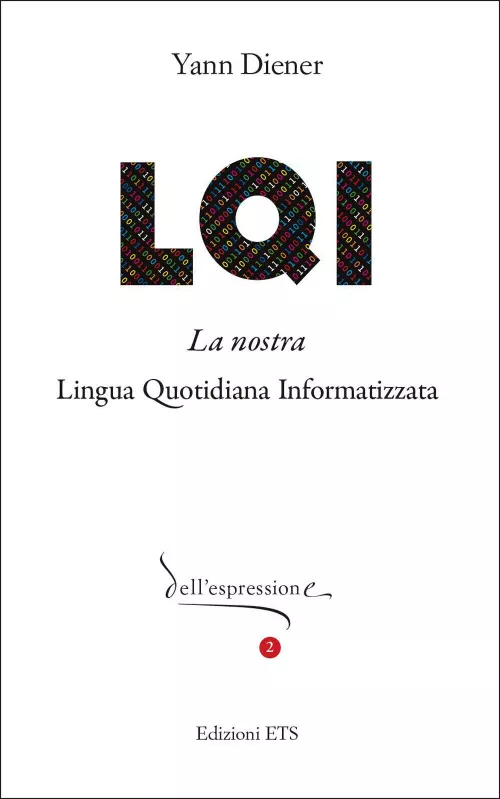Una lingua senza io
Siamo tutti sommersi dall’imperiosa richiesta di password da parte dei tanti device con cui quotidianamente interagiamo. E guai a non ricordarsele. Ciò darebbe luogo all’apertura di un vero e proprio conflitto con l’Istituzione Informatica che, come prima cosa, ci sbarrerebbe l’accesso alle attività fondamentali della nostra socialità (come lavorare o mettersi in contatto con la propria cerchia di persone intime) e quindi ci prospetterebbe una tortuosissima via d’uscita per riprendere possesso della nostra identità: esibire documenti, dimostrare di non essere un robot [!!!], infarcire la nostra parola d’elezione di caratteri impossibili da memorizzare, di questo passo aprendo la via a una nuova dimenticanza e alla ripetizione ad infinitum di un tale calvario.
Durante la nostra vita quotidiana, innumerevoli sono le occasioni per cui siamo chiamati a identificarci univocamente, riducendo la volatilità delle nostre appartenenze, l’impermanenza delle nostre relazioni, la complessità delle nostre qualifiche come dei nostri umori, a una lista di opzioni già in qualche modo previste dal sistema, assunte – è il caso di dirlo – meccanicamente e ripetutamente. La nostra vita deve essere codificata e una tale evenienza ci sembra perfino normale.
Ci vuol poco, infatti, perché l’imperativo alla precisione informatica venga da ognuno interiorizzato al punto da apparire naturale, in modo che non sia facile distinguerne univocamente e una volta e per tutte i confini. Viene, per esempio, prima la propensione tanto in voga di questi tempi a (iper)definire (innanzitutto a sé stessi) il proprio orientamento sessuale o le schede di profilazione in cui a ogni occasione buona siamo chiamati a dichiararlo?
A porre la questione davvero generale di come la lingua dell’informatica e i suoi protocolli possano averci cambiato, arriva LQI. La nostra Lingua Quotidiana Informatizzata, da poco pubblicato nella collana “dell’espressione” dell’editore ETS diretta da Nunzio La Fauci, scritto come uno zibaldone dallo psicanalista francese Yann Diener – collaboratore di Charlie Hebdo e autore di alcuni fondamentali lavori sul rapporto fra lingua e psiche – tradotto e curato dallo stesso La Fauci e da Francesco Paolo Alexandre Madonia.
Ma cosa potrà mai avere di speciale la lingua informatizzata che già al giorno d’oggi quotidianamente parliamo? Per capirlo si può fare rifermento a una nozione di base della disciplina linguistica strutturale, per la prima volta rilevata da Ferdinand de Saussure. Egli usava distinguere langue, a indicare gli aspetti sistematici e astratti della lingua, e parole con cui, invece, si riferiva alla convocazione e all’appropriazione individuale di tali aspetti sistematici nell’uso concreto posto in essere da ogni parlante. La dicotomia in questione descrive, dunque, una qualità fondamentale delle lingue, quella di essere sociali e individuali allo stesso tempo: non si dà lingua senza un “codice” comune ma, allo stesso tempo, tale codice deve possedere maglie abbastanza larghe da permettere a ognuno nelle più disparate situazioni di trovarvi posto, in qualche modo appropriandosene. Se è facile immaginare la babele che scaturirebbe dal cancellare gli aspetti sociali della lingua – ciò che abbiamo definito langue – in nome del primato dell’espressione individuale (la parole), cosa potrebbe, invece, succedere se a prendere il sopravvento fosse la langue a discapito della parole, comprimendone ruolo e spazio vitale, è meno evidente. Per immaginare una situazione di questo genere, sostiene Diener, non serva affatto procedere per assurdo, perché è proprio la lingua dell’informatica a mostrarcelo. Un tale mondo è, infatti e letteralmente, sotto i nostri occhi, permeando di sé ogni aspetto del presente.
Si tratta di un mondo plasmato dalla comunicazione mediata dalle macchine, comunicazione intesa, quindi, come l’avrebbero intesa Shannon e Weaver i due matematici/ingegneri della compagnia dei telefoni americana che per primi ne modellizzarono lo schema. Mondo di cui il “libretto” di Diener (di sole 115 pagine, ma di vero spessore teorico) si propone come una critica. Che, attenzione, non ci tiene a essere militante né apocalittica, non nasconde dietro di sé alcun progetto “politico” di restaurazione di presunti bei vecchi tempi perduti, ma intende, piuttosto, presentarsi come testimonianza tanto estrema quanto ironica di uno scarto epocale, come si trattasse di una cartolina inviata ai posteri da un passato remoto in cui era ancora possibile riconoscere, indicandola, la differenza fra parola e comunicazione. Differenza che, manco a dirlo, oggi appare sempre più sfumata fino a implodere in sé stessa.

Prova ne sia che il fatto che, come si diceva, sempre più spesso consideriamo la lingua informatizzata – la lingua della comunicazione – come lingua naturale ed è necessario il lavoro dell’autore per far avvertire tutto lo scarto che le separa. Indubbiamente affascinante è, poi, il fatto che a intestarsi una tale titanica missione possa essere uno psicanalista, cioè uno che per vocazione crede nella responsabilità della parola e dell’espressione umana sulla salute fisica prima che psichica dell’essere umano. Con un metodo specifico, quello di andare a caccia dell’aberrazione – della patologia – nell’ovvio della vita quotidiana (realizzandone dunque una psicopatologia), grazie al fatto di proporne, a proprio e altrui beneficio, un qualche resoconto.
Resoconto quindi. Ma anche genealogia. Perché Diener chiama in causa anche le condizioni materiali attraverso cui la lingua dell’informatica ad un certo punto della modernità viene effettivamente immaginata e modellata da soggetti precisi, di cui è pur sempre possibile rivalutare gli itinerari esistenziali ed intellettuali. È così che il volume applica lo stesso metodo psicopatologico anche alle biografie dei protagonisti agli albori dell’informatica, in un felice connubio fra le loro nevrosi e quelle del presente.
In questa prospettiva può, pertanto, essere utile chiedersi cosa possa mai aver indotto uno come Alan Turing a procedere all’elaborazione del primo rudimentale codice informatico della storia. Ci dice lo psicanalista Diener di come il suo profilo psicologico avrebbe potuto già dalla tenera età essere preso in esame per la sua peculiarità: “È capace di restare per ore disteso su un prato a guardare una pianta crescere, cercando di capire come funziona” si ricorda, per esempio, ad un certo punto in una delle sue biografie.
Turing vince negli anni 30 una borsa di dottorato a Cambridge, pubblicando il primo paper (“On computable numbers”) in cui fondando l’informatica moderna procede all’ideazione di un calcolatore in grado di eseguire alcuni compiti in maniera automatica. Perché ciò possa avvenire, però, bisogna che le istruzioni vengano espresse in un codice specifico.
Ci vorrà poco (siamo nel biennio 37-38) perché passi a concentrarsi sulla decrittazione, ideando la prima macchina in grado di sciogliere enigmi, intitolata Oracle, termine non casualmente preso in prestito dal lessico religioso. Sarà ancora successivamente che il nostro potrà essere arruolato nei servizi segreti britannici e chiamato a cimentarsi con il famoso Enigma, la macchina utilizzata dai nazisti per coprire le loro conversazioni. Turing riuscirà a decrittarne i messaggi grazie all’idea di fondo della sua teoria, eseguire automaticamente e rapidamente compiti ripetitivi. Per penetrare i segreti del codice nazista non gli risulterà, anche visto il suo peculiare profilo psicologico, difficile replicare, nel codice, il loro modus operandi. È così che, grazie alle sue teorie proto-informatiche, indirettamente finirà per sdoganare il modo di pensare – costituito da una vera e propria ossessione burocratica e classificatoria – del nemico.
La lingua informatizzata è, infatti, funzionale all’operazione fondamentale della comunicazione, quella di codifica / decodifica. Per facilitare questo processo essa deve proporsi come metalinguaggio, codice artificiale progettato con l’obiettivo di ridurre l’ambiguità insita nelle lingue naturali. Come a dire che quella artificiale deve essere una lingua “economica” ovvero orientata alla trasmissione, veicolando su di sé quante più informazioni possibili, senza accavallamenti e contraddizioni, senza vaghezza e ambiguità.
Si potrebbe obiettare che un tale modo di procedere non sia prerogativa esclusiva del solo codice informatico ma che possa essere considerato tipico di ogni linguaggio scientifico. Vero. Il metalinguaggio delle scienze dure, della fisica o della biologia, si propone in fondo obiettivi non troppo dissimili. La differenza sta, però, nel fatto che il suo uso rimane confinato al laboratorio e ai trattati scientifici: la sua accuratezza è insomma direttamente proporzionale alla sua marginalità. Ecco perché nessuno scienziato, nessun fisico o biologo si rivolgerebbe alla moglie o al proprio marito, ai parenti durante un pranzo di famiglia, agli amici di partitella il venerdì sera utilizzando il lessico della propria disciplina.
Al contrario, la lingua dell’informatica, con i suoi criteri di economicità ed efficacia, scavalca questo confine, pretende di sostituirsi alle lingue naturali, imponendo le proprie griglie, il proprio lessico, la propria precisione chirurgica e spietata semplificazione alla comunicazione umana, concentrandosi ossessivamente sulle operazioni di codifica e decodifica. È così che i parlanti finiscono per perdere dimestichezza con le costruzioni retoriche complesse che richiedano un orientamento testuale: sarcasmo, ironia, metafore, allegorie, iperboli vengono sempre più spesso, sui social come nei dibattiti televisivi, prese alla lettera, interpretate meccanicamente come semplice sommatoria di parole. Con il risultato di innescare giganteschi fraintendimenti, determinati, per l’appunto, da una visione del linguaggio semplificata, incapace di gestire l’ambiguità, una visione del linguaggio senza parole e pertanto senza soggettività, pura burocrazia. Il profilo di Turing – che verrebbe dalla moderna psichiatria considerato autistico – ha, si capisce, quindi, finito per modellare su di sé la comunicazione umana. Ed ha cacciato l’uomo nella medesima condizione di Edipo, il quale ha gioco facile a risolvere l’Enigma rivoltogli dalla Sfinge ma perde consapevolezza di sé, non vede i rapporti di forza e causali all’interno dei quali si ritrova imbrigliato. L’uomo moderno, sommerso da una mole infinita di dati da decrittare, perde la capacità di trovare un senso alla propria esistenza. Si perde, insomma, nell’Enigma.
Conseguenza non secondaria di tale semplificazione è che applicare il metalinguaggio dell’informatica al mondo, codificandone ogni anfratto, imponga un enorme carico di lavoro ai parlanti. Lo sanno bene i medici (ma anche i professori universitari) sempre più chiamati a dedicare ore preziose del proprio lavoro a compilare scartoffie elettroniche, a seguire infiniti scambi di email, a smistare l’imponente mole di informazioni che transitano dai loro device. Contro tutto ciò, si può forse ancora scegliere, come è successo in Francia, di fare sciopero. Uno sciopero contro la gergoafasia dei nostri anni, che processando incessabilmente brandelli di realtà senza criterio, finisce col connettere tutto con tutto. E, per questa via, perdere il controllo.
Alla soglia della terza guerra mondiale, verrebbe da dire che ci siamo quasi.