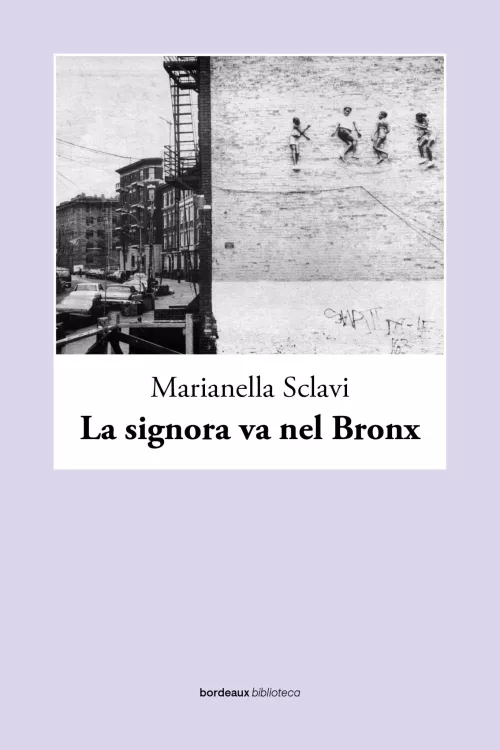La signora va nel Bronx
Il Bronx nell’immaginario collettivo occupa un posto di tutto riguardo. È almeno a partire dagli anni 70 che il suo nome viene collegato alle peggiori nefandezze, evocando quanto di più negativo le città siano mai state in grado di produrre: droga, violenza, degrado, rovine. “Luogo di perdizione”, “distopia urbana realizzata”, “inferno metropolitano” sono alcuni degli epiteti affibbiati a questo borough della grande mela, così difficile e problematico, la cui stessa esistenza poteva suonare a molti come uno scandalo: come può una metropoli del calibro di New York, la capitale dell’impero, essersi dovuta ritrovare a fare i conti con un luogo tanto malmesso?
Ci vuol poco, poi, perché il suo itinerario venga indicato come paradigmatico: sganciato dal suo contesto storico-antropologico, dalla sua specificità di luogo, il Bronx diventa velocemente metafora, simbolo assoluto della malattia mortale della città, di modo che ogni quartiere difficile dislocato da qualsiasi parte del mondo possa esservi riferito, assumendo le sembianze di “Bronx” del suo angolo di cielo: anche a Palermo, la città da cui scrivo, le borgate più problematiche come lo Zen, il Cep o Borgo Nuovo, sono non di rado state appellate con un tale riferimento.
È con l’intento di scalfire la monoliticità di una tale visione distopica “assoluta” che Marinella Sclavi, bianca, borghese e con una decorosa vita da professore universitario a Manhattan, si reca, agli inizi degli anni 90, proprio nel Bronx, decisa a batterlo in lungo e in largo alla ricerca di una fotografia più accurata del suo clima intellettuale e morale e interessata a sperimentarne la quotidianità di luogo concreto, oltre le astrazioni dei tanti che prima di lei si erano esercitati a tessere una teoria della sua inadeguatezza. Ne viene fuori quello che non sarebbe esagerato riconoscere come un vero e proprio classico della sociologia urbana, La signora va nel Bronx, uscito nel 1994 per l’editore Anabasi, ripubblicato nel 2006 da Bruno Mondadori e da poco riapprodato in libreria con una nuova prefazione di Francesco Careri, grazie all’editore Bordeaux (300 pp., € 18).
“Prima devi leggerti tutti i libri già scritti sul Bronx” questa è l’indicazione che, come si spiega fin dalle prime pagine, Marianella Sclavi riceve da molti dei suoi colleghi, una volta messi a parte del suo proposito di recarsi nel quartiere. A cui senza soluzione di continuità sarebbe seguita un’ennesima raccomandazione: “vacci, però, munita di fucile”: libri e fucili – mi viene da pensare non appena aperto il volume – due arnesi così diversi che però paradossalmente nei riguardi dei luoghi devianti e dei soggetti marginali vanno di regola a braccetto facendosi l’uno forza dell’altro. Da una parte, il paternalismo dei tanti volumi sulla devianza scritti da “esperti” che mai avrebbero messo piede né frequentato i medesimi luoghi di cui vorrebbero offrire la chiave, dall’altra, l’ostilità, la diffidenza, il disprezzo malamente mascherato dall’ironia di una “battuta” come quella appena riportata sulla necessità di dotarsi di appropriate tutele qualora si fosse stati davvero così “sfortunati” da doverci passare attraverso.
Ma Marianella Sclavi non si lascia scoraggiare, non dà retta ai suoi colleghi, non legge le tonnellate di scartoffie che nel tempo si sono accumulate sulla specialità del Bronx né tantomeno si dota di fucile e ci va lo stesso. Le pagine che seguono sono il resoconto etnografico delle sue incursioni, straordinario esempio di come si fa un lavoro del genere (cosa cercare, come guardare, come comportarsi) e insieme, una ricostruzione accurata della vita del quartiere dall’interno, ricca di storie e personaggi di grande umanità oltre che di preziose indicazioni utili a riconoscere il valore sociale degli spazi marginali di regola oscurato dallo stereotipo, con l’idea che sia proprio la capacità di riconoscere un tale valore il primo passo verso l’emancipazione.
E allora come concretamente mettersi all’opera verso un tale compito? Si può tranquillamente cominciare dal caso. È proprio la capacità di sapere approfittare della volatilità delle occasioni a costituire la prima indicazione “metodologica” per il ricercatore impegnato nella lettura del resoconto: “Maria sapeva per esperienza che quando si conduce una ricerca con la necessaria pazienza e perseveranza, è proprio quando meno te lo aspetti che ti si presentano gli agganci, le informazioni, gli indizi più preziosi. Un buon ricercatore si differenzia da uno mediocre proprio per la capacità di cogliere al volo queste occasioni”. L'opportunità a partire da cui riuscire a penetrare nel quartiere si presenta a Sclavi a tavola, durante una cena di natale, nel momento in cui uno dei commensali fra una portata e l’altra le parla del figlio, laureato in legge a Yale, e della sua esperienza in difesa dei “diritti del poveri”, “nel cuore del Bronx”, “crogiuolo di idee”, a suo dire, fra i più interessanti d’America.
Una tale indicazione colpisce Marianella, evocandole suggestioni opposte. Per un verso, l’idea di iniziare la ricerca dal “cuore del Bronx” incute paura ma, d’altra parte, riscalda: il cuore del Bronx promette, insomma, pericolo ma anche, come ogni cuore che si rispetti, passione. Ci vuol poco perché, per il tramite del suo casuale collegamento, Sclavi possa venire a contatto con Banana Kelly, comitato civico nato negli anni 70 nel South Bronx, che al suono dello slogan “don’t move, improve” era già riuscito a ottenere risultati inimmaginabili, in termini di rigenerazione urbana ed emancipazione sociale, decidendo di andare a sentire di persona, proprio “nel cuore del Bronx”, i suoi animatori. Il resoconto che ne deriva si caratterizza per mettere insieme la descrizione dell’universo emozionale delle parti in causa – osservatrice compresa – con l’esposizione dei fatti propriamente detti. Ed è allora che lo stato d’animo della professoressa italiana bianca in metro direzione Bronx coglie perfettamente l’ambivalenza che chi si appresta ad attraversare da una posizione di privilegio lo spazio esotico della periferia sente: entusiasmo frammisto a paura. E a far testo in questo caso sono proprio le paturnie esistenziali dei pensieri che nella mente di Maria si affastellano: come attraversare un posto del genere senza lasciarsi andare al pregiudizio? Come classificare gli utenti della metro sulla scala della pericolosità? Sulla base di quale criterio, se non quello di un razzismo latente e istintivo, un nero dovrebbe essere più pericoloso di un bianco? O una donna meno pericolosa di un uomo? “Meriti di venire assalita da una donna di mezza età con l’espetto di una dattilografa” è la battuta che sortisce il duplice effetto di sdrammatizzare la paura e di rendere accattivante la lettura.
Tutto l’itinerario seguito da Maria, il percorso lungo la metropolitana, l’avvicendarsi dei passeggeri fra una fermata e l’altra, la passeggiata fino a Kelly Street sede del comitato sono raccontati al-ralenti, in modo che ogni dettaglio trovi una corrispondenza, risuoni, con l’esperienza. Avvincente.
Ed è così che si apre la fase di esplorazione, suddivisa in tre grandi sezioni. Nella prima si dà conto dell’esperienza di Banana Kelly, ricostruendone il ruolo nella storia di risanamento intrapresa dal Bronx. Nella seconda, si mette in atto una tattica di shadowing di alcuni cittadini del quartiere, seguiti lungo la loro vita quotidiana, nella terza si chiama in causa il ruolo della scuola, la cui esplorazione viene raccontata per differenza con l’esperienza di osservazione già condotta da Sclavi in scuole italiane. Ognuna delle tre sezioni è ricca di notizie e indicazioni di metodo significative.
A rendere ancora più preziosa l’esplorazione di Sclavi, c’è poi anche il fatto che, proprio a partire dal periodo in cui è stata portata avanti, il Bronx stava, come poco sopra si accennava, intraprendendo un percorso che lo avrebbe portato ad affrancarsi dal disastro, dando il via a un colossale processo di rigenerazione urbana che arriva al giorno d’oggi. Da qualche tempo, del Bronx, infatti, non si sente più parlare: sono pochi i film che al giorno d’oggi lo chiamano in causa come teatro di scontri fra bande, popolato da mafiosi e spacciatori di droga magari ripresi come da cliché a scaldarsi ai margini delle strade con falò improvvisati sui bidoni della benzina. Tutto questo appartiene al passato. Un passato che seppur rimanga sospeso a galleggiare nell’immaginario non corrisponde più, nell'insieme, alla vita quotidiana del quartiere.
Di come il Bronx possa essere riuscito a salvarsi da solo, nessuno, però, dice. La signora va nel Bronx aiuta a capire cosa possa essere successo (e, per certi versi cosa stia ancora succedendo), ritrovando nel bel mezzo dell’inferno metropolitano i primi segnali di riabilitazione. È proprio per via di una tale fortuita sincronicità che il volume può a posteriori apparire come uno studio di caso sulla strada giusta da intraprendere, utile per chi voglia impegnarsi in percorsi di risanamento nel proprio contesto di azione, rifuggendo (in nome dell’umorismo, lo si vedrà) dagli approcci apocalittici alla Leslie Kern, oggi à la page.
La storia del quartiere, del comitato di Banana Kelly e più in generale dell’associazionismo che tanta parte avrà nella sua emancipazione, viene raccontata dall’attivista Harry de Rienzo. Non tutti sanno, infatti, che il Bronx sia stato per molti anni un quartiere agiato di New York, almeno fino alla fine della guerra. Esso veniva guardato come luogo d’approdo appetibile da molti newcomers, come la famiglia Potts, la quale riuscì a comprare un’intera palazzina in zona, bruscamente messa sul mercato dal precedente proprietario, ad un prezzo accessibile perfino a gente come loro, afroamericani alle prese con l’epico esodo della loro comunità verso il Nord del paese. Fatto sta che i Potts diventano proprietari dell’immobile in un Bronx ancora agiato, giusto un attimo prima della sua deflagrazione. Il loro approccio si contraddistingue per essere improntato a una cauta amministrazione delle proprietà (presto riusciranno ad acquistare una seconda casa oltre a quella che già possedevano), con un atteggiamento orientato alla “manutenzione” dell’esistente. Intorno a loro, invece, le case iniziano a essere derubate di ogni suppellettile, perfino dei tubi dell’acqua, una tal evenienza portando la maggior parte dei proprietari a disamorarsene. In un contesto del genere, non è difficile immaginare come molti cittadini (sia proprietari che inquilini) avrebbero volentieri abbandonato il campo, lasciando i loro immobili esposti all’incuria. Diversi edifici vengono, perfino, incendiati: dato che le banche non concedono mutui per permetterne la compravendita meglio dargli fuoco. Questi appartamenti devastati e le loro macerie diventano così luoghi di prostituzione e spaccio, presidiati da violenti senza scrupoli. Basta che una sola palazzina cada in un tale stato d’abbandono per “contagiare” velocemente l’intero isolato, producendo intorno a sé uno scenario di desolazione e rovine. Un tale stato di cose rende il quartiere un luogo da cui fuggire: chiunque ne abbia la possibilità sceglie di trasferirsi altrove, lasciando i ruderi in cui era stato costretto fino a quel momento ad abitare vuoti, in attesa di essere depredati od occupati da inquilini ancora più poveri e inermi. Di fronte a un tale scempio, alcune zone del quartiere perdono fino al 75% della loro popolazione.
La risposta delle autorità rivela tutta la sua inadeguatezza: le forze di polizia non riescono, infatti, a tenere a bada l’ordine pubblico né a impedire i quotidiani incendi. D’altra parte, la ricetta dei politici per uscire dal guado si sarebbe presto dimostrata altrettanto insufficiente, incentrato, sulla scia delle teorie di Robert Moses, su ruspe e ricostruzione su larga scala di edifici nuovi di zecca destinati a fare in breve tempo la stessa fine di quelli di cui avevano preso il posto.
Un primo passo avanti decisivo viene fatto con l’acquisizione comunale degli appartamenti i cui proprietari fossero stati in debito con il versamento delle tasse e non si occupassero della manutenzione. In poco tempo, il comune si ritrova proprietario di migliaia di abitazioni che, non avendo la capacità di gestire, rimette velocemente sul mercato a prezzi stracciati. In uno scenario del genere trova posto l’intervento dei Potts e del loro comitato di Banana Kelly, che si forma sulla base dell’esempio di un altro comitato vicino, per rappresentare gli inquilini e costringere il comune a farsi carico della gestione degli edifici acquisiti, piuttosto che a svendere. Con il passar del tempo, il comitato riesce anche ad ottenere il consenso per attivare un programma che permettesse a volontari di riscattare la proprietà delle abitazioni in cambio del lavoro di ristrutturazione. Questi esperimenti ribaltano completamente la logica urbanistica di Robert Moses fino a quel momento imperante, innescando un meccanismo virtuoso per cui i tanti giovani del quartiere senza arte e né parte, manovalanza per bande criminali e droga, vengono invitati a imparare un mestiere (chi carpentiere, chi muratore, chi elettricista) e ad impegnarsi per la manutenzione del loro territorio. Banana Kelly comincia con una dozzina di volontari e presto diventa un modello per tutta la città, “salvando” dalla distruzione intere aree, grazie al restauro di migliaia di edifici, alla demolizione di quelli irrecuperabili rimpiazzati da parchi pubblici e strutture di servizio.
Riassumere il quadro delle iniziative intraprese, la profondità della discussione critica ed esistenziale improntata da Sclavi nella relazione con i suoi interlocutori bronxesi è impresa ardua ed esonda i limiti di queste righe, ragion per cui rimandiamo alla lettura del volume, sicuri della sua attrattiva anche per i non addetti ai lavori. La scrittura di Marianella Sclavi si contraddistingue, infatti, per la sua levità, il ritmo, l’umorismo, in grado di dar vita a una narrazione avvincente a prescindere dal suo davvero notevole interesse scientifico. Si può, così, scegliere di leggere questo volume anche come un’opera letteraria, interessata a scommettere sul potere della narrazione come veicolo di un vero “ascolto attivo” fra i soggetti implicati nella vita comune. Puntare sulla messa in forma di un racconto dell’esperienza vissuta implica, per Sclavi, infatti, scommettere sulla sua intellegibilità a vantaggio del prossimo. Ciò nella convinzione che a muovere la condotta di ognuno – dei professori universitari come dei criminali – non possa che esservi una qualche ragionevolezza, da ricostruire in una trama condivisa. Il testo diventa così il luogo dell’incontro/scontro fra ragioni diverse chiamate a negoziare la propria posizione con quella dell’altro in una “versione” dei fatti sempre perfettibile. E ciò vale, come si è visto sopra, anche e forse soprattutto per chi tesse le trame del racconto. Al proposito, mi colpisce la scelta di campo di Sclavi di rappresentarsi nelle proprie esplorazioni e conversazioni nel quartiere, alla terza persona, assumendo le sembianze della sociologa Maria, descritta da un narratore esterno alla stessa stregua degli altri personaggi rappresentati: un modo brillante di risolvere il problema della responsabilità del ricercatore. Tale responsabilità – reazioni emotive, battute, incongruità – fa parte del corpus d’analisi e viene, pertanto, messa in forma dall’alto e da lontano, in una sorta di felice sdoppiamento fra la Marianella narratrice/analista e la Maria narrata/imbrigliata nelle conversazioni.
Non è un caso il fatto che la terza persona verrà dismessa nel capitolo conclusivo del volume in cui l’analista prenderà il sopravvento e si tireranno le somme teoriche, metodologiche e politiche di quanto raccontato.