Animali non come noi
È una delle sensazioni più comuni, oggi. Gli animali, ad eccezione di cani e gatti, sembrano non esistere più. Le campagne sono vuote, gli animali selvatici che percorrono le città o sono quasi invisibili, come gli insetti, o stravaganti eccezioni, come le volpi e i cinghiali. L’animale è stato retrocesso tra gli oggetti di un passato rurale e imperfetto, sostituito con strumenti più efficienti e meno impegnativi da mantenere. Né tantomeno ci sembra accettabile l’idea di essere noi stessi animali. Anche quando lo dichiariamo a parole, difficilmente lo crediamo fino in fondo: se siamo uomini è perché abbiamo qualcosa in più rispetto agli animali.
Anche se non ce lo diciamo, insomma, abbiamo la convinzione profonda di essere superiori. In definitiva ci siamo costruiti l’idea di essere rimasti i padroni del pianeta perché siamo la specie più intelligente, che ha saputo distanziarsi dalla natura e produrre arte e cultura. Andiamo avanti in questo modo da qualche secolo, ma abbiamo dato una brusca scossa al sistema negli ultimi decenni, nonostante l’ambientalismo, l’animalismo, la consapevolezza delle estinzioni di massa che provochiamo alle specie animali. È come se avessimo imparato la teoria, ma nella pratica stentassimo a credere davvero a quanto noi stessi amiamo ripeterci.
Ma, come ci ricorda Roberto Marchesini – etologo, zooantropologo, filosofo –, dimenticarsi degli animali significa mettere da parte il meccanismo che ci ha permesso di diventare umani. Homo sapiens, afferma in L’amore per gli animali (Lindau), è tale perché aperto all’acquisizione di elementi dalle altre specie. È la disponibilità ad accogliere l’altro che ci ha reso specie dominante (o, secondo altra prospettiva, invasiva). Ma l’altro, il cosiddetto eterospecifico, non è mai materia bruta da plasmare come se non avesse una personalità. La relazione non si fonda sulla passività di una delle due componenti. Relazione significa confronto, scambio di opinioni, contrasti, incomprensioni, grandi slanci d’amore e odi profondi.
Marchesini fa capire quanto questo sia stato fondamentale nel corso del tempo per costruire l’umanità, a partire dai contatti con gli animali che Sapiens ha iniziato a cacciare nel Paleolitico – ogni cacciatore deve conoscere le abitudini della preda, come ha raccontato Roberto Calasso in Il cacciatore celeste (Adelphi) – per poi passare, attraverso la decisiva relazione con il cane (chiave di volta della nostra storia di specie, come la lavorazione della pietra e la scoperta del fuoco), alla successiva fase neolitica, contrassegnata dalla domesticazione di alcune specie animali e vegetali e dal passaggio dalla relazione sillegica (costruita sulla raccolta) a quella epimeletica (fondata sulla cura, che, a sua volta, innesca un legame fondato sull’affetto). L’animale è ovunque in noi, anche quando non lo vediamo. È nelle espressioni culturali, nell’onomastica, nei sogni.
Ma cosa è accaduto, a un certo punto? Marchesini individua nella svolta umanistica del XV secolo il momento di passaggio. È lì che l’uomo ha dichiarato la propria separatezza dal mondo animale, facendo di sé una forma vivente ontologicamente diversa, che si costruisce attraverso la paideia, l’educazione letteraria, filosofica, storica, in netta opposizione alla belluinità dell’animale, dominato dall’istinto e dall’assenza di riflessività. Su questo snodo – di vitale centralità – poggia lo studio della filosofa ambientale inglese Melanie Challenger.

Come afferma in Noi, animali (Sonda, traduzione di Martina Clerici) non solo l’umanesimo occidentale, ma anche il cristianesimo e persino religioni come l’induismo – nelle Upanișad il dio Shiva afferma che “gli esseri umani sono unici nella loro capacità di agire guidati dalla conoscenza” – hanno scavato il solco che ci ha separato dagli altri animali. Abbiamo costruito una scala gerarchica e ci siamo posti al vertice. Gli uomini si sono scissi dagli animali e continuano a far di tutto per dimenticarsi di essere animali, spaventati dall’anarchia e dall’amoralità della natura. La strada che abbiamo percorso insiste sul fatto che rispetto agli animali abbiamo altre qualità, o, detto altrimenti, possediamo un’essenza non biologica. Challenger spiega che si tratta di un inganno (peraltro pur esso naturale).
Quelle che riteniamo facoltà solo umane non sono in effetti tali. Si pensi al linguaggio che condividiamo con gli altri appartenenti al genere homo e, come rivelano studi recentissimi, non è solo peculiare della nostra specie. Ma la chiave di volta è il ruolo della mente. Tutti sembriamo d’accordo sul fatto che “siamo in grado di pensare perché esiste un io che pensa”. E siamo dell’idea che la vera parte umana sia proprio quell’io, ovvero sia “la mente che crea l’uomo”. Gli uomini sono persone, dotate di qualità “che vengono elevate ai vertici dell’esperienza – la ragione, l’intelligenza, la moralità”.
In realtà questo patrimonio di convinzioni, che ha alle spalle millenni, è scientificamente inesatto. Il nostro essere persone, munite di consapevolezza di sé e degli altri, non è una condizione che ci separa dalla natura, ma è quanto la natura ci ha dato per adattarci all’ambiente. È la nostra storia evolutiva che ci ha condotto a pensare di essere sganciati dal substrato animale. Challenger fa notare che le nostre presunte qualità superiori hanno tutte una radice naturale: è la biologia che ci ha fatto cooperativi, sociali, ma anche capaci di mentire e di spersonalizzare l’altro per piegarlo ai nostri scopi, sottovalutando le caratteristiche di chi non fa parte del nostro gruppo e privando gli animali, probabilmente con l’inizio dell’allevamento, di mente, di intelligenza e di moralità.
Ma biologici sono anche i nostri ricordi, le emozioni, le visioni del mondo (il tradizionalismo politico è una risposta alla paura), i legami (soprattutto madre-figlio), la coscienza della morte, il cui terrore sviluppa come strumento di difesa l’idea dell’unicità umana. Ma il paradosso contemporaneo è evidente: nonostante Darwin, facciamo fatica ad accettare la nostra condizione di animali. Non è un caso che nel corso dell’ultimo secolo si sia cercato di arginare il darwinismo per via laica, individuando fasi di rivoluzione culturale nella storia umana, in cui avremmo, improvvisamente, compiuto una tale serie di passi in avanti da perdere le nostre caratteristiche originarie (operazione scorretta, che non tiene conto del fatto che la vita è un processo graduale e metamorfico, senza strappi).
Come ribadisce ancora Marchesini, però, il rifiuto di sentirsi parte della natura, non è a costo zero, ma determina pesanti conseguenze, facendoci dimenticare che siamo noi la causa delle difficoltà in cui si trova il pianeta. Non solo l’estinzione delle specie, ma anche i problemi climatici e la pandemia hanno origine dalla nostra volontà di separatezza. Che, probabilmente, trova una giustificazione contemporanea anche nella logica capitalistica, ovvero nell’idea che la natura sia, come riporta Marchesini citando Jason Moore, “un bene a buon mercato”, a nostra immediata e totale disposizione.
E a questo livello è interessante la lettura di un altro testo da poco giunto in libreria, Amare gli animali (Blackie edizioni, traduzione di Lorenzo Vetta) del giornalista inglese del Financial Times Henry Mance. Nella sua ottica, amare gli animali significa reimparare a convivere con loro – con tutti loro – e non semplicemente possederli per piegarli ai nostri scopi. Convivere vuol dire smettere di mangiare la loro carne (pesci compresi), abbandonare il consumo del loro latte (solo noi umani lo facciamo), rinunciare alla loro pelle, al loro pelo e alle loro piume per vestirci. Per due motivi: mettere la parola fine ad uno sfruttamento brutale (la testimonianza diretta di quanto Mance ha vissuto nei mattatoi non può non colpire, ma anche la condizione delle mucche da latte, costrette ad essere perennemente incinte e separate dai loro vitelli, in gran parte destinati ad essere subito uccisi, non è da meno) e abbattere l’inquinamento ambientale, riducendo la superficie occupata dal bestiame e le emissioni di metano.
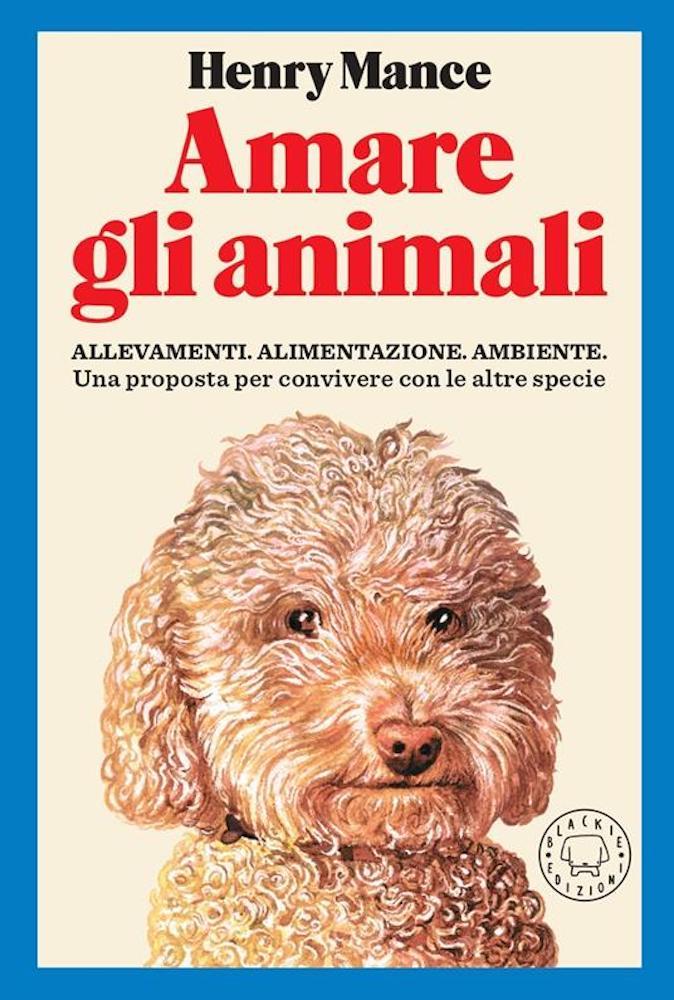
Il presupposto è di natura etica: gli animali sono esseri senzienti, possiedono coscienza e, soprattutto, provano dolore. Ma se solo i mammiferi “sembrano processare il dolore attraverso la neocorteccia, l’area del cervello associata alle emozioni complesse”, è anche vero che gli stessi mammiferi, gli uccelli e i pesci possiedono i nocicettori, “neuroni che segnalano alle creature possibili stimoli dannosi”. Non solo: i pesci e gli umani, sottoposti a stress, producono lo stesso ormone, il cortisolo. Tra i cefalopodi, si pensi ai polpi, che, come ha spiegato Peter Godfrey Smith in Altre menti (Adelphi), amano essere accarezzati dagli uomini, cacciano con straordinaria precisione, sono osservatori curiosissimi, adorano giocare e, certamente, sentono dolore. La sofferenza che arrechiamo agli animali – in modo sistematico da circa un secolo negli allevamenti industriali – non può trovare una giustificazione nella prelibatezza della carne. Per ridare equilibrio agli ecosistemi bisogna ridurre il nostro impatto ambientale, consumare meno, restituire spazio alla natura selvaggia e agli animali non domesticati, capire che il vero segno dell’errore sono gli zoo – ingiustificati e inefficienti da qualsiasi punto di vista li si osservi, nonostante la loro convinzione di rappresentare l’unica strategia per la salvaguardia delle specie a rischio e la pretesa di essere educativi – e non tanto la caccia, che invece “può finanziare la conservazione”, riducendo l’eccessiva presenza di cervi e cinghiali.
In tal senso, i pet – i cani e i gatti – dovrebbero fare da volano all’attenzione verso gli altri animali e non riportarci a una condizione di chiusura nella gabbia della nostra autoreferenzialità (amiamo i cani nella misura in cui ci assomigliano, o assomigliano ai cuccioli umani). È posizione condivisa da Marchesini, secondo il quale l’amore incondizionato per il cane e il gatto – la grande tendenza globale dell’ultimo ventennio – non è altro che una faccia dell’esasperazione antropocentrica. In effetti cosa sono i nostri animali di casa? Non più “alterità”, cioè forme viventi dotate di una loro personalità irriducibile alla nostra, ma “proiezioni” dei nostri desideri, giocattoli, su cui riversare il nostro affetto. Non a caso, la gran parte dell’umanità contemporanea è cresciuta nell’immaginario disneyano, costruito sull’animale antropomorfo che a parte qualche tratto originario è del tutto umano nel linguaggio, nel comportamento, nelle idee, nei vizi. Dappertutto, quindi, ci specchiamo in noi stessi.
La tesi di Mance è che gli animali devono essere messi nelle condizioni di poter continuare ad esistere e per poterlo fare devono stare senza di noi. Il paradosso è quindi che amare gli animali significa lasciarli lontani da noi, restituendo loro almeno il trenta per cento del pianeta. Mance però sa che “non crediamo al cambiamento climatico… non crediamo davvero che gli animali stanno scomparendo e nemmeno che gli ecosistemi stiano collassando”. Se il coronavirus forse ha dato modo di capire quanto in realtà siamo fragili, lo sforzo da compiere è soprattutto a livello mentale, perché “l’estinzione umana non è un concetto così peregrino”.









