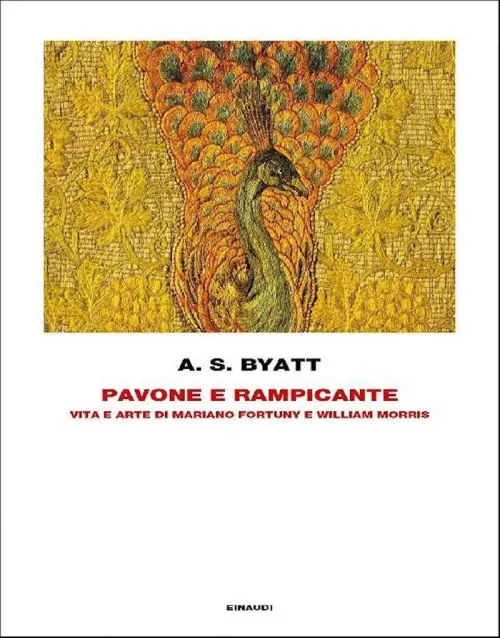Mariano Fortuny e William Morris / Canali veneziani e prati inglesi
Di verde. Il libro inizia parlando di verde. Verde acquamarina dei canali veneziani, verde dorato dei prati e dei boschi inglesi, entrambi soffusi di luce, scintillanti ai bagliori del sole d'aprile sull'acqua immobile e sulle gocce perliformi di rugiada. E poi ancora luce. Luce sulla laguna veneziana. Luce sulle pietre inglesi. Luce soffusa, iridata, impalpabile, che conferisce grazia alle cose, annullandone i contorni ne nega i confini e trasforma i paesaggi in una trama, come se fossero un’immensa tessitura stesa sul mondo.
È con l'evocazione di queste immagini, ricordate ad occhi chiusi, che inizia Pavone e rampicante. Vita e arte di Mariano Fortuny e William Morris, (Einaudi, 2017) lo straordinario libro di Antonia Susan Byatt.
Allo stesso tempo saggio, racconto e libro d'arte – è infatti arricchito da un nutrito corredo iconografico – con rigore scientifico reso piacevole dalla sua scrittura mutevole e immaginifica l'autrice arditamente vi accomuna e poi distingue, analizza sovrapposte e quindi disgiunte la vita e le attitudini creative dei due poliedrici artigiani-artisti che un divario di trentasette anni separa e che la Storia dell'Arte colloca sul crinale di due diverse stagioni: la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Mariano Fortuny, dettaglio di tessuto plissettato, 1910 circa (che sembra alludere al moto ondoso, lento, fitto e serpeggiante delle acque verde-acquamarina della Laguna veneziana). William Morris, tessuto con pavoni e draghi, 1878 (che pare interpretare poeticamente gli intrichi vegetali e il verde dorato della campagna inglese).
Il linguaggio artistico di William Morris (1834-1896), borghese, libertario e socialista, vissuto nell'epoca del secondo vittorianesimo, è intimamente connesso al movimento delle Arts and Crafts, di cui è anche il fondatore. Quello di Mariano Fortuny (1871-1949), invece, aristocratico ed elitario, partecipe del clima della Belle Époque, è improntato all'Art Nouveau, o Liberty, che dir si voglia. Nessuno di apparentemente più distante e dissimile, dunque, sia per estrazione sociale che per ambito culturale. Ma è proprio tra le pieghe di queste differenze che Antonia Susan Byatt individua analogie e punti di contatto mai proposti prima che al lettore appaiono subito evidenti e palesi inducendolo ad accoglierli immediatamente e a condividerli. Tutti e due gli artisti, infatti, sono eredi in nuce, dell’anima del Romanticismo: l’immaginazione, ispiratrice del lavoro di entrambi. Tutti e due, poi, sono uomini di genio che amano la natura, della quale ritraggono con immediatezza la vita animale e vegetale, rese con intrichi lineari e con vivaci cromatismi, di analogo fascino se pure con tratti e tecniche differenti.
Tutti e due, inoltre, sono artigiani ed inventori ed entrambi si circondano degli oggetti da loro stessi ideati, in cui sperimentano forme nuove e moderne desunte sì da quelle del passato, sebbene da due epoche storico-artistiche differenti: dal medioevo nordico Morris; dal mondo ellenico antico e dall'arte veneziana Fortuny. Tutti e due sono affascinati dalle saghe e dai miti: Morris dalle saghe islandesi, Fortuny dai miti greci. Tutti e due amano i colori naturali e sperimentano tinture con pigmenti di loro creazione, Morris nella tintoria di Merton Abbey, fatta costruire dagli Ugonotti sullo scorcio del Settecento; Fortuny in quella appositamente progettata per lui da Barry Dixon alla Giudecca. Se Morris, infine, è stato uno dei più grandi scrittori inglesi del suo tempo, Fortuny è stato celebrato nei romanzi di grandi letterati a lui contemporanei, quali Gabriele d’Annunzio e Marcel Proust.

Da sinistra: William Morris; Jane Burden; Henriette Negrin; Mariano Fortuny y Madrazo.
Antonia Susan Byatt conduce il lettore per mano nelle case abitate dai due artisti, teatri della loro vita privata e professionale: l’austera Red House ed il severo Kelmscott Manor di Morris; il raffinatissimo Palazzo veneziano Pesaro degli Orfei di Fortuny. Con una prosa asciutta, a volte brutale, enfatizzata dalle immagini caricaturali che la corredano, gli narra dell'infelice matrimonio di Morris con Jane Burden, la musa dei Preraffaelliti, amante del pittore Dante Gabriel Rossetti e dello stoicismo con cui Morris ne sopporta la liaison. Con una scrittura fattasi opportunamente passionale e raffinata gli racconta invece dell’amore che per tutta la vita ha legato Fortuny alla moglie Henriette Negrin, coautrice, tra l’altro, dei meravigliosi tessuti che lo hanno reso famoso e apprezzato dal jet-set internazionale e dalle dive del tempo.

In alto: alcune vedute della Red House. In basso: William Morris, La belle Iseult, 1858, Londra, Tate Gallery; alcuni esempi di disegni di William Morris per tessuti e carta da parati, dominati dal colore e dal linearismo a motivi naturalistici.
E allora tutti gli artigiani erano artisti
Progettata da William Morris nel 1859 insieme all'amico architetto e collega di studio Philip Webb (1831 – 1915), la Red House è stata annoverata da Nikolaus Pevsner nel suo “I Pionieri del Movimento Moderno” (1936) tra gli edifici che rappresentano i prodromi dell'architettura moderna. Manifesto delle Arts and Crafts è completamente realizzata in mattoni rossi, dal cui colore prende il nome, senza che alcun intonaco la ricopra. Inoltre è stata pensata per interagire con l’ambiente naturale in cui è immersa, il paesaggio del Kent, perciò ha tante finestre di diversa forma e dimensione. Sebbene tragga ispirazione dai modelli dell'architettura medievale, soprattutto dal gotico, a cui tanto Morris ha inneggiato, ha tratti di sorprendente modernità nella pianta libera (con grande anticipo su quella che verrà inclusa tra i 5 punti dell'architettura moderna da Le Corbusier nel 1925). Un altro dei motivi che ascrivono questa architettura tra le precorritrici del Movimento Moderno è l’essenzialità quasi minimalista delle sue forme. Il medesimo concetto di stanza vi è addirittura messo in discussione nel concentrarsi negli angoli degli spazi funzionali.
William Morris, assertore del socialismo utopico di ispirazione ruskiniana, nonché fautore di un ritorno all’artigianato, sosteneva che per far fronte all’alienazione prodotta dal lavoro in fabbrica e al degrado paesaggistico causato dal proliferare delle industrie sul territorio, fosse opportuno dar vita ad una società in cui arte e vita si unissero indissolubilmente, dove cioè la necessità morale e l'edonismo, il bene e il bello, si fondessero in un unicum capace di recare all’uomo la felicità.
“Qualunque cosa fatta dalle mani dell’uomo ha una forma, che sarà bella o brutta: bella se è in armonia con la natura e l’asseconda; brutta se è in conflitto con la natura e l’avversa; indifferente non può essere mai”. (The Lesser Arts, lezione sulle arti decorative tenuta da Morris il 21 Gennaio 1882 a Birmingham al Birmingham & Midlands Institute)
Egli riteneva inoltre che fosse necessario reagire alla bruttezza dilagante degli oggetti prodotti industrialmente educando il pubblico alla bellezza insita nei manufatti artigianali del passato, soprattutto se legati al territorio in cui erano stati creati.
“C’è stato un tempo in cui il mistero e il miracolo della produzione manuale erano riconosciuti in tutto il mondo, il tempo in cui l’immaginazione e la fantasia si mescolavano a tutte le cose create dall’uomo, e allora tutti gli artigiani erano artisti …” (ibidem)
È poi la “forza creatrice del colore” a presiedere alla realizzazione dei suoi arazzi, delle sue carte da parati, dei suoi tessuti e vetrate e stampe. Così scrive:
“Per un grande pittore assorto nella meditazione sulla potenza della sua arte, il colore è una forza creatrice. Egli sa quanto il colore agisca la materia, quanto sia, in realtà, una vera e propria attività della materia; sa che il colore vive di un continuo scambio fra materia e luce. Così, a causa della fatalità dei sogni elementari, il pittore rinnova le grandi fantasie cosmiche in cui l'uomo è associato agli elementi, fuoco, acqua, aria e alla materialità delle sostanze terrestri.” (William Morris, News from Nowhere and Other Writings)
Sebbene la sua opera pittorica si limiti all'esecuzione di un solo quadro, La belle Iseult (Queen Guenevere), per il quale aveva posato come modella la sua bellissima moglie Jane Burden, la sua produzione di motivi floreali e animali, tutti di grande bellezza, è assai copiosa. Parrebbe che Morris, in assoluta controtendenza con il trionfo dell'immagine femminile nella pittura dei Preraffaelliti (in particolare di quella della sua Jane nella pittura di Rossetti), abbia voluto contrapporvi la rinuncia totale alla rappresentazione della figura umana. Chissà? Forse proprio per non acuire, nel riprodurla, il dolore che il tradimento della moglie gli causava, trovando invece nel linearismo zoomorfo e fitomorfo, ma soprattutto nell’esplosione cromatica delle sue creazioni, la forza per lenirlo e rattenerlo.

In alto: Palazzo Pesaro degli Orfei ora Fortuny; Era di Samo, 570 a.C, Parigi Louvre che indossa il chitone e l’himation entrambi i capi sono stati reinterpretati da Fortuny nelle sue creazioni; Mariano Fortuny, abito Delphos; lady Conde Nast indossa un abito Delphos, 1907; Isadora Duncan indossa un abito Delphos, 1910, ph. di Mariano Fortuny. In basso a sinistra: tessuti di mariano Fortuny; a destra: altre due versioni dell’abito Delphos, la prima con himation in broccato veneziano reinventato da Fortuny.
Di roseo rapito a una luna nascente
La lunga e felice love story di Mariano Fortuny con Henriette Negrin si scrive invece a Venezia, nello storico palazzo Pesaro degli Orfei (leggi qui il bell'articolo di Anna Toscano sui differenti suoni che vi hanno riecheggiano nel tempo). Costruito verso la fine del Quattrocento in campo San Beneto per la ricchissima famiglia patrizia dei Pesaro (immortalata da Tiziano nell’omonima Pala) è stato da questa abitato fino a quando non lo ha lasciato, per trasferirsi, verso la seconda metà del XVIII secolo, nella nuova, magniloquente, residenza di Ca’ Pesaro, progettata da Baldassare Longhena e oggi sede della Galleria d'Arte Moderna e del Museo d'Arte Orientale. In seguito, l'avito Palazzo Pesaro acquisirà anche il nome di ‘degli Orfei’ per aver ospitato la Filarmonica degli Orfei. Sarà all'età di ventotto anni che il giovane rampollo del nobile casato dei Fortuny y Madrazo, di origine catalana, che già abitava da tempo a Venezia con la madre, in palazzo Martinengo, vi traslocherà con Henriette, trasformandolo ben presto in un atelier di pittura, di fotografia, di scenografia, di moda e di design, frequentato dalla più raffinata clientela internazionale del suo tempo. Da Eleonora Duse a Peggy Guggenheim, da Isadora Duncan a Sarah Bernhardt, da Ruth St. Denis a Martha Graham, alle nostre Emma e Irma Grammatica e perfino alla “divina marchesa” Luisa Casati (musa di grandi artisti del calibro di Boldini, Marinetti, Balla, Man Ray, Alberto Martini e ispiratrice di D’Annunzio), tutte facevano a gara per indossare una creazione di Mariano Fortuny.
Tra i tanti capolavori che il nostro progetta e mette in produzione in quel palazzo, che diverrà ben presto noto come “Palazzo Fortuny”, il più famoso è Delphos (1907-1930), un abito che ha travalicato i confini del tempo: proveniente dal lontano passato della Grecia ionica, si è infatti eternato nel futuro. Si tratta di un abito in satin di seta ispirato ai chitoni delle korai greche (si veda quello indossato dall'Era di Samo, 570 a.C., Museo del Louvre, Parigi). Caratterizzato da una fitta plissettatura (eseguita con una macchina da lui inventata e brevettata nel 1909) su una base rettangolare era poi chiuso per il lato lungo da una sequenza di perline in pasta di vetro di Murano, in modo da formare una foggia cilindrica che si modellava naturalmente sul corpo di chi lo indossava. Privo di cuciture, ne aveva solo a coulisse lungo gli orli e nello scollo, veniva confezionato avvolto come una matassa di lana, riposto in una piccola scatola. Sottili cordoni di seta, ornati sempre da perline in pasta vitrea, consentivano poi di allungare o di accorciare a piacere le maniche. I meravigliosi tessuti con cui era realizzato venivano tinti con pigmenti naturali, minerali o vegetali, dai colori brillanti, indaco, verde smeraldo, rosso cocciniglia, arancio, rosa antico, avorio, viola, dalle sfumature cangianti, mutevoli alla luce, ottenuti con un procedimento rimasto segreto.
Si racconta che alla morte di Mariano, Henriette abbia buttato via le polverine di colore gettandole nel canale della Giudecca affinché nessuno se ne appropriasse.
La prima creazione di Fortuny nel campo della moda fu la sciarpa Knossos (1907), una sciarpa molto lunga che, sebbene nata come costume di scena per il teatro, divenne ben presto un must conteso da tutte le signore eleganti. A fornirgli l’idea ispiratrice era stato il rinvenimento di un brandello di tessuto durante gli scavi di Cnosso condotti sir Arthur Evans (che 1905 definì ‘minoica’ la civiltà cretese) e da lui descritti nel suo libro: The Prehistoric Tombs of Knossos, da Fortuny letto e riletto.
Ecco cosa scrive in alcune sue note:
“Nel 1907 alcuni frammenti di tessuto stampato rinvenuti in Grecia mi incoraggiarono a condurre delle ricerche sui procedimenti di stampa del passato, dopo di che mia moglie ed io avviammo un laboratorio a Palazzo Pesaro Orfei per mettere in pratica i metodi che avevamo scoperto.”
La sciarpa era dipinta con motivi cicladici di fiori e di alghe, desunti dalla lettura di un altro testo, quello del medico-archeologo Angelo Mosso, intitolato “Escursioni nel Mediterraneo e gli scavi a Creta”, di cui possedeva una copia che consultava di frequente. Così scrive in proposito:
“Le scoperte fatte da Angelo Mosso su Creta furono di grande incentivo a tentare alcune prove. E il primo saggio fu una sciarpa lunga, che chiamai appunto Knossos dai motivi di fiori e di alghe che corrono intorno agli antichissimi vasi ritrovati nell’isola di Candia.”
Mariano scattò moltissime foto di Henriette con indosso la sciarpa Knossos drappeggiata attorno al suo corpo in varie fogge. In un angolo vi si può distinguere il marchio di fabbrica dell’azienda che i due coniugi avevano aperto a Palazzo Fortuny, costituito da un tondo al cui interno è raffigurato un labirinto contornato dalle scritte: Fortuny Knossos.

Alcuni dei loghi di Fortuny, a destra il marchio della sciarpa Knossos.
Persino Gabriele D’Annunzio menziona la sciarpa Knossos nel romanzo Forse che si forse che no. La fa indossare al personaggio di Isabella Inghirami, nel paragrafo in cui questa ha un convegno galante con il protagonista del libro, Paolo Tarsis, di cui è innamorata:
“Ella era avvolta in una di quelle lunghissime sciarpe di garza orientale che il tintore alchimista Mariano Fortuny immerge nelle conce misteriose dei suoi vagelli rimosse col pilo di legno ora da un silfo ora da uno gnomo e le ritrae tinte di strani sogni e poi vi stampa su co’ suoi mille bussetti nuove generazioni di astri, di piante, di animali. Certo alla sciarpa di Isabella Inghirami egli aveva dato l’impiumo con un po’ di roseo rapito dal suo silfo a una luna nascente.”
Un altro merito di Fortuny come stilista di moda è stato quello di aver saputo ricreare i lucenti broccati in velluto di seta per cui Venezia era divenuta famosa nei secoli, ampiamente riprodotti nella pittura dai suoi artisti, da Paolo Veneziano (1300-1365) a Vittore Carpaccio (1455 ca-1526), da Paolo Veronese (1528-1588) fino a Vittorio Zecchin (1878-1947), passando attraverso il cromatismo di Giorgione, di Tiziano e del Tintoretto.
Di questi broccati narra anche Marcel Proust, nel secondo volume della Recherche:
“… dicono che un artista di Venezia, Fortuny, abbia ritrovato il segreto della loro fabbricazione e che, fra qualche anno, le dame potranno passeggiare, e soprattutto stare a casa loro, in broccati splendidi come quelli che Venezia ornava, per le sue patrizie, con i disegni dell’oriente”.
E ancora, nel quinto volume, lo scrittore francese ci racconta di un mantello di Fortuny indossato da Albertine:
““Posso venire così, se non scendiamo dall'auto". Esitò un secondo fra due mantelli di Fortuny per nascondere la vestaglia, come due amici diversi da condurre con sé, ne prese uno azzurro cupo, bellissimo, infilò una spilla in un cappellino. In un minuto fu pronta, prima ancora ch'io avessi preso il mio soprabito, e andammo a Versailles.”
Fortuny è l'unico artista contemporaneo a Proust ad essere da lui citato nella Recherche con il suo vero nome e non con uno pseudonimo. Ha inoltre il privilegio di esservi menzionato per ben tre volte, in quello che lo stesso Proust ha definito leitmotiv Fortuny. In uno dei brani, egli si sofferma sull’unicità delle creazioni del maestro veneziano che, lungi dall'essere seriali, posseggono, pur nella ripetitività del modello, delle peculiarità, magari insite in un dettaglio, che le rende uniche e individuali, al punto che meriterebbero un nome proprio, così come avviene per le opere degli artisti:
“Tra tutte le vesti o vestaglie della signora di Guermantes, quelle che mi sembravano più rispondenti a un'intenzione determinata, e dotate di uno speciale significato, erano quelle fatte da Fortuny su antichi disegni veneziani. È forse il loro carattere storico, o piuttosto il fatto che ciascuna è unica, a dar loro un carattere così singolare che l'atteggiamento della donna che le indossa, mentre ci aspetta o parla con noi, acquista un'importanza straordinaria, come se quel vestito rappresentasse il frutto d'una lunga deliberazione e se quella conversazione si distaccasse dalla vita ordinaria come una scena di romanzo.(...) Nulla di vago può restare nella descrizione del romanziere, giacché quel vestito esiste realmente, e i suoi menomi disegni sono altrettanto naturalmente precisi di quelli di un'opera d'arte. Prima di indossarne uno, la donna ha dovuto scegliere tra due vestiti, tutt'altro che simili, ciascuno dei quali è anzi profondamente individuale e potrebbe portare un nome."

Mata Hari con una sciarpa Knossos; Lillian Diana Gish con un abito Delphos, 1920; Miss Muriel Gore ritratta da Sir Oswald Hornby Joseph Birley con indosso un abito Delphos e una sciarpa Knossos, 1919.
Ad occhi chiusi
Dopo aver osservato a lungo le trame e i colori dei tessuti e delle carte da parati di Morris e quelle delle stoffe delle vesti di Fortuny, socchiudendo gli occhi, Antonia Susan Byatt scrive di avere come l’impressione di vederle confondersi. In un’esperienza visiva involontaria esse le sembrano sovrapporsi le une alle altre, come le era accaduto anche quando, trovandosi a Kelmoscott, semplicemente chiudendo gli occhi, vedeva le immagini appena guardate circonfondersi della luce acquatica dei canali veneziani; oppure quando, invece, pur essendo a Palazzo Fortuny, se chiudeva gli occhi, le pareva di trovarsi immersa nella luminosità vegetale della campagna inglese.
È così che si conclude il suo libro, ad occhi chiusi, com’era iniziato.
Antonia Susan Byatt, Pavone e rampicante. Vita e arte di Mariano Fortuny e William Morris, Einaudi 2017, tradotto da Anna Nadotti e Fausto Galuzzi.