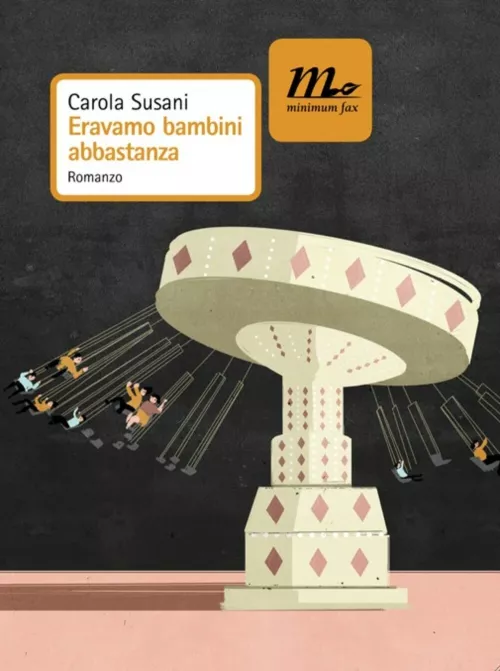Carola Susani. Eravamo bambini abbastanza
Ci sono immagini che retroagiscono sulla nostra conoscenza delle cose, dei libri, delle persone. Appena sento il nome di Carola le immagini che si formano immediatamente nella mia testa sono due. Una è lei circondata dalle sue bambine; sono sedute per terra, in una galleria d’arte, in una giornata primaverile a Roma e giocano, incuranti della gente attorno. Sono facili, sciolte, contente; potrebbe esserci chiunque attorno, loro sono chiuse nel loro cerchio magico e se ne fregano. L’altra è Carola da piccola in mezzo alle rovine del Belìce: i suoi genitori sono architetti veneti e nel ‘68 l’hanno portata lì perché volevano collaborare alla ricostruzione. Trascorsero in baracca diversi anni: anni di lotta politica, ma anche di leggerezza e di gioco in mezzo all’immenso parco giochi delle rovine (chissà perché bambini e rovine vanno così bene insieme, forse perché in mezzo alle rovine ci puoi trovare qualsiasi cosa: è spazio per l’immaginazione).
Il disastro, dice Blanchot, si prende cura di tutto, e forse non è un caso che Manuel, il bambino protagonista dell’ultimo libro di Carola Susani, Eravamo bambini abbastanza (Minimum fax, 211 pp., 13,50 €) abbia tra i suoi averi più cari proprio un libro illustrato sui disastri naturali che si intitola Il libro delle fini e degli inizi. Manuel è stato rapito da un personaggio misterioso chiamato Raptor, come una specie di animale preistorico dai movimenti e dagli spostamenti imprevedibili, a volte minacciosi e sgradevoli, altre invece carezzevoli, calorosi. Il Raptor è un rapitore di bambini, perlopiù dell’Europa dell’Est, che in genere forma una piccola banda che vaga per fabbriche e case abbandonate, periferie degradate, ferrovie, strade ai margini delle città, vive di espedienti e piccoli furti, ma in definitiva non è troppo infelice, anzi. Manuel, un bambino borghese che immaginiamo compito ed educato, catapultato da un giorno all’altro dalla sua normalità pulita a una quotidianità sporca e affamata in cui i suoi compagni di viaggio parlano una lingua che non capisce, non è affatto scontento, cede volentieri il suo Game Boy, guarda le foto di sé scomparso come se si trattasse di un altro bambino e cammina senza troppo strepitare. Nelle lunghe notti che i bambini passano in questi luoghi abbandonati, uno di loro, Alex, narratore nella narrazione, racconta le storie di ognuno di loro, inventa le infanzie, esagera, crea dal nulla episodi e personaggi; e il bambino di cui si narra questa infanzia favolosa, non importa che Alex racconti come sia nascere a Chernobyl ovvero in un villaggio della Polonia in cui si desidera solo andare a Sud, sempre annuisce contento, accettando le divagazioni e le iperboli come parte del gioco.
Ritorna, come nell’incunabolo di questo romanzo, L’infanzia è un terremoto, che ricostruiva l’infanzia di Carola in mezzo alle rovine del Belìce (le rovine della nostra storia, della nostra modernità), il tema della comunità che si fa forte di una solidarietà lacera e affranta per superare il disastro: solo che qui c’è un ulteriore passo avanti, perché questo mondo è fatto solo di bambini. Bambini che vengono quasi tutti da situazioni di miseria e privazione, ma sono anche forti e coraggiosi. Il Raptor li ha scelti con attenzione, perché ha visto in ognuno di loro un’oltranza capace di resistere alle difficoltà, di non lagnarsi, di trovare sempre nuovi modi di sopravvivere alla fame, al freddo e alla tristezza. C’è di più: a guardare il disastro da vicino, come fa il bambino protagonista, si scopre che in esso c’è un valore aggiunto di realtà, un’intensificazione dell’esperienza tutto sommato non reversibile, come un viaggio da cui non si torna uguali:
“Sono passati pochi anni dalla fine di tutto, sembra un millennio. Questa storia, quello che abbiamo passato con il Raptor, è lontanissima, come se non ci fosse mai stata, come se fosse capitata a un altro oppure in un’altra dimensione. Durante il giorno me ne ricordo come un sogno. E sto tranquillo: ho dodici anni, una famiglia che ci tiene, vado bene a scuola, tutti mi guardano come uno che si è salvato per miracolo, uno che è tornato da un posto peggiore della morte. Ma certe volte mi sveglio di notte e non riconosco la stanza, corro spaventato nella camera dei miei genitori, li guardo mentre dormono e non capisco che ci faccio qui. In quelle notti per un momento mi viene in mente che la vita vera era quella, la nostra con il Raptor, e che questa – la scuola, i genitori, i regali di compleanno, la piscina – è come un giro in giostra, un esercizio finto che non allena a niente”.