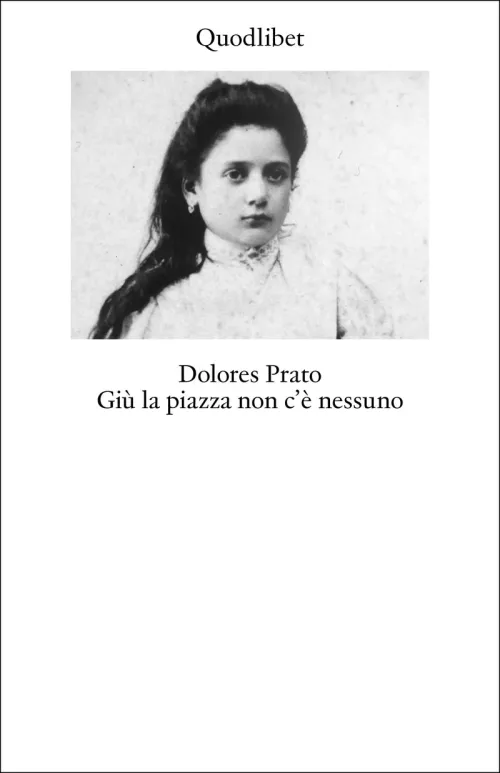Dolores Prato. Un cassetto pieno di pagine
“Sarò regina! Certo è possibile, benché difficile. Che c’è più alto della regina? La Madonna. Ma la Madonna era un pasticcio: vergine e madre. La verginità il punto più alto di ogni altezza. Erano vergini quelle che non avevano figli, ma io non potevo rinunciare ad avere figli; perciò come la Madonna: vergine-madre. Ero lontanissima dal supporre che cosa volessero dire le due parole, sapevo solo che c’era di mezzo un miracolo. Per me si sarebbe compiuto; s’era compiuto per la Madonna? Dunque era possibile. E se invece fossi diventata scrittrice? I miei compiti la maestra li leggeva forte in classe…”.
Come sempre nella sua opera, Dolores Prato non rifugge mai il confronto con l’umanità del divino – anzi, del sacro tout court – né tantomeno l’esposizione dei fatti della propria infanzia. E proprio con Giù la piazza non c’è nessuno, riproposto da Quodlibet in una nuova edizione ampliata a cura di Elena Frontaloni, Prato raggiunge il gradino più alto del suo percorso di auto-narrazione. Il racconto della sua infanzia di figlia illegittima, respinta e sola, vissuta sullo scorcio fra XIX e XX secolo in una minuscola cittadina delle Marche che nel ricordo diventa grande quanto il mondo intero, colorandosi di sfumature fantastiche e magiche: Treja. Un racconto così lontano dalle consuetudini stilistiche (a lei, a noi) contemporanee e così vicino a un grado assoluto di sublimazione dell’intimità, da aver trasformato l’anomala e irriducibile Prato (“la più grande narratrice italiana del Novecento” secondo Andrea Cortellessa) in un’autrice sempre più apprezzata in Italia e tradotta all’estero: dopo la versione francese di Jean-Paul Manganaro e Laurent Lombard (Bas la place y’a personne), apparsa nel 2018, nel 2024 Giù la piazza non c’è nessuno è stato tradotto in tedesco da Anna Leube (Unten auf der Piazza ist Niemand).
Tuttavia, la questione pratiana è soprattutto, più ancora che una questione di contenuti, una questione di metodo e di vastità dei materiali: tra copie personali, copie accettate dall’editore (Einaudi), pagine rifiutate e pagine rassettate, la letteratura di Prato è un cassetto ricolmo di pagine vergate a mano e dattiloscritte, reimpaginazioni, collage di frasi e di significati che hanno messo a dura prova autrice, collaboratrici e – in un secondo momento – curatrici.
Elena Frontaloni riesce a recuperare un profilo inedito di Prato a partire da quella “copia personale” tanto cara alla sua artefice: una “creatura viva”, scrive Frontaloni, “manifestazione vibrante dell’estro inconcluso dell’autrice, fonte inquieta di tutti gli altri testimoni rintracciati”. Una copia che permette di identificare con precisione maggiore che in passato i caratteri fondamentali della pagina pratiana, prontamente elencati dalla curatrice: “costruzione per luoghi e oggetti che mette in secondo piano ma non oblitera una progressione di tempo e di trama; ripetizione variata e cangiante di scene e motivi; cursus e ritmo debitori tanto dell’oralità quanto di un solido labor limae; inimicizia per il formato libro in ragione del godimento dell’attimo della scrittura e della narrazione, nel suo srotolarsi potenzialmente infinito; libera messa in crisi e in parodia delle strutture retoriche della patria lingua e delle patrie lettere, con procedimenti di arte allusiva crudamente emancipati da basse furbizie citazionistiche”.
A proposito di furbizie, è inevitabile chiedersi, anche alla luce della riscoperta e del meritato successo dopo decenni di sostanziale oblio, quali rapporti l’autonarrazione biografica di Prato intrattenga con il gusto tutto contemporaneo per il memoir e l’autofinzione. Domanda senz’altro troppo vasta, per la quale bisognerebbe scomodare pagine e pagine di letteratura critica. E tuttavia una risposta può essere trovata, scavando e “respirando” le parole che Prato ritaglia con tanto amore e straordinaria consapevolezza. Di certo l'autrice, sotto una spessa scorza di inesplicabilità, si sofferma su un periodo di tempo particolare della propria vita, quell’infanzia che “è la sola età in cui l’inconscio affiora senza ostacoli. L’inconscio che sa quel che noi non sapremo mai, l’inconscio che se a lui ci abbandoniamo ci fa divinatori, mi parlava, ma io non lo capivo”.
Non capire e specialmente non capirsi, farsi spettatori delle proprie emozioni e dei propri accadimenti, mostrarsi come giudici colpevoli delle proprie azioni, condividendo così un senso di indeterminatezza che non ambisce minimamente a farsi “caso esemplare”, sono tra le peculiarità di una ricerca che non esita a gettarsi nella dimensione dell’infinitamente piccolo. Come accade nel riportare un episodio che vede protagonista il leggendario zio prete, Domenico Ciaramponi detto Zizì, nell’atto di celebrare un matrimonio: “Un’ostia consacrata e successivamente imbrattata il sacerdote doveva deglutirla lo stesso. […] Lo zio ingoiava qualche repugnante sozzura, o il demonio s’era introdotto nella cerimonia? Non ci fu alcun moto di meraviglia nella gente, o io, annegata da quel che vedevo, non me ne accorsi. Certo che da nessuno ne sentii parlare. Allora ero quella che niente domandava. Adesso vorrei chiedere: ‘Che fu quel che vidi? Ci fu quel che vidi?’, ma non c’è più nessuno che possa rispondermi”.

Non, nessuno, niente: un climax di negazioni in un passaggio così breve rivela l’assiduità di Prato verso il dubbio, la messa in gioco, la presa di coscienza che passa tra l’infanzia di chi ha vissuto (e che quindi “vede, esperisce e non si interroga”), e l’età adulta di chi narra quando ormai è troppo tardi, e non può avere altro interlocutore che se stesso. Nella sua solida insicurezza, Prato è in grado di straniare episodi dal potenziale pruriginoso, come la scoperta infantile dell’eros per tramite dell’amica Carmela: “Carmela fu l’unica ragazza a entrare un giorno in casa degli zii per giocare con me. E giocò. Ma che gioco strano! Lei sola giocava. Nella camera dei bauli, stesa su un mucchio di biancheria sporca preparata per la lavandaia, senza mutandine, a gambe larghe, giocò con se stessa. […] Non mi piaceva quel gioco mai visto di cui ignoravo persino il nome. E poi non c’era niente di bello. Avevo solo intravisto qualcosa di brutto. Chiarissimo poi che per giocare non era bello stendersi su un mucchio di biancheria sporca”.
Invece di battere su tasti altrove consueti – la vergogna, l’imbarazzo, il senso di inadeguatezza della voce narrante – Prato da un lato spiazza il lettore con il commento, inatteso ma tutto sommato non peregrino, sull’effettiva salubrità di un giaciglio di panni sporchi; dall’altro gioca ancora una volta sul registro prediletto della negazione: il gioco non si conosce e non piace, le lasse della scrittura pratiana possono scorrere altrove, in una concatenazione di eventi che potranno anche durare quanto un battito di ciglia, ma che sulla pagina appaiono caricati di una gravità retrospettiva.
In questa stessa direzione si muove l’inedito finale della nuova edizione di Giù la piazza: un fermento, per certi versi inaspettato, di parole crude e taglienti, che la dice lunga della consapevolezza con cui Prato, giunta ormai al termine della vita, guarda alla propria giovinezza. “Per come essere fatti, lo siamo tutti ugualmente: un pudding di elementi ereditari ed occasionali messi a lievitare nella piccola madia della madre dove avviene l’involontaria confezione. […] Impastati per il tempo della gestazione, si sfornano poi i pudding. Apparentemente sono tutti uguali, bastardi e non. […] Ma il bastardo ha sempre qualcosa di più e di meglio del legittimo. Basta guardare i cani: i bastardi sono più festosi più simpatici più intelligenti dei cani di razza. Esclusi naturalmente quelli di chi legge”.
Impossibile non prendere in considerazione un passaggio come questo, anche alla luce di due fra i tòpoi più frequenti e significativi dell’opera di Prato, ovvero la maternità e l’esclusione. La madre, grande assente nella vita quotidiana e ingombrante presenza nell’agitazione dei pensieri, negli scritti di Prato è spesso accostata alla figura della Madonna (il “pasticcio” dell’essere vergine e madre in Giù la piazza, ricordato all’inizio, ma anche l’essere “vergini o vedove” come condizione obbligata per la santità in Educandato), nonché, di riflesso, al grande mistero femminile della creazione della vita. “È la madre che, respingendoci, dal suo corpo ci dette la vita”, scrive Prato; e ancora: “A me non era importato niente della mamma”.
Una maternità, dunque, che mai può essere disgiunta dall’esclusione: la mamma/totem di Prato è un demiurgo che dona la vita per poi dimenticarsene, abbandonando la figlia alle tempeste del mondo. Prato non possiede, non condivide, non parla di “mamma” con le proprie coetanee, non capisce, non domanda, non prende parte ai giochi: Dolores Prato nega. “Tutto ciò che ha un’origine merita d’aver fine”, salmodiava il Mefistofele di Goethe. Allo stesso modo, Prato si muove nello scorrere lento del fiume dell’esistenza (Fiume disperso era il titolo proposto dall’editor Natalia Ginzburg per l’edizione einaudiana di Giù la piazza, prontamente respinto al mittente dall’autrice: “Niente fiume svenevole, voglio la mia Piazza sgrammaticata”), senza sottrarsi però al guizzo della battuta. Gli “esclusi”, stavolta, sono proprio i lettori: come se, all’improvviso e per un momento, il dolore condiviso lungo tutte quelle 838 pagine non pesasse più di una piuma.
Leggi anche:
Nel deserto di Dolores Prato. Intervista a Jean-Paul Manganaro | Elena Frontaloni
La Roma di Dolores Prato | Andrea Pomella
Nella fucina di Dolores Prato | Carlotta Guido