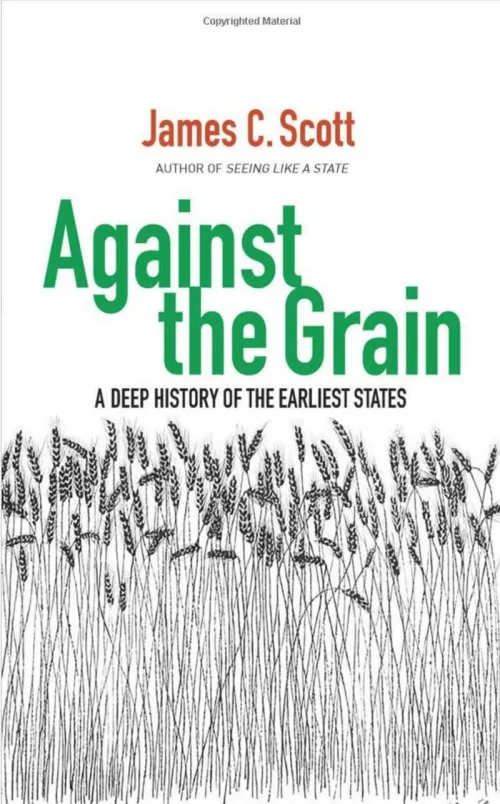E anche contro una certa idea di civiltà / James C. Scott: Contro il grano
All’inizio degli anni ’70, Pierre Clastres scriveva nel suo libro più noto – La società contro lo Stato – che “la storia dei popoli che hanno una storia è, si dice, la storia della lotta di classe. La storia dei popoli senza storia è, potremmo dire con almeno altrettanta verità, la storia della loro lotta contro lo Stato”. L’opera di James C. Scott, in parte scienziato politico in parte antropologo e ambientalista “a titolo amichevole”, e a lungo docente all’università di Yale, si iscrive nella traccia aperta dall’antropologo francese e dai suoi studi sugli indiani Aché (o Guayaki) dell’est del Paraguay.
Il terreno prediletto da Scott è da oltre quarant’anni quello delle società agrarie marginali e senza stato del sud-est asiatico, in particolare Birmania e Malesia, delle quali ha studiato i modelli politici di auto-organizzazione. La sua insistenza nel cercare di comprendere la logica del potere dello stato moderno – per esempio ne Lo sguardo dello stato (in uscita da elèuthera, a cui va il merito di aver riproposto il suo lavoro, dopo la lontana pubblicazione da Liguori del suo I contadini tra sopravvivenza e rivolta (1981) – va infatti di pari passo con la sua volontà di delineare una storia delle pratiche di resistenza e di insubordinazione – le forme di “infra-politica dei senza potere” al centro de Il dominio e l’arte della resistenza (elèuthera, 2006) - che queste società relativamente egalitarie, e spesso dimenticate, hanno elaborato fino a poco tempo fa nel tentativo di sottrarsi al controllo dello stato o, quanto meno, di tenerlo a debita distanza (The Art of Not Being Governed, non tradotto). C’è vita fuori dello stato, ci dice Scott, e in fondo c’è sempre stata – forse perché spesso, fuori, si stava meglio? Si può facilmente riconoscere in questo approccio un dialogo con la tradizione anarchica, anche se per lui il punto non è tanto quello dell’abolizione dello stato – a cui riconosce, “in certe circostanze”, un ruolo emancipatore – quanto, piuttosto, quello di provare a limitarne e contrastarne il potere di assoggettamento (Elogio dell’anarchismo, elèuthera, 2014).
Nel suo saggio più recente, intitolato Against the Grain. A Deep History of the Earliest States – titolo “normalizzato” da Einaudi in Le origini della civiltà. Una controstoria – Scott ritorna su questi temi, questa volta interrogando la genealogia dei rapporti che esistono tra domesticazione, sedentarizzazione e l’emergenza dello stato nella regione mesopotamica del basso corso del Tigri e dell’Eufrate, nel periodo compreso tra il VII-II millennio a.C.. Per farlo Scott assume, divertito, la postura e la libertà, dell’“ingenuo intruso” che rilegge questi rapporti a partire da quanto “già esiste” e da un punto di vista che situa “ai confini tra preistoria, archeologia, storia antica e antropologia”, con il duplice obiettivo di sintetizzare le conoscenze oggi disponibili su questi aspetti, e di interpretarle per formulare una serie di ipotesi, più o meno provocatorie.
Il punto è: come siamo arrivati ad essere dei coltivatori e degli allevatori stanziali governati da quell’istituzione che ora chiamiamo stato? Cosa possiamo scoprire sulle sue “origini, struttura e conseguenze”, se la consideriamo come un “complesso ecologico” essenzialmente agricolo? Ritorniamo al titolo originale. Porsi “contro il grano” significa per Scott reinterrogare alla radice la teoria classica (la dottrina?) che vede nella domesticazione dei cereali, e nella mitologia incentrata sulla presunta superiorità dell’agricoltura rispetto alla raccolta e alla caccia, una precondizione fondamentale della nascita della civiltà: quella sedentaria che si concretizza nella forma stato, e nella particolare “concentrazione di piante, animali domestici e persone” che la caratterizza. Per poterlo fare bisogna però ridimensionare il potenziale “ipnotico” che un certo tipo di tracce (in senso archeologico) ha avuto, e in generale ancora ha, nell’orientare e dare sostanza al modo di costruire un racconto della storia umana.

Opera di Vincent Van Gogh.
Un problema di percezione connesso al disequilibrio generato dal peso che hanno i reperti più resistenti, più “monumentali”, tipici delle fasi di fondazione, rispetto a quelli più deperibili e difficilmente, o per o nulla, documentabili perché relativi a materiali e/o supporti deperibili, oppure riconducibile a processi lenti, insidiosi, temporanei, simbolicamente minacciosi, etc. In questo senso, quindi: se è possibile accumulare scorte e vivere in una società stratificata – schiavi compresi – pur essendo dei cacciatori-raccoglitori (che non smettono di esserlo anche se ogni tanto coltivano qualcosa); se si può essere sedentari – per l’abbondanza di risorse della regione – senza per questo dedicarsi all’agricoltura (che per un lungo periodo non appare come una “prima scelta”); se dei centri agrari possono sorgere e esistere su base volontaria, in assenza di un potere centralizzato che ne prenda il controllo; se nella stabilità dei primi stati, fragili anche per ragioni “agro-ecologiche” e “epidemiologiche”, la coercizione gioca un ruolo più rilevante rispetto alle opportunità che essi hanno da offrire, cosa resta del canone che fin qui ha retto il racconto della nostra storia? Non molto, e l’archeologia ha mostrato da tempo sul piano cronologico le sfasature esistenti tra il momento in cui compaiono le prime forme di stanzialità, si sperimentano i primi tentativi di domesticazione di piante e animali e, molti millenni più tardi, si formano i primi stati.
Pur se a volte in chiave un po’ troppo “dimostrativa”, nel suo dover mettere all’angolo lo stato, Scott descrive e analizza in profondità le anomalie di questo canone, i motivi per cui a lungo si è evitato che l’agricoltura e l’allevamento diventassero pratiche dominanti (per la quantità di lavoro necessaria per difendere un territorio artificiale, per il rischio di epidemie legato alle specie domestiche), e quelli che invece progressivamente hanno fatto sì che l’agro-ecologia dei cereali prendesse forma (grazie anche al fatto di essere allo stesso tempo “visibili, divisibili, calcolabili, conservabili, trasportabili e «razionabili»”) contribuendo assieme ad altri, fattori – la coercizione, il cambiamento climatico – a creare le condizioni per la formazione dei primi stati. In questo lungo processo un ruolo particolare spetta alla domesticazione intesa come una modalità di “controllo sulla riproduzione” – del fuoco, di piante e animali, di noi stessi (chi/cosa addomestica cosa/chi?) – e che opera come una riorganizzazione qualitativa del mondo – della domus – intorno a sé. Con effetti non sempre prevedibili (epidemie). La domesticazione, provocatoriamente, viene letta come un “processo di dequalificazione”, una “contrazione dell’attenzione e della conoscenza pratica”, e anche rituale, del mondo portatrice di possibili ricadute politiche: un’unica autorità centrale ha per Scott più facilità ad imporsi in presenza di una risorsa dominante (il grano), che in un sistema ecologico complesso, come a lungo è stato quello delle terre umide della bassa Mesopotamia. In fondo, è là dove “finiscono le tasse e i cereali” che i barbari cominciano.
Per finire, riveniamo a noi. Una delle intuizioni più significative dell’archeologia, scrive Scott, è stata quella di interpretare l’idea di “caduta” (collapse) degli stati antichi come “lo smantellamento di unità politiche più grandi ma più fragili, nei loro componenti più piccoli ma spesso più stabili”, e in questo modo di considerarla non sotto l’aspetto tragico ma come “l’inizio di una riformulazione periodica, e forse anche salutare, dell’ordine politico”. In tempi come i nostri di diffusa (italica) isteria verso il ruolo da attribuire allo stato o a quella che viene presentata come la sua nemesi mitica, e che altro non è che uno stato ancora più grande, uno sguardo alla nostra preistoria può aiutare ad allargare la prospettiva. Perché al di là di qualunque idealizzazione, tanto dello stato che della sua assenza, quello che i nostri antenati ci mostrano sono pur sempre, per dirla con le parole di uno studioso della democrazia come Castoriadis, degli “indizi di possibilità”. Non è poca cosa, a volerli prendere sul serio. Perché rispetto alle società tradizionali, ai cacciatori-raccoglitori del Neolitico o a quei pochi che ancora sopravvivono in giro per il mondo, non c’è alcun dubbio che noi non abbiamo più nessuna idea sull’origine della nostra cultura materiale e, soprattutto, nessuna capacità di saperla riprodurre, se necessario.