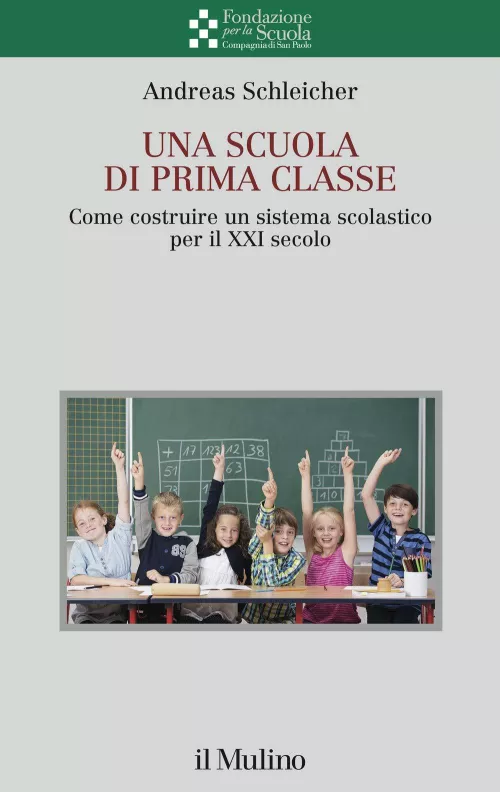Un sistema scolastico per il XXI secolo / Una scuola di prima classe
Il rapporto scritto da Jacques Delors (1996) e Education at glance dell’OCSE (2002) costituiscono due tappe significative dell’interesse maturato da una corposa letteratura economica nei confronti dei sistemi educativi. All’istruzione è attribuita, infatti, una lunga serie di benefici sociali ed economici sulla base di numerose ricerche che hanno documentato come un buon livello di alfabetizzazione rafforzi la coesione sociale e la partecipazione democratica (vedi qui) nonché l’assimilazione delle tecnologie, l’adattamento ai processi produttivi e lo sviluppo delle abilità tecniche che contribuiscono alla crescita dell’economia. Non sorprende – osserva Federica Cornali – che le raccomandazioni per il miglioramento dei sistemi d’istruzione, il rafforzamento dell’inclusione scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa siano diventati il Leitmotiv preferito dalle istituzioni politiche e dalle organizzazioni con finalità di promozione sociale ed economica (UE e OCSE).
La pubblicazione di Una scuola di prima classe, scritto da Andreas Schleicher, direttore del progetto PISA, s’inserisce in questa stagione culturale. Scritto nel 2018, tradotto in italiano nel 2020 e pubblicato da quel think tank che è la Fondazione per la scuola Compagnia di San Paolo, il libro si presta a molteplici livelli di lettura. Può essere attraversato come documentazione prodotta su realtà educative e politiche scolastiche assai distanti dall’orizzonte italiano. Oppure può essere letto come sintesi degli attuali discorsi neoliberisti sulla scuola che riducono la discussione sull’equità, sull’efficacia e sull’efficienza dei sistemi e educativi e formativi ad un territorio dell’economia politica. In altri termini l’istruzione è un bene posizionale non un valore in sé.
Dopo una breve ricognizione su cosa siano i PISA e sulla letteratura critica esistente, analizzerò l’opera da tre angolature: quale funzione implicita o esplicita è attribuita alla scuola per il futuro; cosa significa produrre conoscenza nel XXI secolo; con quale accezione sono utilizzati le nozioni di equità ed efficacia.
La querelle su PISA
I test PISA (acronimo per Programme for International Student Assessment) sono un’indagine internazionale triennale promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) su di un campione di studenti quindicenni volta ad accertare le competenze di lettura (comprensione del testo), matematica e scienze. Essi sono strutturati come una batteria di domande a risposta multipla e mirano a capire quanto le conoscenze disciplinari siano agite nella quotidianità e come si trasformino in procedure di apprendimento utilizzabili anche in futuro. Promossi per la prima volta nel 2000, l’ultimo ciclo (2018) ha visto partecipare 79 Stati; nel 2022, dopo un anno di ritardo a causa dell’emergenza sanitaria, essi saranno nuovamente proposti e gli studenti verranno testati su di una nuova disciplina: il pensiero creativo. L’ambizione delle rilevazioni è piuttosto alta. L’OCSE in molteplici documenti, e con notevole enfasi, ha sostenuto che PISA, lungi dall’essere un semplice test atto a rilevare e misurare un particolare set di competenze o abilità, «misura se un/a quindicenne è ben preparato/a per vivere in società», offrendo ai Paesi membri «uno specchio» per valutare questo obiettivo.
A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, diverse organizzazioni internazionali (IEA, UNESCO, OCSE) conducono ricerche su larga scala (LSA) nel tentativo di definire indicatori standardizzati in grado di misurare e comparare i livelli degli apprendimenti e il grado di efficacia delle politiche scolastiche dei diversi sistemi educativi sul piano internazionale. Lo IEA, associazione formata da centri di ricerca, servizi statistici, fondazioni, enti indipendenti, ha promosso sistematicamente rilevazioni su larga scala a partire dagli anni ‘90: IEA-PIRLS che valuta comparativamente le abilità di lettura dei bambini al quarto anno di scolarità; IEA-TIMMS rivolta alle abilità matematiche e scientifiche nel quarto e ottavo anno; IEA-ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) finalizzata a comprendere in che modo nei paesi occidentali i giovani sono preparati ad diventare cittadini.
I test PISA sono gli ultimi arrivati e con i precedenti hanno un rapporto di continuità e discontinuità. Da un lato hanno contribuito a normalizzare l’idea, tutt’altro che scontata, che la competenza si può definire, operazionalizzare e misurare. Dall’altro si distinguono per quantificare le competenze cognitive non ancorate ai curricula nazionali e, unici, per misurare le competenze non cognitive (soft skills).
La letteratura critica sul tema è assai nutrita e, per comodità, può essere distinta in tre ambiti. Il primo comprende le contestazioni sull’affidabilità delle rilevazioni perché debole (se non errato) è il modello statistico assunto. Una sintesi non troppo tecnica delle principali obiezioni metodologiche elaborate da matematici e statistici può essere letta qui e qui. Gli altri due lavorano sul versante ideologico. Un filone di studi, ascrivibile alla sociologia dell’educazione di matrice conflittualista o alla pedagogia critica, utilizza il concetto di governamentalità foucaultiano per rilevare come PISA sia una tecnologia di governo funzionale ad una narrativa neoliberale implicita, nel senso che il nascondimento dell’impianto valoriale (adeguamento all’esistente, imprenditorialità di sé stessi) è funzionale alla sua riproduzione, nonostante la retorica dell’equità di cui si ammanta. Un altro gruppo di ricerche, riconducibile latu sensu ai subaltern studies giudica i test come espressione di un neocolonialismo educativo capace d’imporre una standardizzazione e occidentalizzazione dell’agire didattico. Entrambi i filoni non contestano l’approccio quantitativo ai fenomeni dell’istruzione (presente in molte ricerche di scienze dell’educazione, pedagogia e sociologia dell’educazione) quanto l’ottica funzionalista che appiattisce l’istruzione sulla sfera economica. In discussione è la nozione di capitale umano che, come osserva tra gli altri Yang Zhao – «sottende una monolitica, distorta e angusta visione della funzione dei sistemi educativi internazionali» centrati sul vantaggio competitivo generato dalla conoscenza.
Non mancano e non sono mancate le semplificazioni. La penetrazione del discorso educativo neoliberista all’interno degli Stati, delle regioni, delle scuole e, in alcuni casi, persino delle famiglie è evidente: il DDL noto come la Buona scuola, le prove Invalsi organizzate su base censuaria, Eduscopio documentano la prospettiva efficientista sottesa all’economia dell’istruzione e la logica manageriale performativa introdotta nell’amministrazione pubblica (scuola inclusa) dalle pratiche ispirate al New management. Tuttavia le ricerche di sociologia dell’educazione attualmente a disposizione mostrano l’esistenza anche di una significativa dialettica tra scelte di politica scolastica nazionale e suggerimenti e\o normative elaborate da organizzazioni sovranazionali di vario tipo (UNESCO, OCSE, UE). In altri termini la relazione centro\periferia non può essere pensata in termini unidirezionali.
PISA è, dunque, oggetto culturale complesso, allo stesso tempo espressione, costruttore e moltiplicatore del dominio neoliberale sulla scuola. Storicamente è stato lo strumento attraverso cui l’OCSE si è radicata istituzionalmente in ambito educativo, creando personali comunità epistemiche di esperti competenti capaci di diffondere idee (soft policy) e pratiche politiche e strumenti di analisi (hard policy). Dal 2002 l’educazione è stata stabilita come Direttorato autonomo all’interno dell’OCSE e la sua struttura ampliata e potenziata; contestualmente sono stati avviati una serie di progetti (PIAAC per adulti, PISA per le scuole, TALIS per gli insegnanti) che hanno consolidato presso l’opinione pubblica l’immagine di una expertise in grado di valutare la qualità e l’equità dei sistemi educativi, nonché di monitorare i progressi o i regressi compiuti dopo diverse misurazioni. Un soft power capace di presidiare e di estrarre valore dai media digitali. On-line sono liberamente disponibili i report OCSE-PISA, i rapporti sui risultati di ricerca, i diversi framework o l’intero database internazionale. Numerosi tweets informano, poi, quasi quotidianamente l’opinione pubblica su particolari aspetti o approfondimenti dell’indagine.
Quale scuola per il XXI secolo?
È il momento di ritornare al testo. Alle osservazioni critiche Schleicher non fornisce mai una risposta diretta. Da un lato si limita ad osservare che la “rilevazione PISA non si arroga la presunzione di indicare a nessun Paese quelle che occorre fare”, ma semplicemente mostra quello che “fanno tutti gli altri” (p. 75). Dall’altro, nel primo capitolo, costruisce una narrazione titanica in cui pochi precursori hanno agito da apripista superando diffidenze e ostacoli nazionali. Certo le proteste nei confronti dei test esistono ma vengono ridotte a forme di nazionalismo educativo formatosi in contesti con un basso ranking nella graduatoria. Va da sé che non una parola è spesa per replicare alla richiesta di moratoria espressa da autorevoli accademici nel 2014 né sul valore reale dei dati forniti dalle autorità cinesi.
Nel mondo attuale la scuola ha ancora centralità cognitiva? Si, a patto di trasformarsi sensibilmente.
Le scuole di oggi sono state progettate nell’era industriale, nella quale le norme prevalenti erano la standardizzazione e la conformità, e in cui era ritenuto efficace ed efficiente canalizzare gli studenti in indirizzi di studio differenti e formare insegnanti una volta sola per tutta la loro carriera […] Le scuole odierne devono preparare gli studenti per un cambiamento che non è mai stato così veloce, affinché siano in grado di formarsi per lavori che non sono ancora stati creati, di affrontare sfide sociali che nessuno può prefigurare e di utilizzare tecnologie che non sono ancora state inventate (pp. 21; 40)
L’accelerazione tecnologica ha prodotto un cambiamento epocale nell’organizzazione e nei contenuti del lavoro: il capitalismo digitale impone, pertanto, un complessivo ripensamento dell’istruzione dato che
L’alfabetizzazione nel XX secolo consisteva nell’estrarre e nell’elaborare informazioni precodificate; nel XXI secolo, invece, implica la costruzione e la convalida della conoscenza. In passato gli insegnanti potevano dire agli studenti di cercare informazioni sull’enciclopedia e di fare affidamento su di esse in quanto accurate e veritiere. Oggi Goole, Baidu o Yandex ci pongono davanti milioni di risposte a qualsiasi domanda; il compito dei lettori è di triangolare, valutare costruire la conoscenza (p. 306)

Al di là di una certa retorica sul digitale, la tesi espressa deriva da un importante documento dell’OCSE, costantemente aggiornato: Schooling for Tomorrow (2001). Esso ha delineato tre scenari plausibili sul futuro dell’istruzione. Nel terzo si discute di trasformazione delle scuole in «organizzazioni d’apprendimento», capaci di conservare una certa funzione cognitiva a patto di superare un’ottica puramente trasmissiva del sapere e di sperimentare didattiche innovative grazie all’ausilio delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic). Vale la pena sottolineare che nel 2020 è stato diffuso Ritorno al futuro dell’educazione: quattro scenari OCSE per la scuola che tiene conto della pandemia attuale e delle sue ricadute in ambito educativo.
Quale conoscenza?
Istruire nella società della conoscenza significa, dunque, promuovere competenze (al plurale). Senza entrare nel merito di una letteratura amazzonica, le competenze sono declinate in molte lingue disciplinari e contesti d’azione, hanno assunto significati e definizioni diverse e controverse. Sono una componente retorica per designare e classificare alcuni modi di nominare alcune qualità individuali, ma anche parametri per valutare e misurare e ancora sono dispositivi che indicano contenuti professionali e formativi, o altre volte sono fattori per descrivere caratteristiche individuali legate alle identità e personalità dei soggetti. Tale polisemia ha generato una contrapposizione che, come sintetizzato da Mario Ambel, «anziché favorire un reale rinnovamento delle pratiche didattiche disciplinari nella direzione dell’emancipazione e del pensiero critico operativo, ha finito col contrapporre una difesa spesso anacronistica delle conoscenze all’affermarsi, alla fine vincente, di una visione delle competenze tutta aziendalista, competitiva o adattiva all’esistente».
Nel libro sono presentate due declinazioni:
a) competenza come educabilità. In diversi punti l’autore insiste sulla possibilità che ciascun soggetto sia istruito indipendentemente dalle condizioni socio-culturali di provenienza. In questo contesto il termine competenza coincide con la nozione di “obiettivo di apprendimento” da raggiungere nel quadro di una situazione didattica organizzata:
Alla radice di questo modo di pensare c’è la radicata convinzione che tutti gli studenti possono raggiungere gli stessi risultati e che sia compito degli insegnanti progettare spazi per l’apprendimento all’interno o all’esterno dell’aula, concepiti per aiutare gli alunni a realizzare le proprie potenzialità. Poiché tutti gli studenti riescono a portare a termine, uno dopo l’altro, i compiti assegnati, la condizione socioeconomica ha un impatto minore sui risultati scolastici, caratterizzati inoltre da una minore variabilità – esattamente i risultati che distinguono i sistemi scolastici dell’Estremo Oriente dagli altri nel rapporto PISA (p. 83)
b) competenza come quella forma di «sapere epistemico – affine al tipico modo di pensare, per esempio di scienziati, dei filosofi o dei matematici – [che] ha la precedenza sulla capacità di ricordare singole formule, luoghi o nomi» (p. 42).
Gli studenti di Taiwan sono stati tra i migliori nella valutazione in scienze del 2015 ma, in termini relativi, erano significativamente più bravi nella riproduzione dei contenuti scientifici, piuttosto che nella capacità di dimostrare di saper pensare come scienziati (p. 297).
In questa prospettiva Schleicher non ha dubbi che i sistemi educativi migliori, infatti, saranno quelli in grado di supportare e promuovere quelle metodologie di apprendimento fondate sul problem solving, identificato come l’unica azione didattica in grado di produrre apprendimenti significativi in quanto empiricamente verificabili in un contesto operativo differente da quello d’aula.
L’assolutizzazione di tale metodologia lascia perplessi per almeno due ragioni. La prima. Non è possibile «pensare come scienziati» se non si hanno conoscenze ed esperienza da scienziati, cioè se si dispongono di forti conoscenze disciplinari apprese in maniera organica e sistematica. Soltanto in seguito sarà possibile riconoscere schemi e analogie, trasferire il proprio sapere in nuovi contesti, inquadrare rapidamente il problema e risolverlo). Inoltre, l’obiettivo dell’istruzione è far pensare come uno scienziato o far apprendere quei contenuti scientifici (metodo e lessico disciplinare) capaci di promuovere la formazione di una personalità critica capace di discriminare tra discorsi scientifici e non? La seconda. Alcune discipline (soprattutto umanistiche), per loro natura, sembrano rifiutare una veste problem-solving: Francesco Germinario lo ha illustrato in maniera puntuale relativamente all’insegnamento della storia.
Schleicher, coerentemente con quanto elaborato dall’OCSE a partire dal 2015, enfatizza fortemente il ruolo che i sistemi educativi devono avere nella promozione delle non-cognitive skills (competenze socio-emotive): la ‘responsabilità’, la gestione delle emozioni, l’attitudine e la capacità di lavorare con gli altri. Anche in questo è necessario registrare che si è in presenza di costrutti concettuali tutt’altro che univoci. Essi, nelle parole di Vitteritti, funzionano come «frame simbolici» capaci di mobilitare attorno a parole chiave i discorsi pubblici e le politiche educative nazionali ma che «in molti casi idealizzano e semplificano molte questioni di natura teorica e critica». La pretesa di fornirne una misurazione, infine, è oggetto di forte discussione all’interno della comunità scientifica.
Quale equità e quale efficacia?
Il concetto di equità educativa è di recente formazione. Esso ha progressivamente integrato quello di eguaglianza e si riferisce alla giusta distribuzione in gruppo sociale di eque opportunità educative. Il Gruppo G.E.R.E.S.E. (Groupe Européen de Recherche sur l’Equité des Systèmes Educatifs) ha prodotto 29 indicatori di misurabilità raggruppati in tre categorie: le disuguaglianze interindividuali (ad esempio il grado di dispersione del numero di anni trascorsi nel percorso scolastico o dei punteggi ottenuti con riguardo alle competenze apprese), le diseguaglianze intercategoriali (ad esempio l’impatto dell’origine sociale sulla probabilità di ottenere un diploma o una laurea o sulla probabilità di ottenere punteggi elevati nei test sulle competenze apprese) e la quota di allievi restata sotto una soglia di apprendimenti. Strettamente legato all’equità è l’efficacia del sistema educativo in generale e dell’insegnamento in particolare, indicatore che si propone di massimizzare i risultati medi e di soglia minima. Proprio sotto quest’ultimo aspetto sono rilevanti le misurazioni standardizzate PISA.
La coppia equità\efficacia è una delle occorrenze più frequenti nel libro. Il capitolo IV, Perché l’equità nell’istruzione rimane inafferrabile, documenta come la qualità della scuola sia un «forte fattore predittivo» della ricchezza che un certo Paese avrà. Per tale motivo lo spreco di talenti non è solo una questione di giustizia sociale ma anche di politica economica. L’autore passa in rassegna quei sistemi educativi che sono riusciti a ridurre l’impatto dello svantaggio socioeconomico mediante allocazioni di risorse differenziate, interventi sulla governance scolastica o attraverso politiche del personale. A Singapore e in Giappone il governo trasferisce, mediante incentivazione economica, «gli insegnanti più bravi nelle scuole con i dipartimenti più deboli» (p. 199). A Shangai il governo «assegna agli istituti scolastici ‘più forti’» il compito di farsi carico dell’«amministrazione di quelle ‘deboli’» attraverso l’invio di docenti e di figure dirigenziali. (p. 201). Le informazioni sono di grande interesse per il contesto italiano dato che le ricerche mostrano un’iniqua distribuzione degli insegnanti che aumenta con il crescere del livello educativo: la combinazione tra segregazione abitativa di famiglie a basso reddito e\o immigrate e mobilità tra le scuole dei docenti produce uno spostamento di personale fortemente motivato verso scuole ritenute più comode o meno problematiche. Peraltro anche negli USA dove vige un sostanziale libero mercato dei docenti il problema è il medesimo.
Un po’ sorprendentemente non è presente, infine, una riflessione approfondita sull’efficacia dell’insegnante. Schleicher sottolinea l’importanza della cooperazione tra docenti, del riconoscimento pubblico del loro lavoro, ma riconosce che i sistemi di valutazione dei docenti laddove esistono son un «cantiere aperto». Non è chiaro chi debba valutare e cosa. L’unico caso preso in esame è quello di Singapore in cui gli insegnanti ricevono annualmente una valutazione da parte di una commissione in relazione a 13 competenze diverse, in un contesto di differenziazione della carriera docente. Vale la pena ricordare che esiste un importante filone di studi Educational Effectiveness Research, praticata dagli economisti dell’istruzione, che definisce l’efficacia degli insegnanti come il contributo dato all’apprendimento degli studenti misurato attraverso test standardizzati di competenze disciplinari. È attualmente prassi comune, seppur non esclusiva, misurare l’efficacia degli insegnanti tramite modelli di valore aggiunto, nei quali essa è stimata in un’equazione che tiene conto, oltre ad un indicatore per insegnante, di variabili a livello studente e di contesto.
Quali sono le caratteristiche dei sistemi educativi ad alto rendimento capaci di valorizzare il merito e di garantire l’equità delle opportunità senza che «il codice postale predetermini gli esiti del percorso scolastico»? Sulla scia delle ricerche comparative di Marc Tucker e del , alcuni elementi sembrano costanti: a) investimenti qualitativi nel settore dell’istruzione; b) assenza di canalizzazione degli studenti nella scuola superiore in ordini scolastici a diversa reputazione; c) curricoli e didattica scolastica flessibile calibrata sugli studenti e non sulla tutela della disciplina con una decisa sfrangiatura del superfluo e un orientamento verso le STEM; d) rigorosa selezione degli insegnanti, differenziazione salariale e funzionale (didattica e amministrativa), formazione in servizio costante, valutazione esterna del loro operato; e) autonomia competitiva tra pubblico e privato in un contesto di libera scelta educativa con una forte presenza dell’autorità centrale nel “mantenere una visione strategica e chiare linee guida per l’istruzione e offrire feedback significativi alle reti di scuole locali e ai singoli istituti” (p. 231). L’autore illustra i punti sopracitati riferendosi alle riforme scolastiche promosse a Singapore, in Estonia, in Canada, in Finlandia e a Shangai
Qualunque sia l’intervento di politica scolastica, la condizione perché riesca è il tempo: tempo per il coinvolgimento attivo di tutto il personale scolastico, tempo per la sedimentazione delle nuove norme e delle nuove pratiche in ogni punto della filiera, tempo per l’implementazione ponderata, tempo per superare le diffidenze di coloro che in linea di principio sono favorevoli ad una riforma ma non per i propri figli. L’intero capitolo quinto si risolve in un breviario di policy-making che documenta resistenze, fallimenti e successi di molteplici riforme scolastiche negli anni Duemila.
Il libro è lettura importante per avere consapevolezza del punto di vista di uno degli attori più influenti nella produzione di discorsi sulla scuola e nella definizione dell’agenda educativa del XXI secolo. L’aspetto più significativo del testo risiede, senza dubbio, nelle numerose informazioni su realtà educative e politiche scolastiche assai distanti dall’orizzonte italiano, la cui conoscenza potrebbe alimentare una riflessione meno provinciale. Il fatto che PISA e il Direttorato dell’OCSE siano espressione del dominio neoliberale non è squalificante di per sé di ogni studio o ricerca sull’educazione.
Rimane, tuttavia, la sensazione di un’irrisolta questione: una seria azione di contrasto alla povertà educativa e alle disuguaglianze scolastiche passa necessariamente attraverso la realizzazione di quote minime di giustizia sociale. Non si danno, infatti, discorsi e prassi efficaci sul contenimento della dispersione scolastica, sul miglioramento complessivo dei processi di apprendimento, sulla democratizzazione delle opportunità educative in presenza di una accentuata e profondamente ineguale distribuzione dei redditi e del capitale socioculturale, le quali si saldano frequentemente ad un’azione didattica, ad una quotidianità scolastica che rinforza il legame tra appartenenze sociali e destini individuali.
Il rischio è, altrimenti, discutere di scuola come se fosse una nicchia ecologica.
Andreas Schleicher, Una scuola di prima classe. Come costruire un sistema scolastico per il XXI secolo, il Mulino, 2020