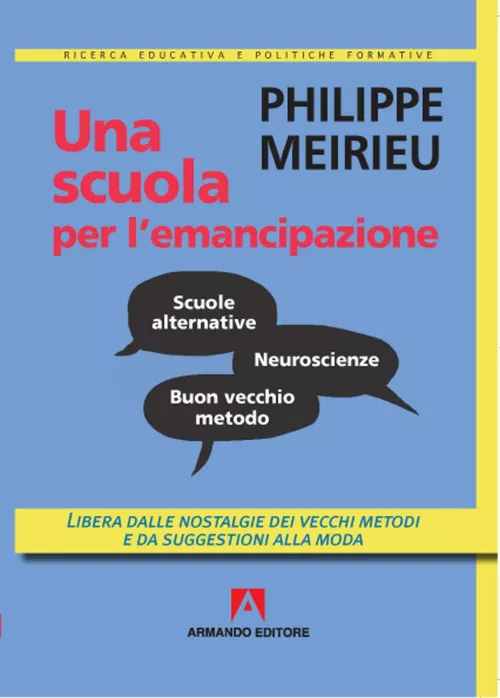Speciale
Una pedagogia politica per la scuola senza classe / Una scuola per l’emancipazione
Il sistema scolastico è scomparso dalla discussione pubblica. Il dibattito si concentra sulle filiere produttive non sugli studenti. Su bambini e adolescenti è calato un gelido silenzio come ha rilevato acutamente Chiara Saraceno. Dopo una prima fase segnata da una forte e comprensibile emotività caratterizzata da sovrabbondanza comunicativa in merito all’attivazione della didattica a distanza (Dad), istruzione e formazione si sono eclissate tra gli addetti ai lavori. Altre sono le priorità.
Le ragioni sono molteplici. Pesa la distribuzione demografica della popolazione italiana, così come una storica debolezza delle politiche educative in questo paese; ma anche una risposta ministeriale che, pur nelle comprensibili difficoltà, non è sembrata all’altezza. Si è già discusso in questa sede della nota ministeriale 388 che ha generato una vivace discussione per le implicazioni esplicite e implicite che conteneva.
Il recente decreto 22 ha introdotto l’obbligo per il personale docente di assicurare «comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza» per garantire – come recita la relazione tecnica di accompagnamento del decreto – «per il tempo dell’emergenza epidemiologica […] il diritto costituzionale all’apprendimento». L’art. 2 (comma a) dispone la possibilità di rimodulare il calendario scolastico, di concerto con le Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica. Saranno successive ordinanze a definire meglio i termini. A quasi due mesi dal blocco, con la presumibile certezza di chiudere l’anno scolastico in casa, è forte la sensazione che la pianificazione di cosa sarà il dopo sia ancora a uno stadio larvale. Eppure i tempi stringono inesorabilmente: le carenze strutturali del personale scolastico, i tempi fisiologici della burocrazia, l’edilizia scolastica non a prova di distanziamento sociale rischiano di restituire a settembre una situazione ingestibile indipendentemente dallo scenario epidemiologico che si configurerà.
Mi permetto di formulare al ministero tre quesiti:
a) quali azioni sistemiche si intendono porre in essere il prossimo anno scolastico per recuperare alla socializzazione e all’apprendimento milioni di studenti? Tutti e nessuno escluso, perché in maniera differenziata il bisogno di imparare nuovamente, recuperare, potenziare e consolidare abilità e conoscenze varrà per ciascuno. La didattica a distanza non ha raggiunto il 20% degli studenti. Il suo impatto sugli alunni diversamente abili è un mistero. La qualità degli apprendimenti, infine, è tutta da valutare, ma un elemento sembra evidente: la Dad necessita di una fortissima partecipazione delle famiglie al processo di apprendimento, tanto maggiore quanto è minore l’età dell’alunno coinvolto. Ne deriva che le risposte sono profondamente diversificate, strettamente dipendenti dal capitale culturale ed economico in possesso. In altri termini, vi è il serio rischio che in assenza di un intervento massiccio e articolato di ‘recupero’, questi mesi acuiscano le disuguaglianze educative preesistenti. Dal gruppo Condorcet è emersa la proposta, condivisibile, di riaprire ufficialmente l’anno scolastico a metà ottobre dedicando il mese di settembre all’opera di raccordo tra il prima e il dopo Covid-19. Non soltanto per le superiori ma, a mio avviso, in ogni ordine scolastico.
b) come verranno gestite le transizioni scolastiche dai diversi ordini di scuola, ma anche dal biennio al triennio delle superiori, che sappiamo essere generatori di dispersione scolastica? Tale aspetto è segnalato con forza dalle preoccupate sollecitazioni provenienti dalle associazioni professionali degli insegnanti.
c) perché, se la prospettiva è di proseguire con le Dad, non dotarsi di una piattaforma pubblica, sul modello francese del CNED senza appaltare alle multinazionali del settore?
Spero di essere smentito, ma la recente storia delle politiche pubbliche sull’istruzione insegna che dal centro arriveranno indicazioni generali e prescrittive senza oneri di spesa, scaricando sull’autonomia scolastica ciò che dovrebbe essere oggetto di un ponderato piano nazionale d’intervento. Sullo sfondo, poi, le famiglie finanzieranno ciò che in sociologia scolastica si chiama shadow education, vale a dire quel complesso di opportunità di educazione supplementare e integrativa (corsi di lingua, anni all’estero, ripetizioni) fortemente correlata al reddito, al livello culturale, agli ambienti sociali cui si ha accesso. L’estate, epidemia permettendo, sarà terreno di conquista.
Proprio perché il presente è carico d’incertezze, è quanto mai opportuno discutere dell’ultimo lavoro del pedagogista francese Philippe Meirieu, Una scuola per l’emancipazione (Armando, 2019) ottimamente tradotto e introdotto da Enrico Bottero. I suoi lavori di ricerca degli anni '80 e '90 hanno prevalentemente avuto come oggetto l’interazione tra pari nei processi di apprendimento nei lavori di gruppo e l’individualizzazione degli apprendimenti senza che ciò comporti pratiche di ghettizzazione. Coerentemente con la propria pedagogia politicamente impegnata, Meirieu non si è sottratto a misurarsi con «il fango delle cose concrete» ricoprendo importanti incarichi istituzionali tra cui la Direzione dell’INRP, Institut National de Recherche Pédagogique.
Una scuola per l’emancipazione riprende in una forma a metà tra saggio e pamphlet diverse considerazioni svolte in opere precedenti. Strutturato in due parti, Sul crinale e Nell’arena, il testo discute di problemi di stringente attualità: la tendenza a risolvere le difficoltà della scuola di massa con il ritorno a forme di pedagogia autoritaria, fortemente selettiva, tipica degli anni ’50; la proliferazione di scuole ‘alternative’, in cui un ingenuo spontaneismo accentua i processi d’individualizzazione dei percorsi formativi tipici degli ultimi dieci anni, all’insegna della ‘mercatizzazione’ del sistema dell’istruzione; le resistenze della scuola tradizionale ad organizzare ambienti di apprendimento formati da individui non omogenei per classi di età nonostante le ricerche educative restituiscano la positività del contrario; la trasformazione della motivazione dello studente da obiettivo da raggiungere in prerequisito per poter avere un’esperienza scolastica gratificante.

L’opera muove da una specifica caratterizzazione del sapere pedagogico in costante tensione tra i vincoli posti dalle situazioni di apprendimento e l’imperativo di liberazione dei soggetti, tra l’orizzontalità della comunicazione e l’asimmetria strutturale dell’educazione. Come già puntualizzato in Fare la Scuola, fare scuola (2015), la pedagogia è una pratica sociale che si distingue dalle scienze dell’educazione, intese come patrimonio di conoscenze provenienti dalla psicologia, dalla sociologia, dalla neurologia, dall’economia e dalla linguistica poiché insiste sulla finalità dell’educazione che, in un contesto democratico, non può che essere la seguente: «Formare soggetti capaci di resistere all’onnipotenza delle pulsioni, di pensare con la propria testa, e di impegnarsi nella costruzione democratica del bene comune» (p. 181).
Ne emerge un’idea di scuola come luogo di costruzione del collettivo e come luogo di decelerazione, argine alla dittatura dell’urgenza tipica della società dello spettacolo. Una scuola che è servizio pubblico ma anche istituzione. Precisazione importante, in quanto come istituzione ha finalità politiche non sempre coincidenti con quelle richieste dai soggetti che la fruiscono. È il discorso sull’autonomia scolastica che accentuando il primo aspetto ha generato ciò che l’autore chiama “consumismo scolastico”, la trasformazione della scuola in un soggetto di mercato a libero accesso. Proprio in Francia da diversi anni si è sviluppata una riflessione incentrata sul cosiddetto capitale spaziale ossia sulle opportunità che i contesti territoriali offrono a chi vi risiede, includendovi anche l’offerta formativa. La letteratura sul tema ha chiarito come siano emerse nuove distinzioni fondate sulla scelta scolastica: effetto istituto, strategie di evitamento sono espressioni tecniche che richiamano l’attenzione sul fatto che le classi sociali elevate indirizzano i propri figli verso scuole in cui non solo è garantita una buona qualità dell’insegnamento ma anche la partecipazione a specifiche reti sociali. Meirieu ne discute soprattutto in relazione alla proliferazione in Francia di scuole “alternative” private. In Italia la questione è oggetto di una serie di studi (Cavaletto, Checchi) che hanno dimostrato quanto l’effetto zona condizioni le scelte familiari e quanto sarebbe necessario reintrodurre vincoli più restrittivi per l’iscrizione degli alunni presso la scuola vicina alla zona di residenza, soprattutto nella scuola dell’obbligo.
Meritano una riflessione più distesa, anche in relazione alle circostanze presenti, i capitoli 9 e 10, in cui trova spazio l'idea della centralità della classe come comunità educativa e ambiente strutturante, per una scuola in grado di dotarsi di dispositivi attenzionali capace di contrastare il frazionamento dell'attenzione.
Formare all’attenzione riflette sul frazionamento dell’attenzione tipica del soggetto digitale su cui oggi si hanno una discreta serie di evidenze documentarie. Meirieu rileva come la scuola di massa attuale presti scarsissima attenzione alle strutture spazio-temporali in cui avviene l’apprendimento. Ad eccezione degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, «l’indifferenza nei confronti delle condizioni di lavoro reale (con l’eccezione di discipline che richiedono aule specializzate) rivela una grave irresponsabilità e ha causato un fenomeno di deistituzionalizzazione che oggi compromette la possibilità di soddisfare l’attenzione degli allievi» (p. 210-211). La scuola deve dotarsi di specifici rituali che servano da dispositivi attenzionali funzionali a recuperare quella che Yves Citton ha chiamato attenzione congiunta, frutto di un costante lavoro pedagogico in classe. Soltanto in un ambiente strutturante la pluralità delle sollecitazioni può essere contenuta e l’atteggiamento mentale dei soggetti collocato in uno spazio-tempo collettivo orientato. Tale tema s’intreccia con il recupero della dimensione operativa, del fare: l’incontro con gli adulti su un «progetto-oggetto che permetta di acquisire una pluralità di conoscenze essenziali, sia tecniche che sociali» (p. 218).
Risulta inevitabile proiettare questi discorsi in queste settimane di aule virtuali, di ambenti di apprendimento polverizzati nelle stanze in cui ciascuno è collocato. Quali rituali elaborare? Come non pensare che questo diluvio digitale possa provocare gigantesche forme di assuefazione e un ulteriore frazionamento dell’attenzione? Meirieu stesso rifiuta ogni atteggiamento tecnofobico, esito a suo dire di un pensiero debole privo di storicità. A certe condizioni specifiche (e difficili) le tecnologie digitali possono contribuire a far emergere il pensiero nello studente. Prima, però, occorre riportare alla dimensione politica la questione del digitale. In un saggio scritto per l’opera L’école, le numérique et la société qui vient del 2012 osservava:
«Il digitale è una questione politica, da assumere come tale: serve al controllo tecnocratico di individui consegnati all’individualismo o potrebbe servire alla liberazione collettiva per lo sviluppo di una democrazia umanamente degna? Il digitale a scuola è allo stesso tempo una questione pedagogica e antropologica: grazie ad esso che cosa trasmettiamo della “condizione umana”? Come ci mettiamo in relazione con i nostri giovani e come garantiamo loro le condizioni per poter crescere?»
Circola una preoccupazione in una parte del corpo docente: che l’attuale massiccio utilizzo del digitale a scuola, frutto di circostanze emergenziali, si traduca in scelte politiche future non sufficientemente ponderate. Un’inquietudine fondata sui modi con cui le tecnologie informatiche sono state introdotte in passato. Marco Gui ha recentemente ricostruito – sulla base dei documenti ministeriali – i diversi piani per l’innovazione digitale che dal 2007 hanno riguardato la scuola. Si è proceduto ad “ondate”, dettate in una certa misura dalle mode del momento (Lim prima, tablet, dopo), con il ricorso a retoriche giustificative organizzate attorno a tre argomenti: a) incrementare gli apprendimenti; b) aumentare le competenze digitali; c) aumentare le inclusioni di studenti con bisogni educativi speciali. Ad oggi, a fronte di notevoli investimenti (2 miliardi di euro), gli studi sul campo chiariscono che soltanto il punto c) ha conseguito buoni risultati. Il ritorno sui punti a) e b) è pressoché nullo. Anche quel filone di letteratura che insiste sull’esistenza di un progresso in termini di risultati di apprendimento riconosce che l’iniezione di tecnologie favorisce le abilità di utilizzo ma si traduce con molta difficoltà in sapere riflessivo. Si tratta di capire su cosa si vuole puntare: sviluppare una media education è urgenza democratica. Non ho immaginazione sufficiente per vedere nel digitale un superamento delle unità “aristoteliche” di azione-tempo-luogo didattico coniugabili con una scuola meno classista di quanto sia quella attuale.
Realizzare una valutazione esigente consegna un paradosso: l’attuale sistema di certificazione numerica degli apprendimenti è, nonostante la sua ridondanza, scarsamente esigente, troppo accomodante, poiché non permette all’allievo di migliorare. Vi domina una pedagogia bancaria, espressione mutuata dall’educatore brasiliano Paulo Freire, che scambia conoscenze con voti e si limita a un’assurda monetizzazione dei saperi: «l’allievo consegna il compito, è “compensato” con un voto positivo o negativo. La transazione finisce lì. Certo, sul compito ci sono annotazioni e correzioni, ma al più egli dedica un’attenzione distratta. Nel migliore dei casi rileggerà il compito per tener conto dei consigli ricevuti quando svolgerà il compito successivo. Ma tutto ciò, dobbiamo ammetterlo, resta qualcosa di molto casuale» (Meirieu, p. 226)
Al di là dei correttivi che si possono praticare, in primo luogo la correzione reciproca tra pari rigorosamente organizzata, Meirieu ritiene necessario riorientare la valutazione secondo una pedagogia del capolavoro capace di impegnare lo studente nell’elaborazione e produzione di un progetto mediante il quale verificare l’impegno del soggetto nel suo lavoro e gli apprendimenti realizzati. Il tema della valutazione torna ad essere, come è sempre stato, prepotentemente divisivo, poiché in esso convergono e si contrappongono idee di scuola e di società reciprocamente escludentesi come documenta il dibattito surreale sul presunto 6 politico di fine anno. La nota 388 del Ministero parla di valutazione che non deve essere trasformata in «in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica» perché essa «ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa». Si è prodotto un falso dilemma sulla seguente questione: si può usare la valutazione formativa per mettere un voto? Laura Greenstein in La valutazione formativa ha osservato che «la risposta a questa domanda dipende dall’insegnante. Esiste una controversia animata nell’uso della valutazione formativa nell’attribuzione dei voti, e si concentra sull’opportunità o meno di dare voti a tutti gli studenti in modo coerente con il livello dei loro risultati o dare un voto alla loro crescita verso la padronanza degli standard» (p. 20).
In realtà, al di là delle sensibilità e della postura di ogni singolo docente, il problema di fondo risiede in un sistema scolastico tutto orientato sulla valutazione sommativa, in coerenza con le disposizioni europee e internazionali, interamente proteso verso la certificazione numerica (reintrodotta anche nella scuola primaria gettando alle ortiche anni di riflessione e pratiche) a cui oggi si chiede una improvvisa torsione verso una valutazione formativa o, per dirla in maniera raffinata, di assumere “atteggiamenti” valutativi attenti ai processi di apprendimento e non solo ai risultati. La lettura di Una scuola per l’emancipazione impone una riflessione su ciò che è culturalmente prioritario sia nelle politiche educative sia nell’attività d’insegnamento. Nell'attuale condizione di ulteriore emergenza è operazione quanto mai necessaria.