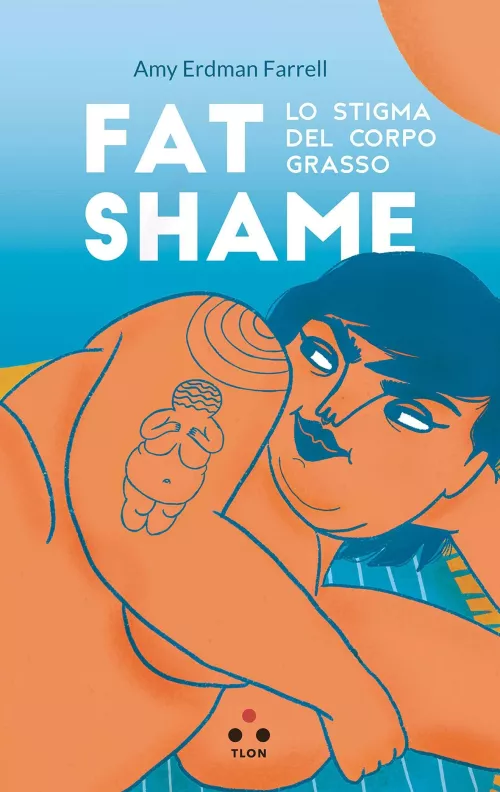Grassi. Una storia culturale della materia della vita / Alle origini del fat shaming
Era la fine del Settecento, e i corpi abnormi di Daniel Lambert, detto “Fat Dan”, quattrocento chili di pinguedine, e di Claude Ambroise Seurat, l’uomo scheletrico, comparivano tra gli spettacoli freak della Hall of Wonders di Piccadilly, a Londra. Stranezze umane esposte per creare stupore e disgusto, meraviglia e raccapriccio. Il body shaming già esisteva, è evidente, e non c’era nulla di male nel praticarlo. Anzi, era proprio la logica di quel tipo di spettacolo. Roba superata, assolutamente scorretta, eticamente ingiusta, si dirà, oggi che si invoca e si pratica body positivity. Eppure, in tv vanno in onda programmi dedicati al dimagrimento di donne e uomini superobesi affiancati da chirurghi accaniti che rimpiccioliscono stomaci o da personal trainer muscolosi e urlanti che, con spirito militaresco, incitano i propri clienti senza fiato mentre salgono di corsa trecento o più gradini.
Tra una visita medica e una seduta di allenamento, le telecamere inquadrano inclementi pance flaccide, braccia fuori misura, gambe edematose, tra abiti deformi e paccottiglia da fast food. Il corpo grasso è – ancora – servito.
Del resto, se si invoca la body positivity è perché c’è qualcosa come una body negativity, e il fat activism, movimento sociale sorto negli anni 60 per ripensare il grasso, e le sue relazioni con le categorie del bello e della salute, deriva proprio dal fat shaming. Ogni fenomeno di valorizzazione in positivo del corpo diverso vien fuori dal suo contrario: dalla denigrazione, dal discredito, dall’offesa del fisico difforme. È banale, ma è fondamentale comprendere le forme del disgusto e dell’offesa, capire il senso della denigrazione, per tracciare le vie della rinascita e della rivalorizzazione del corpo diverso. È il caso, tra gli altri possibili, del corpo grasso. Anzi, del grasso in sé, come materia della vita – in tutti i sensi, evidentemente.
Christopher E. Forth, in Grassi. Una storia culturale della materia della vita (Torino, Espress, 2020, pp. 406), spazza via il luogo comune secondo cui il corpo grasso in epoca premoderna avesse sempre un significato positivo, associato a fecondità, salute, ricchezza, e dunque a bellezza. Per studiare gli stereotipi della cultura occidentale legati al grasso, Forth sfata il più celebre: il fat shaming non è roba del nostro secolo, la lotta al grasso è vecchissima quanto l’umanità. Il “miraggio spartano” dei cittadini fisicamente perfetti dell’antica Grecia, con il loro culto del corpo e dell’efficienza ginnica, si ritrova, scrive Forth, nel Rinascimento, nell’Utopia di Tommaso Moro e nei miti successivi che hanno esaltato ristrettezze, fatiche corporali, controllo degli appetiti e lussi. Miti e pratiche che arrivano fino ai giorni nostri (cosa è, del resto, l’odierna moda del digiuno intermittente?). Sebbene in alcuni periodi il grasso sia stato visto meglio, la storia culturale del grasso in Occidente non prevede un momento in cui sia stato accettato senza riserve. Semplicemente, l’odio per la materia grassa si è inasprita con il tempo.
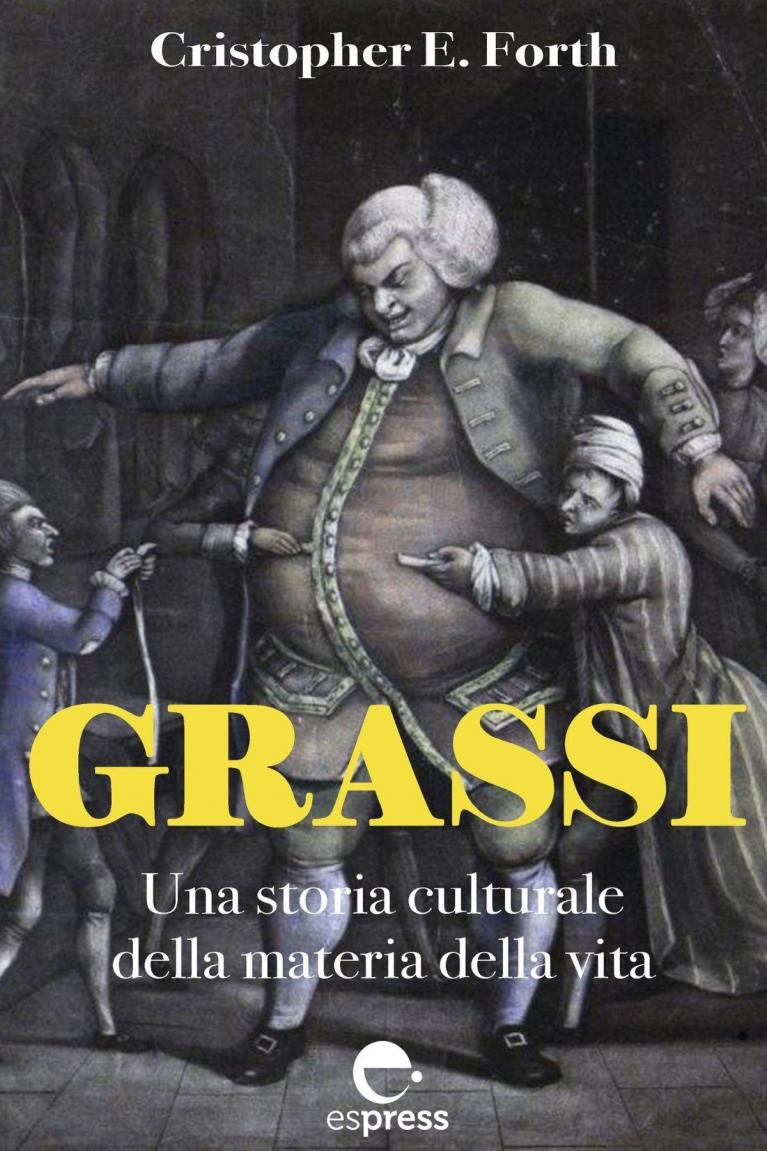
Secondo Forth, la causa sta nel fatto il grasso contiene in sé categorie contrastanti: il fertile e il marcio, il benefico e il pericoloso, l’alto e il basso, la malattia e la salute, lo sporco e il pulito, l’animalesco e l’umano. Ripercorrendo la storia del grasso attraverso i secoli e in vari campi del fare umano (agricoltura ed economia, politica e sport, medicina e arte), Forth porta avanti un’ipotesi molto interessante e pressoché unica tra gli studi sui grassi: il problema non sono le persone grasse, ma i significati della materia grassa in sé. Che è ambivalente, dotata di indecidibilità sensoriale: scivolosa, unta, molle, liscia, capace di essere né liquida né solida, o tutte e due insieme. Merito del libro di Forth, infatti, è di ipotizzare che i significati ambivalenti del grasso siano legati ai tratti materici, concreti, espressivi della sostanza in sé, qualsiasi essa sia: non solo quella della carne umana, ma anche quella della terra, dei cibi, degli animali, degli olii, delle secrezioni.
Ecco che, per esempio, la terra grassa, tipica dell’immaginario agricolo antico, è fertile ma al tempo stesso putrescente, la sua fecondità deriva dalla marcescenza del letame e dei liquami. È grassa nel doppio senso di ricca e sporca. Si pensi anche all’olio: se raffinato può essere puro e persino spirituale (si consideri la predilezione moderna per gli oli essenziali o per l’olio extravergine di oliva), ma “sotto forma di grasso appiccicoso, questa sostanza riesce anche a suscitare disgusto, un’emozione declinata culturalmente che i romani chiamavano fastidium”. Anche il grasso umano veniva usato nella farmacopea antica come rimedio popolare per le ferite: specialmente quello dei criminali, abietti della società, che trovavano riscatto da morti, trasformati in unguento medicamentoso.
Il grasso è prima di tutto “stuff” (del resto il titolo originale del libro è proprio Fat: A Cultural History of the Stuff of Life), materia, cosa, sostanza che sollecita sensazioni. Che non sono solo visive, ma anche tattili e olfattive. Il grasso è legato alle secrezioni corporee – soprattutto al sudore, fa notare Forth, e anche alla sporcizia – agli odori, alla mollezza, al freddo, all’umido. L’uomo grassoccio era poco virile e affidabile già nell’antichità classica: la mollezza e l’umidità erano associate alle rappresentazioni del femminile. L’umidità non era solo una proprietà del corpo della donna, ma anche del suo umore. Del resto, per gli antichi, gli stati d’animo erano prima di tutto stati fisici. Il corpo della donna era poroso, assorbente, pieno di liquidi, mentre quello maschile era sodo, duro e muscoloso. L’effeminatezza diventa quindi tratto dei corpi grassocci che, se maschili, diventano subito poco virili ed inefficienti.
Ecco, in buona sostanza, da dove vengono gli attributi morali negativi che spingono a pensare che una persona grassa sia indolente, inaffidabile, insicura, incapace, persino egoista: risiedono nelle proprietà ambigue delle sostanze grasse, e nei significati che le culture e le epoche hanno dato a questa materia della vita. E che stanno alla base dell’obesofobia contemporanea, del fat shaming che isola gli obesi, tra gli altri, nel mondo lavorativo, e delle discriminazioni che colpiscono le persone grasse nella vita di tutti i giorni (dalle dimensioni delle sedute sugli aerei a quelle nella sala di attesa del medico).

Forth, interessato a spiegare il legame tra grasso e pregiudizi, ricostruisce l’intreccio con altre categorie di discriminazione: il gender, la gerarchia sociale, la provenienza etnica. Non solo il grasso è molle e femminile, ma la donna nera in epoca coloniale è sessualmente incontenibile, ricettacolo di sporcizia e contenitore di appetiti animaleschi, da cui l’uomo bianco europeo e magro deve fuggire. Ecco che nell’Ottocento, per esempio, il sapone è la sostanza che si oppone all’unto sporco, e sui giornali britannici le pubblicità del sapone usano immagini razziali per associare sporcizia, povertà, immigrazione.
Da qui la reazione del disgusto, presentata come fondamentale nel libro, in quanto esperienza che lega tutte le manifestazioni del grasso. E che si spiega come repulsione per l’alterità di qualsiasi tipo. Il grasso si lega all’altro: il femminino, il nero, il povero, la malattia, la morte.
Il rifiuto del grasso fa parte di un più profondo modo di pensare occidentale che cerca di eliminare la corporeità, di alleggerire il fardello della carne. Una ideologia che si è acuita dall’inizio del Novecento in poi con forme di salutismo coercitivo e varie utopie corporee, tra cui Forth inserisce le diete dimagranti (si pensi alla cosiddetta paleo dieta dei giorni nostri, cosa è se non la volontà di un restaurare un mondo primitivo che non esiste più?). Il grasso ci ricorda la nostra limitatezza, la durata della nostra vita, il destino della morte, la marcescenza, la putrefazione. Insomma, non è il grasso, scrive Forth, a essere problematico, ma la nostra corporeità, ovvero la vita umana stessa.
Se il libro di Forth guarda molto indietro per individuare le condizioni culturali del disgusto per il grasso che hanno caratterizzato la storia dell’umanità in varie epoche, in Fat Shame. Lo stigma del corpo grasso (Roma, Tlon, 2020, pp. 382) Amy Erdman Farrell si concentra sull’immagine del corpo bianco “civilizzato”, occidentale perché snello, sodo e preferibilmente maschile.
Farrell scruta la cultura americana contemporanea, dall’Ottocento in poi: analizza materiali dell’immaginario popolare tra cui pubblicità, cartoline, fumetti, riviste (come Life o Harper’s Weekly) ma anche fenomeni mediatici recenti come la campagna anti obesità degli Obama o i gossip sul peso di Britney Spears. Cartoline umoristiche ottocentesche, per uomini, con donne grasse chine a mostrare un sedere traboccante (pruriginoso per i maschi di basso ceto ma vietatissimo per i bravi borghesi), mariti ricchi (i fat cats, si chiamavano non a caso) con pance enormi traditi da mogli carine, cameriere irlandesi nelle case delle signore americane che capitombolano giù per le scale perché goffissime e grassocce, pubblicità di prodotti dietetici per il “grasso che uccide”: Farrell mette insieme un ricchissimo materiale che testimonia come la qualità del grasso sia associata, nell’immaginario ottocentesco e novecentesco, agli inferiori, alle categorie più basse, dei neri e dei primitivi, dei poveri e dei criminali (per Lombroso le donne delinquenti erano basse e grasse).
Ci sarebbe quindi, secondo Farrell, un “corpo civilizzato”, magro, definito, controllato che la cultura occidentale ha costruito in vari modi, a partire dalla definizione di un corpo “inferiore” e altro. La Venere di Willendorf, ritrovata in Austria nel 1908, e che al liceo ci viene presentata come ideale di bellezza femminile e simbolo di fecondità, sarebbe una delle rappresentazioni del grasso primitivo che il Novecento ha individuato per costruire, in contrasto, il proprio ideale di bellezza. Ecco il corpo primitivo, arretrato, non ancora evoluto: è grasso.
Farrell discute a questo proposito del tema del controllo e del potere sul corpo, in particolare nell’ambito dell’attivismo femminista, e fa notare come le cose cambino a seconda dei punti di vista. Le suffragette americane, per rispondere ai loro detrattori che le rappresentavano come brutte, grasse, aggressive, desessualizzate, si presentavano, sulle copertine delle riviste e sui manifesti pro voto delle donne, invece belle, magre, affascinanti. Potere alle donne significava anche potere sul proprio corpo. E l’autrice nota come il femminismo della prima ora abbia contribuito, solo in apparenza paradossalmente, alla denigrazione del grasso nel corpo della donna: per dimostrare capacità di controllo, per non farsi attribuire qualità di inaffidabilità, inefficienza e mollezza, non poche femministe avrebbero ceduto alle diete dimagranti. Riaffermando così proprio l’ipotesi che un corpo civilizzato, capace di vivere in società, efficiente, funzionante, sia prima di tutto privo di peso.
Non tutti gli attivismi sono buoni, dice Farrel, accusando anche certi movimenti animalisti, vegetariani, biologici, e alcuni integralismi del mangiar bene e i locavorismi esasperati, di accrescere il disgusto per l’obesità e, con essa, il fat shaming. Niente più sconcertanti e spettacolari hall of wonders, ma efficaci e catastrofiche stigmatizzazioni del peso, e conseguenti battaglie intestine tra nuovi nemici.