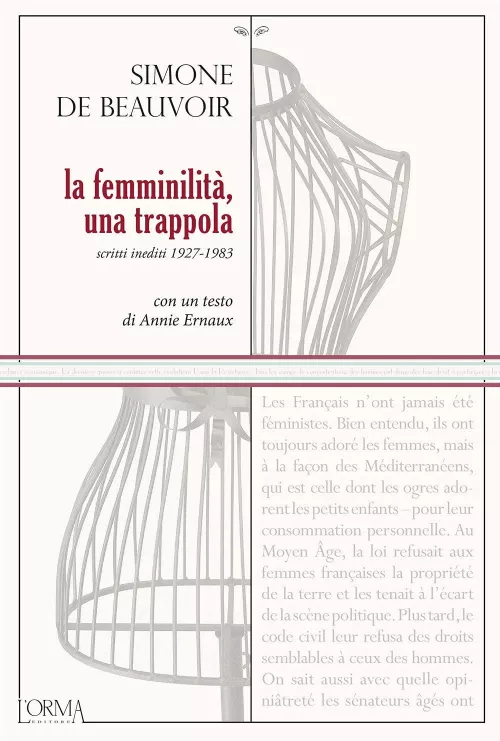Due libri / Simone De Beauvoir e la trappola della femminilità
Del Secondo Sesso Julia Kristeva disse che si trattava di un’opera “in preparazione dalla notte dei tempi; covava sotto le ceneri dei focolari: sfrigolava nei pentoloni; esplodeva nelle camere da letto; si diceva e non si diceva” (traduzione di Alda Arduini). Tuttavia, quando Madeleine Chapsal fu mandata a intervistare Simone de Beauvoir e le chiese di parlare della genesi dell’opera, l’intellettuale parigina rispose che l’idea le era “venuta tardissimo. Uomini o donne, pensavo che ciascuno può cavarsela; non mi rendevo conto che la femminilità fosse una situazione. Ho scritto tre romanzi, dei saggi, senza preoccuparmi della mia condizione di donna. Un giorno mi è venuta voglia di dare una spiegazione su me stessa. Ho cominciato a riflettere e mi sono accorta con una specie di sorpresa che la prima cosa che avrei dovuto dire era: sono una donna. L’intera mia formazione affettiva, intellettuale, è stata differente da quella di un uomo. Ho riflettuto su questo e mi sono detta: bisognerebbe vedere sul piano generale, e nei particolari, cosa significa essere donna” (traduzione di Vera Dridso).
Il Secondo Sesso, inizialmente, avrebbe dovuto intitolarsi L’Altra. Ci sono due tipi di alterità: ve n’è una che si può dire verticale e univoca, e un’altra che è invece orizzontale e reciproca. Mentre il secondo tipo di alterità ha a che vedere col rispettare ciò che è altro da sé, abitando la differenza senza volerla eliminare, e non porta con sé giudizi di valore, il primo tipo di alterità ha a che vedere con i rapporti di potere, primo fra tutti quelli tra uomo e donna per come si sono storicamente configurati – ossia con l’uomo, l’Uno, il Soggetto, che pone la donna, l’Altro, l’Oggetto. Possiamo anche dire che la donna è Tutto, “ma lo è nella modalità dell’inessenziale: è tutto l’Altro”. Al di là dell’analisi storica, sociale, antropologica della condizione della donna che Simone de Beauvoir propone nel Secondo Sesso, c’è un’altra questione, che corre sottotraccia nei suoi romanzi, nei suoi saggi, e nella sua vita personale: il fatto di stare dove l’altro si aspetta che tu sia. L’altro, in questo caso, è l’uomo generalmente inteso, ma anche la donna, ma anche un individuo specifico, e infine pure la parte di sé che allestisce un ideale esistenziale.
Credo sia questo il tema centrale di La femminilità, una trappola, il saggio che dà il titolo alla raccolta di scritti inediti di Simone de Beauvoir, pubblicati da L’Orma e tradotti da Elena Cappellini, Beatrice Carvisiglia, Camilla Diez, Claudia Romagnuolo ed Elena Vozzi. Nel 1947, quando scrive questo saggio, Simone de Beauvoir è impegnata in un tour di conferenze negli Stati Uniti; sta iniziando a pensare al Secondo Sesso, e se pochi mesi prima diceva a Sartre che il fatto di essere donna per lei non aveva “mai contato”, e non le aveva mai dato “il minimo fastidio”, adesso si è resa conto che l’essere donna è una situazione, un contesto, e “se è vero che tutti gli esseri umani coscienti e liberi hanno lo stesso valore, la stessa dignità, è anche vero che sono il contesto e le opportunità a determinare i problemi che ciascuno deve affrontare”. Alla radice dei problemi che le donne devono affrontare c’è il mito dell’eterno femminino, “che descrive le donne come intuitive, affascinanti, sensibili”.
Simone de Beauvoir, tuttavia, non è cieca di fronte al fatto che questo mito, pur inventato dagli uomini, è stato perpetuato grazie alla complicità delle donne; una complicità che ha alla base il desiderio di piacere, e che dunque ha a che fare con lo sguardo dell’Altro, col farsi trovare esattamente là dove l’Altro si aspetta, appunto. “La bambina è incoraggiata a sviluppare il suo potere di seduzione, a essere aggraziata, ben vestita, educata. È costantemente spinta a rivolgersi agli uomini, a cercare un aiuto esterno. Il suo senso di dipendenza e la sua debolezza aumentano”. In questo senso, “si spiega perché finora le donne hanno raggiunto solo di rado quello che è comunemente chiamato genio”, perché il genio “presuppone che non si cerchi con ansia lo sguardo degli altri per capire se esso racchiuda approvazione o biasimo, ma che si guardi con coraggio verso orizzonti ancora insospettabili”. Non cercare con ansia lo sguardo degli altri, dell’Altro, significa rinunciare al desiderio di piacere: “le donne temono che perdendo questo senso di inferiorità possano perdere anche ciò che le valorizza agli occhi degli uomini: la femminilità”. Rinunciare al desiderio di piacere significa dunque rinunciare a farsi compimento del desiderio maschile, che è desiderio di potenza; significa venire meno a una aspettativa – di oggetto di piacere, di Altra –; significa rimettere in discussione il rapporto tra i sessi, le posizioni che ciascuno dei due occupa. “È questa la contraddizione che affligge molte donne oggi: o rinunciano in parte a realizzare la propria personalità, o rinunciano in parte al potere di seduzione sugli uomini”.
Mettere in discussione questi modelli, chiaramente, riguarda tanto la donna quanto l’uomo: come sottrarsi a posizioni storicamente così definite? E se le donne questa domanda la hanno sollevata da tempo – qui con Simone de Beauvoir, prima con Virginia Woolf, ancora prima con Sibilla Aleramo, – sono gli uomini che oggi si trovano a dover fare i conti con lo sguardo dell’altro, un Altro che si configura come colui, colei, che pone la domanda di piacere o di potenza, ma che si configura anche come l’Altro ideale a cui conformarsi – la donna che sa essere donna, l’uomo che sa essere uomo.
Nella costruzione di un’alterità verticale, dunque, l’uomo ha sì posto la donna in una certa posizione – quella di Oggetto, di Altro desiderato, di moglie accudita e madre accudente - ma al contempo ha ritagliato una posizione molto definita anche per sé – quella di Uno, di Soggetto desiderante, di marito in carriera e padre autoritario. Come uscire da questo schema, la cui rigidità deriva dal fatto che alimenta e insieme è alimentato dal desiderio che lega uomo e donna? Il desiderio della donna che crea per sé e per l’uomo determinate aspettative, e viceversa. È, questa, “la parte di scacco che c’è in ogni esistenza”, e che è determinata da quella alterità verticale storicamente posta.

E tuttavia, dicevo, c’è anche l’alterità orizzontale, reciproca, e che, più che essere posta, si dà; è l’alterità che esiste nelle relazioni individuali, nei rapporti di coppia. La questione in questo caso diventa: quanta alterità si è disposti a tollerare? Quante differenze? Simone de Beauvoir, nelle sue Memorie d’una ragazza perbene, scrive di ciò che da giovane si aspettava da una relazione sentimentale: “Io volevo che tra marito e moglie tutto fosse in comune; ciascuno doveva adempiere nei confronti dell’altro quel ruolo di esatto testimone che in passato attribuivo a Dio. Ciò escludeva che si potesse amare una persona diversa: mi sarei sposata solo se avessi incontrato, più compiuto di me, il mio simile, il mio doppione” (traduzione di Bruno Fonzi). Il suo simile, il suo doppione, lo trova in Sartre: “Sartre rispondeva esattamente al sogno dei miei quindici anni: era l’alter-ego in cui ritrovavo, portate all’incandescenza, tutte le mie manie”. Simone de Beauvoir trova in Sartre un altro che non è Altro, trova una persona che risponde a quell’ideale iper-razionalizzato che lei aveva in mente; trova, di fatto, qualcuno con cui “fare Uno da quei due che siamo”, come diceva Aristofane (Platone, Simposio, traduzione di Ezio Savino).
E a questo desiderio di unità, sancito dai due con un patto – “non soltanto nessuno dei due avrebbe mai mentito all’altro, ma non gli avrebbe dissimulato niente” (L’età forte, traduzione di Bruno Fonzi) – Simone de Beauvoir cerca di corrispondere, creando per sé un ideale fondato sulla ragione. La ragione, la razionalità estrema diventa il meccanismo di controllo, l’unico modo per essere all’altezza intellettuale di quell’Uno – di stare, dunque, sempre là dove l’altro si aspetta. E tuttavia pensare di fondare tutto sulla ragione significa escludere la possibilità dell’Altro: dell’altro che sta fuori di me, dell’altro che sta fuori dall’Uno della coppia, ma anche dell’altro che sta dentro di me – la parte emotiva, sentimentale, passionale, ciò che non è ragione, e che dunque è carne, corpo.
“La figura dell’Altro, in cui Beauvoir individuerà l’assillo di fondo della sua giovinezza e delle sue prime opere, ha fin dall’inizio una duplice valenza: necessario alla costituzione dell’io, è percepito anche come minaccia alla sua integrità, fascinazione del perdersi”, spiega Sandra Teroni in Simone de Beauvoir (Donzelli ed.). Fare Uno, nella coppia, significa annientare sia l’Altro – ostinandosi a vederlo come un “per me” e non nel suo “in sé” – sia se stessi; o meglio, più che annientarli, fare sì che le loro identità siano reciprocamente dipendenti e che lo stare al mondo di uno sia legittimato dall’altro, e viceversa. Così, nel momento in cui questo Uno viene meno – perché arriva una terza persona, ad esempio – ciò che subentra è una perdita di identità. «Io non sono nessuno», dice la giovane intellettuale protagonista del primo romanzo pubblicato da Simone de Beauvoir, L’Invitata, quando si rende conto di essere stata esclusa dagli altri due componenti di un triangolo amoroso; “e la stessa frase ripete l’affermata psicoanalista nel romanzo I Mandarini (1954), quando rinuncia a un grande amore che si vuole totalizzante e senza il quale, tuttavia, sente di non essere niente”, spiega Teroni.
Se l’Altro che aveva determinato il mio ideale – un ideale di pura ragione, un essere desiderato ma non desiderante – viene meno, allora chi sono io? Questa è la domanda di fondo di Una donna spezzata. È un’operazione coraggiosa, quella che Simone de Beauvoir fa con questa novella: ciò che sta mettendo in scena è il venire meno di quell’ideale di ragione su cui aveva fondato la propria vita, le proprie scelte, le proprie relazioni. Quell’ideale in nome del quale aveva abbandonato Nelson Algren per tornare da Sartre: “Non è per mancanza di amore che non posso stare e vivere con te. […] Ma c’è un fatto. E il fatto è che Sartre ha bisogno di me”, gli scrive. Quell’ideale a cui per tutta la vita ho teso, quell’ideale intellettuale con cui ho cercato di collimare per rispondere allo sguardo dell’altro, era davvero libertà? La libertà intellettuale è il massimo livello di libertà a cui si può aspirare? In che misura le mie scelte sono determinate dal desiderio e dal bisogno dell’Altro, e in che misura dal mio desiderio e dal mio bisogno? È possibile conciliare fedeltà e libertà? A quale prezzo? La risposta a queste domande viene ricercata mettendo in scena l’opposto della razionalità: c’è Monique, la donna spezzata, che è tale perché ha perso la propria identità nel momento in cui l’Uno che lei pensava di formare col marito Maurice è venuto meno. Maurice ha da tempo una storia con un’altra donna, che è l’opposto di Monique. “Svegliandosi, coccolerà anche lei entro il cavo della spalla chiamandola mia gazzella, il mio uccellino dei boschi? O avrà inventato per lei altri nomi, che pronuncerà con quella stessa voce?” (traduzione di Bruno Fonzi).
Monique immagina, e dunque diventa gelosa; diventa gelosa di un Tutto che immagina abbiano ricostruito, senza di lei, Maurice e l’altra donna; diventa gelosa del lessico famigliare che faceva parte del loro Tutto; diventa gelosa della voce di Maurice, persino. Ed è quest’ultimo elemento forse il più significativo: la voce è elemento identitario – il primo elemento di auto-riconoscimento nel bambino, uno dei primi sintomi della metamorfosi per Gregor Samsa – ed è proprio l’identità che Monique perde. La perde come immagine di Maurice, ma soprattutto perde la propria. “Credevo di sapere chi ero io, chi era lui, e d’un tratto non riconosco più né lui né me”, e più avanti “io ho perduto la mia immagine. Non che la guardassi spesso, ma era lì, un po’ indietro, sullo sfondo, quale Maurice me l’aveva dipinta”. È quello che succede al matrimonio di Rosalind ed Ernest Thorburn in uno dei racconti di Virginia Woolf: i due si sono dati dei soprannomi – Lappin e Lapinova, rispettivamente Coniglio e Lepre. Inizia per gioco, ma presto diventa ciò su cui si regge l’intero matrimonio, senza che i due se ne rendano conto; una sera, però, di fronte al fuoco, Rosalind si rabbuia. Ernest le chiede cosa sia successo, e lei, col terrore negli occhi, dice “si tratta di Lapinova… È sparita, Ernest. L’ho persa!”. “E quella fu la fine del loro matrimonio”, commenta la voce narrante.
Questa è la conseguenza del fare Uno, di annientare l’Altro e il Sé nel nome di un Tutto. Invece, è bene che l’altro rimanga altro anche nei sodalizi, anche nei ménage à trois, anche nelle scappatelle; anche negli amori più grandi. Si tratta di tollerare un certo livello di differenza, e anche la solitudine che questa comporta, di sottrarsi allo stare sempre dove l’altro si aspetta, di accettare che la tensione che costituisce l’amore – il possesso totale dell’altro nel nome della creazione di un Uno – rimanga un asintoto. Per Monique questa presa di coscienza arriva solo alla fine: “So che mi muoverò. La porta si aprirà lentamente, e vedrò cosa c’è dietro. C’è l’avvenire. Io sono sulla soglia. Ho paura”.
C’è un solo luogo, dice Simone de Beauvoir in uno dei saggi raccolti da L’Orma, in cui questa alterità si può risolvere, e quel luogo è la letteratura, in cui la distanza e l’incomunicabilità tra individui vengono momentaneamente colmate: “credo che la fortuna della letteratura risieda nella sua possibilità di permetterci di comunicare attraverso quel che ci separa. Essa è – nel caso della letteratura autentica – un modo per superare la separazione affermandola”. “Ecco il miracolo della letteratura: una verità altra diventa mia senza smettere di essere altra. Abdico al mio «io» in favore di chi parla, e ciononostante resto me stessa”. Questo perché “il linguaggio ci reintegra nella comunità umana”, e perché aveva ragione Proust quando affermava che “la letteratura è il luogo privilegiato dell’intersoggettività”.