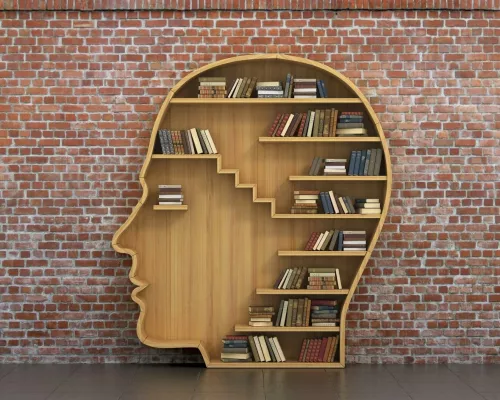Testi letterari / La letteratura: se iniziassimo davvero a studiarla?
Sappiamo tutti che cos’è la letteratura: più o meno, naturalmente. Lo sappiamo nel senso che siamo in grado di riconoscere un’opera letteraria distinguendola da opere che appartengono alla filosofia, alla storia, alle scienze naturali. Anche se negli ultimi decenni alcuni studiosi (come Derrida) hanno enfatizzato una certa labilità dei confini, nella stragrande maggioranza dei casi non abbiamo dubbi: e persino nei casi più ambigui, tendiamo a risolverli considerando il Simposio di Platone o lo Zarathustra di Nietzsche come opere filosofiche, e Il dialogo dei massimi sistemi come un’opera scientifica benché gli autori che sto menzionando siano, indiscutibilmente, anche grandi scrittori.
Ogni lettore ha incontrato sin dalla sua adolescenza qualche testo con cui ha stabilito immediatamente una forte sintonia: ci sono studenti che nel resto della loro vita non leggeranno quasi nessuno dei classici, ma che hanno vissuto un’esperienza estetica – e lo riconoscerebbero senza esitazioni – grazie ad alcune poesie di Leopardi o al Ritratto di Dorian Gray. Dunque la letteratura è accessibile a tutti?
Apparentemente sì. Ma riflettiamo meglio: per la maggioranza delle persone, anche colte, la letteratura è una porta stretta (o una stanza quasi vuota). Chi si è entusiasmato per Leopardi o per Wilde rinuncia disinvoltamente a leggere Proust e Musil, Rilke e Valéry. Per ogni testo che ha rappresentato un incontro felice ce ne sono dieci che si presentano irti di ostacoli: il lessico, la diversa visione del mondo, e soprattutto una complessità con cui i lettori non riescono a fare i conti. Ne derivano frustrazione, noia, abbandono. Com’è noto, alcuni classici della nostra lingua sono stati “tradotti” nell’italiano contemporaneo; ciò non è sufficiente però a renderli davvero contemporanei, nel senso di offrire un’esperienza emotiva e intellettuale attraente.
Siamo dunque di fronte a un paradosso: la letteratura è facile e difficile, accessibile in linea di principio a tutti, ma di fatto quasi inaccessibile per quanto riguarda molti testi. Concretamente: quanti studenti universitari sono in grado di leggere, provando piacere, il Tristram Shandy o Jacques le fataliste, l’Ulisse o La montagna incantata? È già improbabile che si entusiasmino realmente per Il rosso e il nero o per Moby Dick. Queste difficoltà ingigantiscono quando i classici vengono proposti a un pubblico più ampio, e meno “preparato”.
Vengo al secondo punto della mia riflessione: l’educazione alla lettura. Ancora una volta, non si tratta per nulla di qualcosa di semplice. I testi letterari sono oggetti multilaterali e difficili da afferrare: occorrono diverse prospettive per ciascuno di essi. Si può insegnare matematica, chimica: ma si può “insegnare letteratura”? Questa espressione appare bizzarra, se la si esamina con po’ di attenzione. Ciò che un insegnante di lettere può fare è creare le condizioni perché sia possibile un’esperienza estetica. Non la può imporre, ma la può favorire. In che modo?
Anzitutto, non producendo nuovi ostacoli! Non allontanando i suoi studenti da quella che è l’unica realtà della letteratura, e cioè i testi. Sto dicendo delle ovvietà? Temo di no, purtroppo. La letteratura è fatta di testi, e non di contesti: su quest’affermazione si potrà concordare. Perché, allora, gli studi letterari, in ambito universitario come nell’insegnamento scolastico, privilegiano i contesti? È accaduto così nel passato, quando si cercava il significato di un’opera nella vita dell’autore, nelle sue intenzioni dichiarate, nei rapporti di classe e nella politica; ed è così negli ultimi decenni, con il diffondersi dei cultural studies, quando si è cercato il significato dell’opera anche sul versante sessuale e razziale, e quando nell’intentio auctoris si sono voluti scorgere i pregiudizi ideologici.
Gli esiti più ignobili a cui è giunta la critica militante di impostazione “culturale” sono abbastanza noti: mi limito a ricordare le accuse di complicità con l’imperialismo rivolte a Conrad per Cuore di tenebra. Come è stato possibile che queste degenerazioni trovassero spazio? Solamente per i sensi di colpi dell’Occidente o per un' arretratezza teorica permanente, ostinata?
Veniamo alla domanda più difficile, ma non aggirabile. Ho detto che la letteratura è fatta di testi; ma che cos’è un testo? Lo sappiamo veramente? Ci sono stati veri progressi nella conoscenze di “come funziona” un testo letterario?
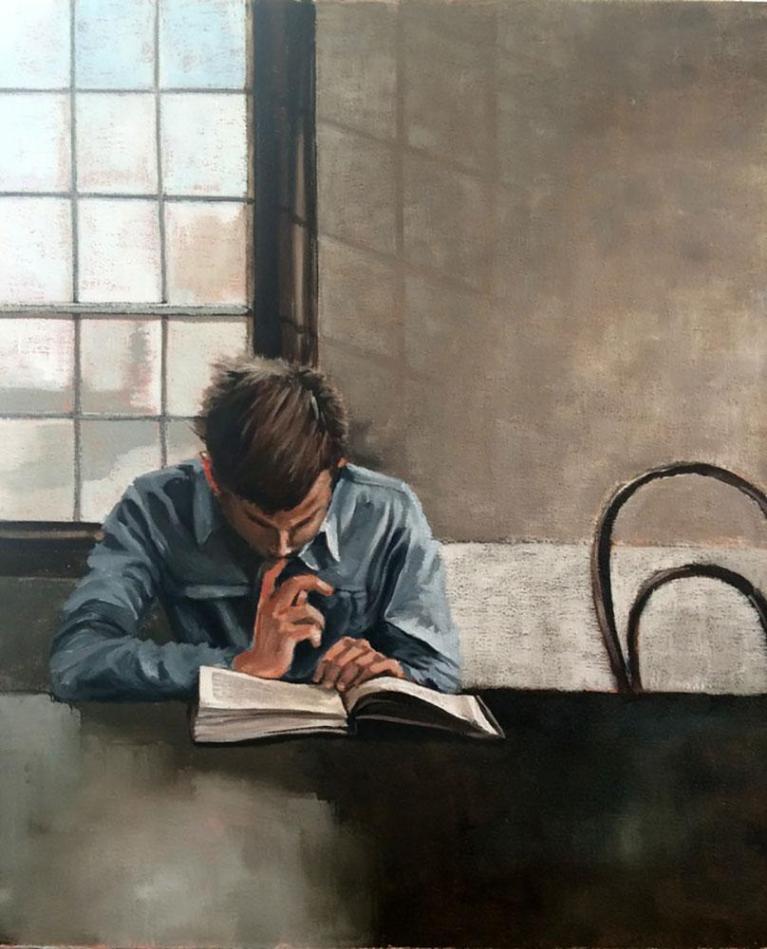
Mila Posthumus, The Reader, oil on stretched canvas, 2015. Private Collection.
Ritengo di poter rispondere in maniera non enfatica, ma sufficientemente decisa e sicura. La letteratura (così come l’arte in generale) è un’attività di cui abbiamo una comprensione parziale, e di cui probabilmente non chiariremo mai tutti misteri (soprattutto per ciò che concerne la creatività). Ma nel corso del XX secolo abbiamo compiuto alcuni progressi irrinunciabili. Abbiamo compreso che un testo non è una grandezza statica, bensì una grandezza dinamica: nasce dalla combinazione tra un artefatto e un oggetto virtuale. L’artefatto è l’opera così com’è (come la conosciamo attraverso la determinazione filologica): per esempio nessuno mette in discussione che la Commedia inizi con “Nel mezzo del cammin di nostra vita”; con oggetto virtuale si intende l’insieme delle possibili interpretazioni, che espandono il testo, gli permettono di non restare imprigionato nel contesto di origine, e lo fanno entrare in quello che Bachtin ha chiamato “il tempo grande”.
I testi letterari sono paragonabili a macchine che viaggiano attraverso le epoche, e che aumentano la loro forza e la loro complessità tramite questo viaggio. Attenzione, però: parliamo di virtualità anche perché non è mai scontato che un testo possa venir attualizzato (ancor prima di essere interpretato). Ogni nuova generazione deve riaccendere il motore che nella transizione epocale si è spento o rischia di spegnersi.
Questa è la responsabilità dell’istituzione universitaria e più in generale della scuola.
L’Università è all’altezza di questo compito? No, se non in misura assai limitata. L’Università ha sempre preferito i contesti ai testi: vale a dire che ha trattato quelle grandezze dinamiche che sono le opere letterarie come se fossero grandezze statiche, e ha favorito il dominio di una distorsione punitiva nei confronti della letteratura che possiamo chiamare contestualismo.
Vorrei prevenire gli equivoci. Non sto affermando che sia inutile occuparsi del contesto: non sto dimenticando che un’opera è anzitutto un artefatto, e ovviamente non nego che per la comprensione dell’artefatto sia necessario il contributo dei filologi, degli storici della lingua, ecc. L’errore devastante del contestualismo consiste nel voler ridurre un testo all’artefatto, negando la sua dimensione virtuale, la sua capacità di espandersi dinamicamente. Il contestualismo è una concezione pseudo-esplicativa e sostanzialmente punitiva nei confronti della letteratura. Dovremmo esprimerci in termini più forti: il contestualismo uccide la letteratura.
Questa è la mia diagnosi per quanto riguarda la decadenza degli studi letterari: sia chiaro che si tratta di una diagnosi “interna” all’istituzione universitaria, e che non considera altri fattori. Non perché non siano importanti, ma perché rischiano di costituire un alibi per le lacune e le devastazioni prodotte nel nostro campo di studi da chi crede di occuparsi di letteratura, e sembra non rendersi conto di quanto misera sia la prospettiva storico-culturale (vecchia e nuova) in quanto vorrebbe negare quella teorica e interpretativa. Eppure, se la nostra visione della letteratura è cambiata da un secolo a questa parte, lo si deve alla teoria della letteratura oltre che a quella dell’interpretazione.
Certamente, la teoria ha una storia che in questo momento non posso neanche tentare di riassumere. Ma c’è almeno un punto di grande importanza che va chiarito. La teoria è nata con alcune ambizioni “positivistiche”, come progetto di una scienza della letteratura: e la scienza è ricerca di leggi. Quasi sicuramente non esistono leggi nella letteratura, dunque quest’ipotesi va abbandonata. Non va abbandonata però l’attenzione al linguaggio letterario, creata dai teorici: se l’Occidente si è finalmente accorto, a metà del ventesimo secolo, che i testi letterari sono “oggetti-di-linguaggio”, e che tale linguaggio è incredibilmente complesso e fascinoso, ciò è avvenuto a partire da una rivoluzione iniziata con i Formalisti russi e proseguita con lo strutturalismo. Questa nuova attenzione al linguaggio produsse per un po’ di tempo una sorta di effetto paralizzante; ipnotizzati da un linguaggio che nessuno aveva mai studiato seriamente prima (con l’eccezione troppo parziale della stilistica, Spitzer, Auerbach, ecc.), quegli studiosi proposero un’estetica inadeguata: sostennero che la letteratura è un linguaggio intransitivo, cioè chiuso in se stesso e ammirevole per la sua costruzione, non per i rinvii ad alcuna situazione storica o sociale.
Un critico, peraltro raffinatissimo, come Stefano Agosti esaltò i giochi del significante nella poesia sino a suggerire che la bellezza di una celebre poesia di Leopardi dipendeva da rapporti anagrammatici come quello tra “Silvia” e “salivi”. Su ciò non possiamo essere d’accordo. L’estetica intransitiva è cosa del passato. Oggi la letteratura è tornata a essere, per molti di noi, una forma di conoscenza.
“April is the cruellest month” (The Waste Land) è una proposizione vera? Ma se lo è, se aspira ad esserlo (Eliot non dice “secondo me, aprile è il più crudele dei mesi”), non lo è nel medesimo senso in cui possiamo attribuire verità a proposizioni come “la neve è bianca” o “il gatto è sul tappeto”. Quali sono dunque le verità della letteratura? È uno dei grandi problemi di cui si occupa la teoria, insieme alla filosofia, e a cui contribuiscono le intuizioni dei grandi scrittori così come quelle della critica letteraria più creativa (che esiste e continuerà a esistere).
La letteratura offre conoscenze sull’humaine condition (Montaigne) e dunque sul cuore umano. Ma non si evochino le emozioni contro l’intelligenza, quasi che delle emozioni si possa parlare solo emotivamente – molto peggio! tramite stereotipi emotivi. Al tradizionalismo dell’anti-teoria, che sovente accusa l’intelligenza di essere arida (penso all’articolo di Berardinelli su “Il sole 24 ore” di qualche settimana fa), e vorrebbe un approccio “spontaneo” all’opera letteraria, possiamo opporre l’obiezione che troviamo in Manzoni, nella scena dei Promessi sposi in cui fra Cristoforo sta per accomiatarsi da Agnese, Renzo e Lucia. Queste le sue parole: “Il cuor mi dice che ci rivedremo presto”. Commenta l’autore: “Certo, il cuore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che accadrà. Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto”. Ascoltiamo il cuore, ma con prudenza (che sa il cuore? Appena un poco), lasciamoci guidare dalle emozioni, purché non siano usate per nascondere idee invecchiate, forme di critica desueta, abitudini intellettuali e pregiudizi che, a ben vedere, ci impediscono di accedere anche alla dimensione passionale dei testi.