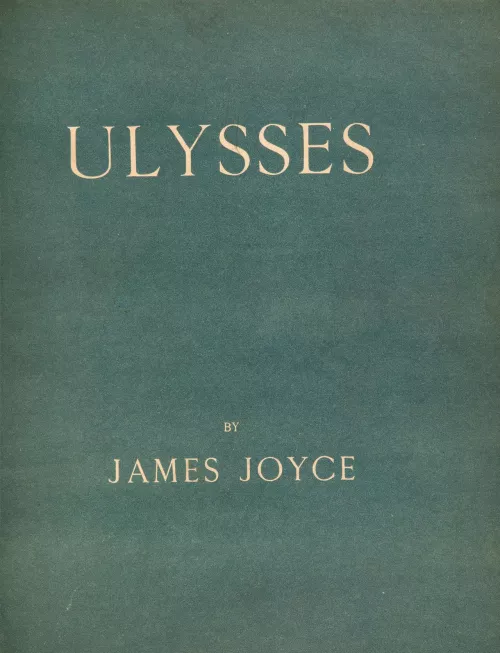2 febbraio 1922-2 febbraio 2022 - I PARTE / Le tribolazioni dell’Ulisse
Nell’estate del 2012, mentre sta portando a termine la traduzione dell’Ulisse di James Joyce per conto della casa editrice Einaudi, Gianni Celati pubblica sul supplemento domenicale del “Sole-24 Ore” una sorta di resoconto a puntate sugli anni trascorsi a combattere con “il disordine delle parole” del romanzo, che uscirà nel marzo 2013. Sei di quelle sette puntate – con l’ultima, la più lunga, spostata all’inizio a mo’ di introduzione – sono in seguito state ristampate sul n. 40 di “Riga” (Quodlibet, 2019) dedicato a Celati. In occasione del centenario della pubblicazione del capolavoro joyciano, avvenuta appunto il 2 febbraio 1922, abbiamo deciso di riproporle senza modifiche, per ricordare Gianni Celati e rendere omaggio al suo lavoro di traduttore.
Un anno a Zurigo, sulle tracce di Joyce, avanzando a fatica tra linee narrative che si accavallano (9 settembre)
Zurigo. Primavera 2009. Regola per tradurre l’Ulisse di Joyce, nei giorni in cui non faccio lezione. Alzarmi alla mattina ore 5 e tirare a lavorare fino alle 5 di sera. Poi fare la spesa nel negozio vicino a casa, e scendere in camminata verso il lungofiume, oppure risalire l’erta collinare della zona dove abito, chiamata Zürichberg. Qui salendo per mezz’ora arrivo al cimitero dove c’è la tomba di Joyce, non lontano dallo zoo dove sono messi in mostra animali di varie provenienze.
La tomba è una semplice lapide rasoterra, contornata da un cespuglio, e dietro il cespuglio sorge una statua di bronzo con i tratti del nostro autore. Corpo magro e dinoccolato, accartocciato su se stesso in un rilassamento pensoso, con gambe accavallate, mento appoggiato a una mano con sigaretta tra due dita, Joyce guarda verso il cespuglio alla sua destra. Si direbbe un uomo snodabile che sta pensando a una acrobazia da compiere, mentre arrivano dei visitatori a rendergli omaggio come grande acrobata letterario, dopo aver visitato lo zoo dietro l’angolo.
Mi pare che l’idea dell’acrobata letterario si adatti bene al personaggio raffigurato in quella statua, perché Joyce è come uno che ha volato da un trapezio all’altro in cima a un tendone, come l’artista del trapezio in un racconto di Kafka (Trapezkünstler [Erstes Leid, in italiano Primo dolore], 1924). Il che mi fa tornare in mente una passione molto diffusa tra letterati e artisti nella Parigi fin de siècle: la passione per l’acrobata da circo, che si alza in voli iperbolici da un trapezio all’altro, al di sopra del prosaico mondo dei borghesi e bottegai. Joyce è arrivato a Parigi nel 1902, e qualcosa gli è rimasto di quel modo per sorvolare la prosa del mondo, facendo voli del pensiero che portano a invenzioni fuori ordinanza. Così succede in gran parte degli episodi nell’Ulisse, dove ci si perde per l’accavallarsi di linee narrative, senza spiegazioni, per cui tutto deve essere intuito da minimi cenni. Per questo molto spesso il lettore si confonde, e stanco mette il libro da parte, ricordando soprattutto quegli inspiegabili voli della mente. Allora i lettori come lui (che non disprezzano i borghesi e i bottegai, anche perché adesso ci sono i supermercati, senza bisogno di voli del pensiero), se capita l’occasione turistica, dopo una visita allo zoo, vanno a vedere la tomba di Joyce, molto sobria e accattivante.

Nell’anno passato a Zurigo abitavo nella parte collinare che ho detto. È una zona di grandi ricchi, densa di psicoterapeuti, con belle ville d’altri tempi. La strada dove abitavo si chiama Hochstrasse, e appena fuori, a sinistra, percorrendo cinquecento passi si arriva alla Universitätsstrasse. Qui c’è un palazzone con una stele a caratteri latini, dove si legge che J.J. ha abitato lì etc. Quella stele municipale mi fa pensare a un gesto umanistico, per onorare un rifugiato straniero (Joyce qui rifugiato a causa della Prima guerra mondiale), come ai tempi della riforma protestante guidata da Zwingli. La sua tomba è spesso pubblicizzata nei dépliant turistici, con riassunto della sua carriera in un’ottima guida come Lonely Planet. Negli ultimi decenni però la quantità di richiami ai soggiorni zurighesi di Joyce ha fatto di lui un nome famosissimo, con tutte le informazioni che ci vogliono per eleggerlo a figura locale; figura che contribuisce a rendere Zurigo una rinomata città dell’arte e della cultura.
Così la grande saggezza svizzera ha appaiato il nome d’uno scrittore molto difficile da leggere all’industria turistica dove tutto deve essere facile da digerire. Questo però non aiuta i lettori a orientarsi nel joyciano disordine delle parole, generato da continue deviazioni narrative e bizzarre divagazioni del pensiero; argomento su cui riflettere.
Durante la mia permanenza, molta gente mi ha suggerito di rivolgermi a Fritz Senn, per risolvere certi miei problemi nel tradurre l’Ulisse. Fritz Senn è una straordinaria figura di critico non-accademico, studioso di Joyce da tutta una vita, fondatore della Zürich James Joyce Foundation, il quale offre al pubblico “un allegro sapere, che non ricorre a note a piè di pagina o residui dell’apparato accademico”. Sono parole che vengono incontro a miei desideri in materia joyciana, ma a pensarci mi pare ci sia un intoppo. Se questo allegro sapere funzionasse, sarebbe come imparare la ricetta d’un cibo meraviglioso, però così eccitante che la legge stabilirebbe non possa essere degustato se non dopo un lungo digiuno; digiuno lungo come quello di antichi santi nel deserto.

Zurigo, verso l’autunno. La traduzione di Joyce procede faticosamente. Ho l’idea di non riuscire a cavarmela, anche se andassi a chiedere aiuto a Fritz Senn. Pochi giorni fa nella mia strada di Hochstrasse, qualcuno ha scritto su un muro a grandi spennellate Komsum tötes Empathie. “Il consumo uccide l’empatia”. Mi colpisce il confronto tra quelle due azioni. Il consumo di parole, il consumo di soldi, il consumo di cibo, il consumo di tutto. Il consumo dell’Ulisse di Joyce: che senso ha questa frase? Mi viene in mente l’immagine di folle che hanno comprato una nuova traduzione dell’Ulisse (poniamo la mia), e se la portano a casa tenendola stretta sottobraccio. Poi cosa succede? Vedo che gran parte delle stesse folle poco a poco mettono via il libro, ne prendono un altro, un poliziesco, e si mettono a leggerlo soddisfatti. C’è stato consumo in questo caso? Sì e no, perché da una parte il venditore ci ha guadagnato, dall’altra è come se il lettore non avesse comperato niente, e avesse buttato via dei soldi, poi pensando che l’Ulisse sia un imbroglio.
In qualche modo questo è vero, perché il venditore propone un libro di grande prestigio, ma senza avvertire i clienti che molti non riescono a leggerlo. Ossia: come si fa con i medicinali, bisognerebbe avvertire il cliente che quel libro è digeribile o no, secondo gli umori e le curiosità e i gusti. Ma il venditore non può farlo perché questo abbasserebbe le quote di vendita, e allora quel libro sarebbe subito in perdita. Forse ci sarebbero venditori che con qualche sforzo accetterebbero la proposta di avvertire i clienti etc. Ma, siccome noi viviamo in una società con la regola della competizione (il che vuol dire prevalere sugli altri), tutte le possibili soluzioni per vendere quel libro più degli altri sarebbero messe in gioco, e inevitabilmente prevarrebbe chi ha meno scrupoli degli altri. In tutto questo l’idea di consumo rimarrebbe un po’ ambigua, e per metterla in luce chiaramente bisognerebbe poter vendere soltanto libri garantiti.
Veniamo all’altro termine, “empatia”. Il dizionario Zanichelli lo dà come voce dotta, dal greco empàtheia (“passione”), derivata da pathos (“affetto”). Dunque posso riformulare la frase scritta sul muro così: il consumo uccide o soffoca qualcosa per cui abbiamo affetto o una passione o un amore. Di cosa si tratta? Si può dire subito che le cose per cui abbiamo affetto sono generalmente quelle che hanno fatto parte della nostra vita, oppure l’ambiente in cui siamo cresciuti. Ma questo affetto può anche essere qualcosa che si sviluppa in me lavorando o imparando una pratica che non sapevo e che è diventata per me importante. Questo è il caso dell’Ulisse di Joyce: non c’è niente che io mi aspetti dal lavoro di traduzione che sto facendo; non guadagnerò abbastanza soldi per mantenermi neanche un terzo degli anni di lavoro previsti; ma non sento di essere defraudato, perché quello che sto facendo è come una mania o come un amore o come uno di quei sacrifici a cui si dedicavano i santi d’un tempo. E questa mi sembra l’unica conclusione a cui riesco ad arrivare. Il resto è oscuro. Ne parlerò un’altra volta.

Stephen, bardo in miseria (5 agosto)
Nell’Odissea, su uno sfondo di popolazioni e divinità e figure mitiche, emergono tre personaggi centrali: Ulisse, suo figlio Telemaco e sua moglie Penelope. Nell’Ulisse di Joyce troviamo gli stessi ruoli in tre figure centrali: Bloom (figura del padre), Stephen Dedalus (figura del figlio) e Molly (figura della moglie). E come all’inizio dell’Odissea Telemaco parte in cerca del padre, così cominciando dal primo episodio del romanzo joyciano il giovane Stephen inizia una peregrinazione che lo porterà a incontrare il paterno Mr Bloom. La terza figura, Molly, sposa di Bloom, è la moglie insoddisfatta, una specie di Penelope ribaltata, che in una fantasia notturna piena di oscenità amorose alla fine ci guida verso un’insolita apertura alla vita. Quanto a Stephen, è un ritratto di Joyce nei suoi anni giovanili, che dopo essere stato allevato dai gesuiti si ritrova in un’Irlanda soffocata dalla chiesa cattolica e dal dominio britannico. Giovane dandy, bizzarro e coltissimo, ma anche randagio e miserando, Stephen ha trovato rifugio in una delle antiche torri sulla costa sud-est di Dublino, assieme a uno studente di medicina, Buck Mulligan. Lui riassume vari aspetti delle mode culturali d’epoca, come il neo-paganesimo ellenizzante, qui associato a una vaga nozione di super-uomo “iperboreo” (termine usato da Nietzsche in L’Anticristo, per indicare l’individuo uscito dal gregge).
Caratteristico è l’inizio del romanzo, dove Buck Mulligan mette in scena un’acida parodia della messa cattolica. E subito vediamo un contrasto tra Buck e Stephen: perché Stephen è una figura dolente, con le stigmate d’una situazione critica della cultura irlandese, mentre l’altro non fa che smerciare frasi da nichilista ridanciano, oppure richiami a un irlandesismo sbocciato alla fine del secolo precedente. Così, quando Mulligan si fa la barba guardandosi in uno specchietto scheggiato, e racconta di averlo rubato a una serva, Stephen risponde con un’immagine dolente: “Quello è il simbolo dell’arte irlandese. Lo specchio sbrecciato d’una serva”.
L’altro aspetto che in questo episodio riassume la situazione d’epoca è la presenza di Haines, visitatore britannico (che Mulligan spregiativamente chiama “sassone”) in cerca di reperti folklorici della cultura irlandese. Ed è questa sua passione turistica per un passato irlandese in un’epoca di sudditanza all’impero britannico, a fare di Haines una figura emblematica. Più avanti Stephen, in un cupo malumore, gli dirà: “Io sono il servo di due padroni, uno inglese e uno italiano. Lo Stato Imperiale Britannico e la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana”. Queste sono le colonne d’una soffocante egemonia sull’Irlanda, intorno all’anno in cui si svolge il grande romanzo di Joyce, il 1904.